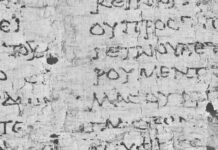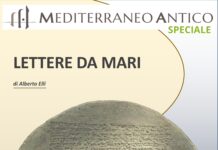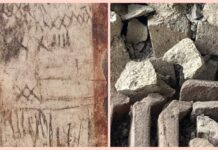Nel 1922, in occasione di scavi per la costruzione di un’abitazione nell’area urbana di Santa Maria Capua Vetere (CE), venne alla luce uno dei Mitrei meglio conservati al mondo: l’oblio ultracentenario del luogo restituiva intatta una nuova, preziosa testimonianza dell’antica religione misterica di origine orientale.
Ad oggi, a Roma e nelle principali città del suo vasto impero, si contano numerosi edifici, spesso ipogei, adibiti al culto di Mitra, ma solo un’esigua parte risulta visitabile o ben conservata: in quest’ottica l’evidenza capuana risulta ancora più straordinaria.
Ma facciamo un passo indietro.
 A partire dal vasto rimescolamento di popoli e culture avvenuto con le conquiste di Alessandro Magno – prima – e con l’espansione dell’impero romano poi, sul piano religioso, accanto alla religione di stato, si affermarono nuove tendenze. Tra queste, la venerazione del dio Mitra, che si diffuse nell’area del Mediterraneo orientale intorno al II-I secolo a.C. per poi trovare slancio, a partire dalla seconda metà del I secolo d.C., fino e oltre i confini dell’impero romano.
A partire dal vasto rimescolamento di popoli e culture avvenuto con le conquiste di Alessandro Magno – prima – e con l’espansione dell’impero romano poi, sul piano religioso, accanto alla religione di stato, si affermarono nuove tendenze. Tra queste, la venerazione del dio Mitra, che si diffuse nell’area del Mediterraneo orientale intorno al II-I secolo a.C. per poi trovare slancio, a partire dalla seconda metà del I secolo d.C., fino e oltre i confini dell’impero romano.
Come altre dottrine religiose, il mitraismo visse inizialmente al margine della religione ufficiale, praticato da pochi adepti, spesso riuniti in confraternite; in seguito, si diffuse in maniera capillare.
A partire dal mondo militare romano, che fu il principale veicolo di diffusione del culto, esso fu abbracciato da commercianti, burocrati e funzionari di governo, fino a trovare il favore di alcuni imperatori romani del III secolo d.C. (per il particolare sostegno che esso offriva alla natura divina dei monarchi). Tra questi, Commodo, a proposito del quale F. Cumont, grande studioso della dottrina mitraica, sostiene che “fu ammesso tra i loro adepti e partecipò alle loro cerimonie segrete, e la scoperta di numerose iscrizioni votive, per il benessere di questo principe o con la data del suo regno, ci fornisce alcuni indizi dello slancio che questa conversione imperiale impartì alla propaganda mitraica”.
Oltre al fattore di autorità e vittoria che la dottrina offriva alla casa imperiale, la chiave del successo del culto sta nel fatto che esso proponeva una fede diversa, non più una questione di stirpe o nazionalità, bensì una scelta personale. Una religiosità alternativa, escatologica, che permetteva all’anima dell’iniziato di passare attraverso sette livelli di iniziazione per arrivare alla salvezza.
Per conoscere di più del dio Mitra, dobbiamo accontentarci di fonti indirette, perlopiù invettive cristiane contro i riti mitraici; molto più ricco e articolato è, invece, il patrimonio iconografico di cui disponiamo attraverso le decorazioni dei mitrei ad oggi noti.
Nella maggior parte degli apparati scultorei e parietali dei mitrei, lo si vede nascere già fanciullo da una roccia, recante nelle mani una daga ed una fiaccola, con il corpo nudo e un berretto frigio sul capo, come nella statua dal mitreo di S. Stefano Rotondo a Roma oggi al Museo Nazionale Romano; i testi infatti lo definiscono “nato dalla pietra”.
I simboli citati prospettano precisi rimandi alla teologia mitraica: la torcia rappresenta la luce che egli porta nel mondo con la sua nascita, la daga è lo strumento attraverso il quale viene eseguito il sacrificio del toro, mentre il berretto frigio contribuisce a connotarlo immediatamente come un personaggio di origine orientale.
Nelle fonti è poi chiamato “invitto” e “tauroctono” ed è, infatti, comunemente rappresentato intento ad uccidere un toro all’interno di un antro cavernoso.
Mitra avrebbe inoltre affrontato il dio Sole, sconfiggendolo e ricevendo la corona raggiata come pegno dell’alleanza stipulata: su un bassorilievo romano del II-III secolo a.C., oggi al Louvre, il dio celebra la vittoria banchettando con il Sole, ora suo alleato, al cospetto di due dadophoroi e della Luna.
 L’iconografia più comune resta quella della tauroctonia, dove compaiono, accanto al dio, un cane, uno scorpione, un serpente, il sole, la luna, simboli degli dei planetari e dei segni zodiacali, che danno un valore cosmico all’episodio e lo qualificano come avvenimento che ha dato avvio alle condizioni esistenziali. A completare, quasi sempre, il repertorio decorativo dei mitrei vi sono volte stellate, come nel caso del Mitreo di Capua. Qui, a partire da un criptoportico con funzione di vestibolo, si accede alla sala del culto: un ambiente rettangolare coperto da volta a botte e pavimentato in cocciopesto con crustae marmoree. Se il tipo di struttura voltata ricorda intenzionalmente la caverna sacra dove Mitra ebbe i natali, l’altare sul fondo della parete, munito di canaletta e rivestito di stucco rosso, così come le vasche e pozzetti che corrono lungo i muri laterali, sono da attribuirsi alle abluzioni purificatrici praticate durante i riti mitraici.
L’iconografia più comune resta quella della tauroctonia, dove compaiono, accanto al dio, un cane, uno scorpione, un serpente, il sole, la luna, simboli degli dei planetari e dei segni zodiacali, che danno un valore cosmico all’episodio e lo qualificano come avvenimento che ha dato avvio alle condizioni esistenziali. A completare, quasi sempre, il repertorio decorativo dei mitrei vi sono volte stellate, come nel caso del Mitreo di Capua. Qui, a partire da un criptoportico con funzione di vestibolo, si accede alla sala del culto: un ambiente rettangolare coperto da volta a botte e pavimentato in cocciopesto con crustae marmoree. Se il tipo di struttura voltata ricorda intenzionalmente la caverna sacra dove Mitra ebbe i natali, l’altare sul fondo della parete, munito di canaletta e rivestito di stucco rosso, così come le vasche e pozzetti che corrono lungo i muri laterali, sono da attribuirsi alle abluzioni purificatrici praticate durante i riti mitraici.
Sulla parete di fondo del Mitreo è rappresentata la più nota impresa del dio: a cavallo del toro, Mitra affonda un coltello alla base del collo dell’animale, tenendolo fermo per le narici con la mano sinistra. Il dio, giovane, con il viso sbarbato e la chioma riccioluta, indossa il consueto costume orientale i cui ricchissimi colori contrastano con il candore dell’animale: la tunica rossa con polsini verdi, le anassiridi (pantaloni dalla foggia persiana), il mantello, rosso all’esterno e azzurro con stelle d’oro all’interno (a richiamare la volta celeste), il berretto frigio di colore rosso con decorazioni in verde e oro.
Intorno alla vittima taurina, un cane lecca il sangue che scorga dalla ferita, uno scorpione ne punge i testicoli, infine un serpente striscia sotto i suoi piedi per raccoglierne il sangue che cola.
Ma la lunetta affrescata non si esaurisce intorno al duo Mitra-toro: ai lati del gruppo centrale sono dipinti due dadophoroi, anch’essi in costume frigio, armati di arco e frecce. Essi sono Cautes, con la fiaccola sollevata, simbolo del Sol levante, e Cautopates, con la fiaccola abbassata, simboleggiante il tramonto. A incorniciare l’arco della grotta, si individuano in basso le teste di Oceano e Terra, in alto i busti del Sole e della Luna, simboli della dimensione cosmica e al tempo stesso terrena dell’evento.
L’occhio più attento scorgerà altri cicli pittorici, più o meno conservati, che decorano la sala: la Luna sulla biga, altri dadophoroi in costume orientale, scene di iniziazione degli adepti.
La cronologia del complesso è da porsi alla fine del II secolo d.C. mentre risulta meno agevole definire il momento di abbandono dell’edificio sacro: più importante è sottolineare la rilevanza della sua presenza a Capua. Fin dall’età preromana essa fu tra le più importanti e fiorenti città del mondo prima italico e poi romano, dominando un territorio estremamente ricco per lo sfruttamento agricolo e per il commercio, l’ager Campanus. Frequentata da aristocratici, alti funzionari, militari e commercianti, Capua fu crocevia di civiltà, provenienze, lingue, religioni diverse. Non stupisce, dunque, che uno dei culti più diffusi nell’epoca medio e tardo imperiale, che costituirà una minaccia per il Cristianesimo, abbia trovato fortuna nell’altera Roma.
Informazioni:
Aperto su richiesta dal martedì alla domenica (h. 09.00 – 19.00), rivolgersi al personale del Museo Archeologico dell’Antica Capua. Info: 0823/844206; 0823/798864.
Biglietto intero € 2.50 cumulativo per accedere ai 4 siti del circuito Antica Capua (Museo Archeologico dell’Antica Capua, Anfiteatro Campano, Museo dei Gladiatori e Mitreo).
Ridotto € 1.25 per i cittadini dell’UE tra i 18 e 25 anni non compiuti.
Gratuito per i cittadini dell’UE sotto i 18.
Bibliografia
S.De Caro, “La terra nera degli antichi campani. Guida archeologica della provincia di Caserta”, Napoli 2012
M.J. Vermaseren, “Mithriaca, 1. The Mithraeum at S. Maria Capua Vetere”, Leiden 1971
F.Cumont, “Le mysteres de Mithra”, Parigi 1902
R.Iorio, “Mithra. Il mito della forza invincibile”, Venezia 1998
Foto
Ortensio Fabozzi
uff. fotografico (Museo Archeologico dell’ Antica Capua) Santa Maria C.V.
POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA