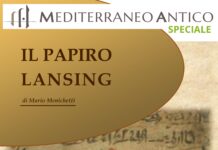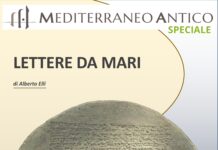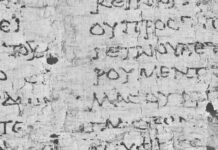Pompei nel corso della sua storia fu difesa da mura che però non sempre garantirono protezione, come avvenne durante l’assedio di Silla che portò alla presa della città e alla riduzione a colonia romana. Già dalle origini, l’abitato si dotò di mura difensive e una cinta in blocchi di pietra fu costruita a partire dal V secolo a.C. La città, in quella fase, non aveva le stesse dimensioni dell’attuale, ma l’espansione urbanistica era notevolmente ridotta. Quando Pompei fu coinvolta nelle guerre sannitiche, nel IV secolo a.C., le mura, ritenute inadeguate a fronteggiare un pericoloso nemico, vennero parzialmente ricostruite, sostituendo ed integrando la cortina esterna con una nuova di maggiore altezza.

I rifacimenti delle mura si inseriscono in un generale riassetto urbanistico di Pompei, che vede, nel IV secolo a.C., una consistente espansione urbanistica sia a nord che ad est del nucleo più antico. L’ultimo sostanziale intervento sulle mura di Pompei risale al periodo della guerra sociale, tra il 90 e l’89 a.C. In questa occasione vennero effettuati numerosi rifacimenti della cortina esterna, danneggiata nelle precedenti vicende storiche e, soprattutto, furono aggiunte al circuito delle fortificazioni una serie di torri di guardia, poste ad intervalli più o meno regolari, a cavallo della cortina. Le nuove opere edilizie furono eseguite in opus incertum, costituite da scaglie di pietra legate con malta, con un paramento irregolare e, pertanto, facilmente riconoscibili dalle fasi edilizie precedenti. Con il consolidarsi dell’autorità di Roma e il venire meno di pericoli esterni, la funzione difensiva delle fortificazioni andò diminuendo d’importanza. La pacificazione dell’Impero, avvenuta sotto Augusto, aveva favorito i commerci, così, gradualmente, le mura acquistarono un valore monumentale e simbolico, urbanistico piuttosto che strategico. Per le nuove esigenze dei traffici le aperture delle porte vennero ampliate, affiancando all’arco di ingresso originario altri varchi: Porta Ercolano venne ricostruita con tre fornici, di cui quello centrale, il più ampio, riservato ai carri, quelli laterali ai pedoni. Verso la fine del I secolo a.C., si assiste ad una progressiva occupazione di alcuni tratti delle mura dove si svilupparono lussuose ville che si estesero su più piani terrazzati, in particolare lungo i pendii occidentali e meridionali del costone lavico, sfruttando la posizione panoramica verso il mare.
 Quando il terremoto del 62 d.C. provocò la distruzione di Porta Vesuvio, non si reputò necessario ricostruirla e così rimase fino all’ eruzione del 79 d.C. Tra i cantieri di scavo presso il Parco archeologico, vi è anche quello presso le antiche mura, nella zona della Torre di Mercurio, condotto dall’Università di Roma Tor Vergata. A raccontare le indagini del suo team, il professor. Marco Fabbri che spiega che la Torre di Mercurio è il luogo più alto del sito di Pompei, dove si può comprendere la posizione strategica della città tra il Vesuvio, il mare e la valle del Sarno, tre elementi naturali che ne determinarono la sua fortuna. L’obiettivo delle indagini è quello di datare le varie fasi edilizie delle fortificazioni e di capire così la storia urbana di Pompei, perché un intervento in antico, fatto su un tratto di mura, veniva fatto da una comunità, da un potere centrale, e solo un’attenta indagine e la conoscenza di ogni intervento permetteranno di ricostruire tasselli importanti per la storia della città.
Quando il terremoto del 62 d.C. provocò la distruzione di Porta Vesuvio, non si reputò necessario ricostruirla e così rimase fino all’ eruzione del 79 d.C. Tra i cantieri di scavo presso il Parco archeologico, vi è anche quello presso le antiche mura, nella zona della Torre di Mercurio, condotto dall’Università di Roma Tor Vergata. A raccontare le indagini del suo team, il professor. Marco Fabbri che spiega che la Torre di Mercurio è il luogo più alto del sito di Pompei, dove si può comprendere la posizione strategica della città tra il Vesuvio, il mare e la valle del Sarno, tre elementi naturali che ne determinarono la sua fortuna. L’obiettivo delle indagini è quello di datare le varie fasi edilizie delle fortificazioni e di capire così la storia urbana di Pompei, perché un intervento in antico, fatto su un tratto di mura, veniva fatto da una comunità, da un potere centrale, e solo un’attenta indagine e la conoscenza di ogni intervento permetteranno di ricostruire tasselli importanti per la storia della città.
 Nell’area delle antiche mura nei pressi della Torre di Mercurio sono stati riaperti due saggi già condotti nel 1927-29 da Amedeo Maiuri, allo scopo di sondare le fasi più antiche della fortificazione della città e il suo impianto urbanistico. Particolarmente interessanti sono le tracce dei solchi delle macchine da guerra utilizzate per difesa durante l’attacco di Silla dell’89 a.C., emerse lungo il camminamento di ronda. Mentre nel luogo dell’altro saggio è venuta alla luce la fondazione della cortina a lastre di calcare di impianto greco.
Nell’area delle antiche mura nei pressi della Torre di Mercurio sono stati riaperti due saggi già condotti nel 1927-29 da Amedeo Maiuri, allo scopo di sondare le fasi più antiche della fortificazione della città e il suo impianto urbanistico. Particolarmente interessanti sono le tracce dei solchi delle macchine da guerra utilizzate per difesa durante l’attacco di Silla dell’89 a.C., emerse lungo il camminamento di ronda. Mentre nel luogo dell’altro saggio è venuta alla luce la fondazione della cortina a lastre di calcare di impianto greco.
Le mura raccontano e lasciano segni indelebili di storia, soprattutto di episodi di guerra. In alcuni tratti di mura, come quello nei pressi di porta Ercolano, si vedono ancora chiaramente i segni dell’assedio dell’esercito romano; la città verrà conquistata e ripopolata dai veterani divenendo Colonia Veneria Cornelia Pompeianorum. Dello stesso conflitto, rimangono altre testimonianze preziose: tre iscrizioni di colore rosso scritte in osco che davano informazioni alle truppe su come muoversi e la costruzione di torri. I movimenti dell’esercito venivano infatti stabiliti in base a punti di riferimento topografici, tra cui la numerazione delle torri fatte costruire in previsione dell’assedio del dittatore e di cui ancora oggi abbiamo testimonianza.
Fonte: Pompeii Parco Archeologico