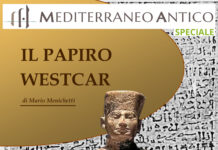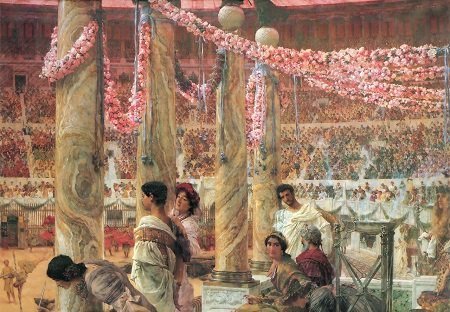L’imperatore Caracalla vittima della congiura di Macrino
Sul piano della politica estera, anche Caracalla non si sottrasse all’idea di organizzare una grande spedizione contro i Parti. Ma durante il viaggio, l’8 aprile 217, venne assassinato a Carre, in Siria, durante una congiura militare, senza di fatto aver pensato mai a nominare un suo successore.
Un abbraccio tra uomini riscrive la storia dei calchi della Casa...
Una notizia assolutamente eccezionale che ci fa capire come dopo più di 2000 anni Pompei ci rivela ancora graditissime sorprese. La notizia è stata data questa mattina dal Soprintendente Massimo Osanna durante un convegno tenutosi nell’Auditorium degli scavi sul Grande Progetto Pompei. Le analisi del DNA e la TAC hanno confermato che i due calchi della Casa del Criptoportico, appartenenti a due persone morte durante l’eruzione e unite nell’ultimo istante prima della morte, in realtà sono due uomini.
I Giardini del Museo Archeologico di Napoli
Giardini, cortili e spazi aperti sono elementi vitali che sbocciano nelle nostre città dando respiro alla struttura a tratti serrata dell’edilizia storica e moderna, divenendo spazi di aggregazione comune. Lo stesso si può dire per i cortili che spesso si aprono nei palazzi storici e nei complessi monastici e conventuali, luoghi privati ma allo stesso tempo spazi in cui condividere momenti di vita comune; questo avviene al MANN (Museo Archeologico Nazionale di Napoli) dove tre grandi spazi aperti impreziosiscono il museo, donando luce alle sale che vi si affacciano.
Ma per capire bene questi luoghi è necessario parlare della loro evoluzione nel corso dei secoli, soprattutto in termini di utilizzo dello spazio. La principale funzione di questi spazi aperti, nell’epoca del loro maggior splendore, era l’esposizione di sculture che vede i suoi precedenti nella storia antica fino ad arrivare al mondo ellenistico-romano. A partire dal Cinquecento fu ripresa la consuetudine di esporre opere in marmo nei giardini di ville e complessi cittadini, in particolare a Roma con il Cortile del Belvedere, Palazzo Chigi (La Farnesina) ed i giardini vaticani, a Firenze con il giardino di Boboli e a seguire con il giardino del Museo Archeologico Nazionale di Firenze di chiara matrice ottocentesca.
La storia della vestale Cossinia
In questa storia di sacerdozio, si cala la figura di Cossinia. Discendente da una nobile famiglia tiburtina, fu destinata al sacerdozio di Vesta a Tivoli, ma terminato il servizio non tornò a casa, restò nel collegio fino agli ultimi giorni della sua vita. Morì infatti all’età di 75 anni e la popolazione le attribuì grandi onori per la sua devozione sincera verso la cura del focolare, tanto che, il suo corpo, fu portato a braccia all’interno della sua dimora eterna. Nel 1929, a Tivoli, fu ritrovato il suo monumento funebre. Un caso assolutamente eccezionale e unico perché fin’ora non si conoscono tombe di vestali. La tomba si presenta come un’ara issata su cinque gradoni di travertino dove accanto fu scoperto un altro complesso funerario simile, sotto il quale venne ritrovato il corpo di una donna inumato in un sarcofago marmoreo.
Nuove aperture a Pompei. Restituite alla fruizione le domus di Sirico...
Giornata ricca di aperture oggi a Pompei. Il Soprintendente Osanna e il Generale Curatoli hanno presentato alla stampa i nuovi lavori del Grande Progetto Pompei che hanno portato alla messa in sicurezza della Regio VII, con la restituzione della viabilità principale di questa e l’apertura di due importanti domus che, nell’attuale suddivisione dell’area, sono situate nella zona che comprende il quartiere del Foro Civile e parte degli isolati abitativi che gravitano all’interno e a ridosso dell’asse viario formato da Vicolo dei Soprastanti – Via degli Augustali – Vicolo del Lupanare.
Il Museo archeologico di Reggio Calabria parla LIS
È passato quasi un anno dalla presentazione a Palazzo Piacentini del progetto: “Il MArRC parla LIS”. Attraverso una videoguida nella Lingua italiana dei segni (LIS) è possibile collegarsi ad un sistema multimediale su diverse piattaforme digitali, così da migliorare la qualità di visita dell’allestimento per gli ipoudenti. Il progetto è stato pensato ed ideato dalla digi.Art Servizi digitali per l’Arte per il #MArRC e prodotto dalla Direzione Generale per le Valorizzazioni del Patrimonio Culturale del MIBACT, nell’ambito della Realizzazione di progetti di sviluppo innovativo nel settore audiovisivo e multimediale – Progetto accessibilità per ipovedenti e sordi, e promossa dalla Soprintendenza Archeologia della Calabria.