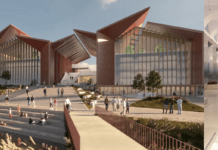La programmazione del Museo Archeologico di Napoli prevedeva queste due mostre in rapida successione.

Il mare evocato da Thalassa si sarebbe dovuto ritirare dalla Sala della Meridiana il 9 marzo, mentre gli Etruschi avrebbero dovuto iniziare il loro racconto 7 giorni dopo, il 16 marzo, un poco oltre quella sala.

Ma qualcosa ha sconvolto la nostra esistenza, modificando ciò che stava accadendo e prendendo forma intorno a noi, solidificando tutto in un’inaspettata glaciazione sociale che ha tolto alle cose il senso del tempo, i ritmi del fare, la cronologia di riferimento. È accaduto così che nell’adeguarsi ai nuovi eventi le due mostre si sono toccate, sovrapposte e – a ben guardare – intrecciate, non solo grazie al fattore tempo.
Arrivare agli Etruschi passando per il mare sembra un fatto naturale: “E presto nella solida nave, apparvero veloci, sul cupo mare, pirati Tirreni: li portava la sorte funesta”, ci dice Omero nell’inno a Dioniso. I Greci chiamavano così gli Etruschi, Tirreni, e così venne chiamato il mare che bagna lo Stivale a occidente, come ci informa Posidonio di Apamea (134-51 a.C.): “Essi nei tempi antichi si impadronirono di molte terre, segnalandosi per coraggio e fondarono molte e importanti città. Parimenti, possedendo una potente flotta ed esercitando il dominio sul mare per lungo tempo, ottennero che il mare che bagna l’Italia prendesse da loro il nome Tirreno”.
Anche i Greci conobbero gli Etruschi attraversando il mare, l’autostrada Mare Nostrum fitta di rotte a doppio senso di circolazione su cui si spostavano beni materiali e immateriali, incontrandoli nella Campania antica. E ad un mito del mare fa riferimento un preziosissimo reperto che da poco tempo ci è stato restituito, perfettamente inserito nel progetto scientifico della mostra Thalassa, ma che sarebbe stato a proprio agio anche all’interno dell’altra mostra, dove gli Etruschi ci raccontano del loro dominio in Campania e del loro rapporto con la Grecia.

Si tratta di un vaso per il trasporto dell’acqua (hydria) a figure nere, datato al 510-500 a.C. e realizzato dal “Pittore di Micali”, dizione con cui si indica il più numeroso gruppo di vasi etruschi a figure nere (circa 200) realizzati dal medesimo pittore o da artigiani della sua bottega e pubblicati – in parte e per la prima volta – dallo storico Giuseppe Micali (Livorno, 19 marzo 1768 – Firenze, 27 marzo 1844).
Questo reperto fu restituito all’Italia dal Toledo Museum of Art (Ohio, USA) nel 2014, grazie al lavoro del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e nel 2019 entrò ufficialmente a far parte delle collezioni del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Il Museo Etrusco è dunque ente prestatore sia per l’esposizione sui tesori sommersi dal Mediterraneo, che per l’esposizione sugli Etruschi in Campania.
Ma il crossover tra le due mostre non si ferma qui. C’è anche l’apparato pittorico dell’hydria che fu commissionata da un ricchissimo uomo etrusco a un artigiano locale probabilmente attivo a Vulci, dove si parla di un mito del mare, un mito omerico che si trova nell’Inno a Dioniso: la metamorfosi dei pirati Tirreni in delfini.
Qui si racconta del rapimento di Dioniso da parte dei pirati Tirreni che lo credono figlio di un re, certi di ricavarne un cospicuo riscatto. Una volta a bordo Dioniso manifesta la sua vera identità avvolgendo l’intera nave con tralci di edera e di vite, tramutandosi poi in un leone. I pirati sconvolti dal prodigio ed atterriti dalla ferocia del grande felino si tuffano in mare e vengono trasformati in delfini.
Il “Pittore di Micali” coglie magistralmente proprio quel momento, la metamórphōsis, mostrando nella sequenza delle figure della metopa centrale, una serie di uomini prossimi a raggiungere i flutti del mare mentre stanno mutando di specie, mostrando assieme parti umane e parti del delfino. Il tralcio di vite nella parte sinistra della scena allude alla presenza di Dioniso, dio del vino e della vite.
Descriviamo le parti (metope) dell’hydria.
Come già detto questo prezioso reperto in ceramica è dipinto a figure nere ed è suddiviso in tre parti (metope), che rispecchiano le tre naturali divisioni della brocca: il collo, la spalla e il corpo.

Sul collo sono rappresentati due uomini nudi di profilo che guardano a destra, impegnati in quello che sembra un passo di danza. Sul collo è invece presente un personaggio mitico somigliante a un tritone, la cui parte superiore è di un uomo con una lunga barba, che tiene stretti tra le mani alcuni pesci, tra i quali un delfino. La parte inferiore è invece resa con una lunga e possente coda munita di pinne che sembrano sostenere il “semidio” sui flutti marini, rappresentati da un fregio ad onde correnti.

Sul corpo del vaso i sei uomini che, alla stregua di un moderno fumetto, raccontano l’attimo in cui si stanno trasformando in delfini poco prima di toccare i flutti marini, anche qua, come sopra, resi con un fregio ad onde correnti.
È proprio quest’ultima la scena più interessante, che ci riporta al mito raccontato nell’Inno omerico, dietro il quale si può leggere in filigrana la contesa tra Greci ed Etruschi per il predominio sul mare e, soprattutto, vista la presenza di Dioniso, sul redditizio commercio marittimo del vino.

Dunque, proprio nella parte finale del percorso espositivo di “Thalassa. Meraviglie sommerse dal Mediterraneo”, troviamo un prezioso reperto che ci accompagna in dissolvenza verso “Gli Etruschi e il MANN”, anticipando e mostrando i contenuti comuni come in un Diagramma di Venn.
Il mare è luogo di suggestione, è strada di comunicazione, è portatore di cose nuove e di cultura. Lo è sempre stato. Attraversare la Sala della Meridiana arredata da Thalassa e scorgere in quell’hydria il senso di ciò che troveremo un poco più avanti, nel prezioso racconto etrusco, dà la sensazione delle onde e la velocità delle vele piene di vento.
Il Mediterraneo non va arginato, va navigato e al Museo Archeologico di Napoli ce lo raccontano i reperti del passato, o per meglio dire, ce lo augurano!