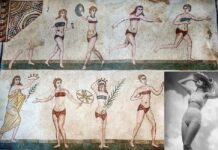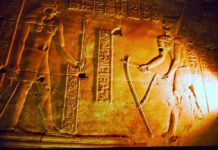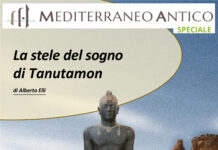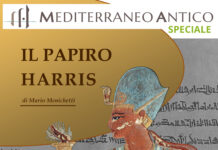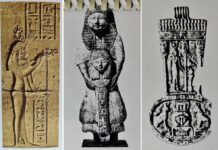Le riflessioni di Flavia Frisone, Professoressa di Storia greca dell’Università del Salento, tra le protagoniste del “XII Festival del giornalismo culturale” di Urbino in programma al Palazzo Ducale dal 4 al 6 ottobre, dedicato allo “Sguardo femminile nel giornalismo culturale”
Il Festival, diretto da Lella Mazzoli, professoressa emerita di Sociologia della Comunicazione all’Università di Urbino “Carlo Bo”, e Giorgio Zanchini, giornalista radiofonico e televisivo della Rai, quest’anno è dedicato alle “Protagoniste”, con particolare attenzione al contributo delle donne nella cultura e nel giornalismo.
In questo contesto, la professoressa Frisone, studiosa di fama internazionale, promotrice del progetto “Alla scuola delle donne”, ci offre un’analisi sul legame tra donne e trasmissione del sapere, dai tempi antichi al mondo moderno.

Professoressa Frisone, il Festival di quest’anno si concentra sullo sguardo femminile nel giornalismo culturale. Come storica del mondo antico, che parallelismi vede tra il ruolo delle donne nella trasmissione del sapere nell’antichità e oggi?
È una domanda molto interessante, che mette in luce aspetti non scontati del parallelo fra presente e mondo antico che da sempre accompagna le nostre riflessioni. Nell’antichità le donne erano frequentemente custodi di conoscenza ma la loro funzione di tramite di questo sapere – spesso un sapere tradizionale che veniva consegnato da una generazione a un’altra – trovava spazio in ambiti che non erano quelli della comunicazione pubblica.

E questo non costituisce una differenza insormontabile?
In parte sì, ma, pur con l’importante differenza “di contesto” a cui facevo riferimento, è interessante osservare che in non pochi casi le donne nell’antichità riuscirono a orientare ciò che era patrimonio comune verso nuove direzioni, o addirittura a riplasmarlo, come accade per la poetessa Saffo. Questa è una prospettiva di analisi sulla quale insisto molto, visto che è proprio al cuore del mio progetto “Alla scuola delle donne”, un’idea nata nel 2016 per creare uno spazio di riflessione sul ruolo femminile nella conoscenza che parte dal mondo antico per guardare a quello moderno.
E che spunti offre, allora, il mondo antico alla presenza femminile nel giornalismo culturale di oggi?
Credo che oggi il ruolo del giornalismo femminile in campo culturale debba trarre ispirazione proprio dalla capacità delle donne antiche di creare e mantenere un proprio sguardo sulla realtà: è possibile rifuggire l’omologazione, le aspettative più ovvie e il racconto mainstream, non per semplice desiderio di originalità ma per una nuova proposta culturale. E questo è particolarmente coraggioso – e importante, oggi che il peso delle donne nel giornalismo è molto cresciuto – se si rivolge all’ascolto e alla rappresentazione delle donne. Pensiamo, ad esempio, a quei temi, a quelle narrazioni, che non trovano luogo, o dignità, nel sapere accreditato da una cultura generalmente declinata al maschile. Temi che invece da sempre sono importanti nella dimensione del femminile. In questo senso le giornaliste di oggi possono guardare alle donne antiche che hanno fatto “scuola”, che hanno aperto prospettive proprie sul sapere.

Il Festival di quest’anno mette in evidenza le donne come protagoniste, e dedica uno spazio specifico al mondo antico. Come può servire il mondo antico per interrogarsi sul significato e sulla portata del protagonismo al femminile?
Direi prima di tutto cercando di andare oltre i luoghi comuni. Guardiamo alle donne dell’antica Grecia, per esempio. Esse indubbiamente vivevano in società profondamente maschiliste. Ciò nonostante, ricoprivano ruoli cruciali: sovrintendenti di attività economiche primarie, custodi dei valori sociali e delle memorie familiari, talvolta raggiungevano i livelli più alti della cultura del loro tempo. Quale spazio è dato a tutto questo nella tradizionale narrazione di una storia centrata su guerre, conquiste, potere? Che importanza era disposto a lasciare alle donne il racconto di questa storia che vorrei definire “al maschile”. Non solo venne meno una narrazione del passato che includesse gli spazi in cui le donne fossero importanti ma le poche figure femminili che si affacciano al racconto della “grande storia” restano schiacciate da una visione stereotipata, spesso deformata da pregiudizi che si sono tramandati ed amplificati nei secoli. La ricerca, soprattutto femminile, negli ultimi decenni ha aperto spazi nuovi nella narrazione storica, lasciando intravedere, per esempio, modelli di resilienza e ambiti di creatività femminile poco riconosciuti o addirittura negati.

Qual è il ruolo del giornalismo culturale nel modificare questa narrativa storica?
In primo luogo, il giornalismo culturale – e in questo sono importanti le donne che raccontano – può contribuire a modificare quella lettura per cliché di cui dicevo. Se dotato di consapevolezza storica non superficiale, poi – e qui inserisco una nota polemica verso rappresentazioni che omologano la storia antica al mito – può aiutare a identificare e sfidare le narrative che perpetuano stereotipi dannosi o giustificano la violenza. La conoscenza storica delle società antiche, infatti, ci insegna a guardare oltre la superficie, a cercare le voci marginali e a considerare molteplici prospettive – tutte competenze essenziali, io credo, per un giornalismo culturale di qualità.

In che modo il suo lavoro di storica dell’antichità si intreccia con le questioni di genere contemporanee?
Il mio lavoro di ricerca mi ha portato a riconoscere che molte delle questioni di genere che affrontiamo oggi hanno radici profonde nel passato. Detta così suona come una banalità ma è la chiave di tutto. La storia, in particolare la storia antica, incontra sempre il presente, e questo è vero anche per la serie molto varia delle problematiche di genere che sono oggi aperte nel dibattito sociale. In particolare, lo è per quanto riguarda la questione dei ruoli e la costruzione del profilo sociale delle donne. Naturalmente ci possono essere più livelli d’approccio. Uno è quello dell’analisi. La storia, l’antichità classica, nel mio caso, ci aiuta a comprendere meglio le strutture di potere, i pregiudizi e le resistenze che ancora oggi influenzano la vita delle donne. Ci mostra lucidamente la genesi delle barriere di genere e che supportano l’esistenza di quel che oggi chiamiamo “tetto di cristallo”, che ferma le donne al di qua di ruoli direttivi apicali. Ci aiuta a demistificare i linguaggi che sono stati funzionali alla costruzione di discriminazioni. Ma, allo stesso tempo, ci testimonia che l’elaborazione di valori, di spunti creativi, di forme organizzative legate all’iniziativa femminile sono una forma costante di resilienza, che può essere una fonte di ispirazione nel presente.

Studiare le donne nell’antichità per comprendere le sfide attuali?
Beh, sì! Studiare le donne nell’antichità non è un esercizio di erudizione o una ricerca fine a sé stessa. Conoscere la loro storia ci aiuta a comprendere meglio le sfide e le opportunità delle donne di oggi, dall’educazione negata in molte parti del mondo alla riconquista femminile di vasti settori del sapere scientifico, dalla disparità nell’accesso alle opportunità alla riconoscibilità e la dignità sociale attribuita al lavoro e al contributo delle donne.

Per concludere, allora, che cosa significa per lei, come storica dell’antichità, essere presente qui?
Certamente è per me motivo di grande soddisfazione essere qui a discutere con le colleghe Valeria Palumbo e Laura Pepe nel panel dedicato alle “Le donne nell’antichità”. Credo che eventi come questo siano importanti per dar luce alle donne che in tutti i campi contribuiscono a raccontare il mondo. Provo a spiegarmi: sono convinta che le donne, oggi, debbano essere rappresentate e percepite non soltanto come oggetto del dibattito sugli enormi problemi ancora aperti ma come promotrici di trasformazioni, come soggetti attivi e qualificati nei diversi campi del sapere. In questa linea, ad esempio, mi sembrano significative iniziative come la banca dati “100 Esperte contro gli stereotipi“, di cui anch’io faccio parte, che è stata creata proprio per offrire un punto di riferimento al femminile al quale attingere per competenze specifiche sia nel campo delle scienze “dure” sia in quello delle scienze umane. Un piccolo ma importante passo per contrastare la desolante sotto-rappresentazione delle donne come fonti autorevoli nel dibattito pubblico, sia scientifico che culturale.
Quale auspicio ha per questo Festival e per il futuro della rappresentazione femminile nei media?
Il mio augurio è che questo Festival possa essere un catalizzatore per un cambiamento duraturo, ispirando più donne a farsi avanti e più media a cercare voci femminili autorevoli. Solo così potremo avere una narrazione del mondo più ricca, sfaccettata e rappresentativa della società nel suo complesso.

MediterraneoAntico è legato alla Prof.ssa Flavia Frisone da un pluriennale rapporto di collaborazione che si è concretizzato in una serie di articoli e interviste di grandissimo interesse. Di seguito i link per accedervi:
Intervista a Flavia Frisone: La storia del Mediterraneo ci insegna ad innovare
Magna Grecia: quel “centro storico” che non finisce mai di raccontare – Intervista a Flavia Frisone
Flavia Frisone in breve
Professoressa ordinaria di “Storia greca” (Università del Salento).
Già Presidente del Corso di Laurea in Beni Culturali e del primo Double Degree Italia -Cina in Beni Culturali (UniSalento-NorthWest University Xi’an).
Le sue pubblicazioni sui temi della colonizzazione greca (in part. Colonie di colonie, 2009) e sui rituali (Leggi e regolamenti funerari, 2000) costituiscono punti di riferimento per gli studi nel settore.
Si occupa anche di storia delle donne nel mondo greco e studi di genere, nelle forme comunicative e di approfondimento della public history (in particolare con il progetto #allascuoladelledonne, avviato dal 2016).
Svolge un’intensa attività di disseminazione culturale, con l’organizzazione di mostre ed esposizioni, in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, la partecipazione a contest, incontri pubblici e programmi televisivi (Rai Storia, TedX, Festival delle Filosofie, Festival dell’Antico, Festival delle Letterature Migranti ecc.). seminari e conferenze.
Per il suo impegno nella disseminazione pubblica di temi scientifici ha ricevuto Premio Internazionale Anassilaos, XXXV ed., 2023, sez. “Megale Hellas”.
È membro di importanti società scientifiche, fra cui la Consulta Universitaria per la Storia Greca e Romana, l’Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia e l’Associazione Italiana di Public History.
Fa parte di “100 esperte contro gli stereotipi” il progetto nato nel 2016 tra l’Osservatorio di Pavia e l’Associazione Gi.U.Li.A., con lo sviluppo della Fondazione Bracco e il supporto della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. ( www.100esperte.it )