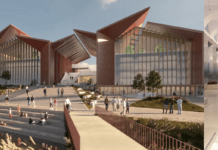L’area espositiva all’ultimo piano del Collegio dei Nobili in via Accademia delle Scienze a Torino non riposa mai.

È infatti terminata da poco la mostra “Anche le statue muoiono. Conflitto e patrimonio tra antico e contemporaneo”, che ha proposto un’interessante riflessione sul ruolo del museo come luogo di conservazione e restauro di antichi reperti, sullo sfondo dei conflitti che hanno provocato danni irreparabili al patrimonio storico archeologico di alcune aree del pianeta, che lo staff del Museo Egizio è già pronto per offrirci un nuovo percorso espositivo.
“Archeologia invisibile” sembra essere la naturale prosecuzione della mostra precedente, inseguendo un fil rouge che pone al centro dell’attenzione il reperto, la cui “biografia” diventa essenziale per svincolarlo dal semplicemente bello e farlo tornare ad essere ciò che in realtà è: la manifestazione concreta di un pensiero che si è fatto materia.
Il percorso di un reperto è complesso ed è scandito da più fasi. Dalla sua produzione al momento in cui è stato abbandonato, dalla sua riscoperta al restauro conservativo per poi essere ricontestualizzato nell’allestimento museale.

Un percorso che va ben oltre la sola lettura storica perché necessita di indagini oggettive che solo la fisica in tutte le sue applicazioni può eseguire, con il suo approccio analitico che consente di progredire nella comprensione della realtà.
Il vantaggio è duplice. Da una parte il concorso di più competenze che applicano metodologie scientifiche ai reperti archeologici – in una parola l’Archeometria – consente di conoscere la tipologia di materiali con cui sono stati realizzati e quindi anche il modus operandi dell’artigiano che gli ha dato forma. Dall’altra consente di effettuare scelte mirate e consapevoli sulle tecniche di restauro e conservazione, che ha sempre la priorità anche di fronte all’indagine diagnostica.
La struttura della mostra è suddivisa in 5 aree. Le tre centrali con specifiche sottosezioni dedicate alle indagini scientifiche che fanno luce sulla storia dei reperti e della civiltà Egizia.
Il visitatore inizia il percorso già dalla sala ovale e prosegue nel corridoio dove il progetto espositivo lo costringe a un punto di vista nuovo e per certi versi inusuale. Ciascun reperto infatti è portatore di una storia dimenticata che generalmente non è più tracciabile con indagini di tipo archeologico, che riguarda chi lo ha realizzato e le relazioni che il suo utilizzo – sia pratico che cultuale – ha innescato nel corso del tempo.

Tuttavia queste informazioni non sono andate perdute e si trovano “intrappolate” nei materiali con cui il reperto è stato realizzato, quasi mai visibili ad occhio nudo ma pronte ad essere liberate dall’indagine archeometrica.
Tra l’essere oggetto d’uso e diventare reperto archeologico vi è un lungo percorso che nel caso dell’antico Egitto si misura in millenni. Questo percorso modifica il reperto e il tempo sovrappone su di esso una serie di informazioni utili a ricreare la sua biografia, importante anche per emancipare l’archeologia, ed in particolare proprio l’egittologia, dai quei luoghi comuni che ne stravolgono il senso.
La visita continua con un altro approccio inusuale che sfata miti e leggende: l’archeologia non scopre oggetti ma contesti archeologici. Sembra una puntualizzazione superflua ma in realtà è un punto essenziale che, come già detto, colloca questa disciplina umanistica nel giusto ruolo emancipandola dai cliché di cui troppo spesso è ammantata.
Il reperto privato del suo contesto archeologico diventa un semplice oggetto, che se non ha caratteristiche estetiche di un certo tipo non riceve nessun tipo di attenzione, anche fosse di grande importanza storica.
È proprio durante lo scavo che si ha il punto di svolta nella vita del reperto, che si trasforma da oggetto d’uso a reperto archeologico ricevendo una nuova vita all’interno di una musealizzazione che tiene conto del contesto archeologico che lo riguarda, delle relazioni e delle microstorie che consentono narrazioni sempre più ampie ed una conoscenza sempre più approfondita anche del contesto storico.

Grande importanza in questa parte dell’esposizione è stata data alla fotografia archeologica. Grazie ad essa infatti, e soprattutto all’uso che ne è stato fatto fin dai primi del Novecento, non solo è possibile avere una grande quantità di dati scientifici oggettivi, ma è possibile anche la ricostruzione di contesti archeologici che ormai sono andati perduti. Il Museo Egizio di Torino possiede un ragguardevole archivio fotografico composto da lastre di vetro, negativi di vario genere e diapositive che ha ricevuto di recente un’attenzione particolare e una riorganizzazione capillare. L’intero archivio è stato messo in sicurezza e digitalizzato, così da poterlo mettere a disposizione di chiunque ne abbia bisogno senza compromettere il prezioso quanto delicato materiale originale.
Nella sezione successiva, la quarta, si entra nel vivo delle indagini archeometriche che ci consentono di vedere l’invisibile.
Protagonista principale è la luce e la sua analisi multispettrale, che consente al visitatore di arrivare con l’occhio laddove il reperto si mostra “muto”, cogliendo aspetti che ne aumentano la comprensione sotto ogni aspetto.

E poi i colori, la cui chimica è resa comprensibile grazie ad una collaborazione con il Massachusset Institute of Tecnology (MIT) che ci racconta dei minerali utilizzati dagli egizi per realizzare le pellicole pittoriche che ancora oggi ci lasciano senza fiato.
Di straordinario interesse il lavoro svolto sui sette vasi di alabastro di Kha, la cui tomba intatta fu scoperta da Schiaparelli a Deir el-Medina. Secondo l’interpretazione degli archeologi confortata dalle fonti epigrafiche, dovrebbero contenere i sette oli sacri legati alle complesse operazioni di mummificazione del corpo del defunto. Per evitare contaminazioni che potrebbero pregiudicare i risultati oggettivi delle analisi, i vasi non sono mai stati aperti, in attesa che una nuova tecnologia ne consenta l’analisi in totale sicurezza. Il Museo Egizio si è affidato ad un prestigioso centro di ricerca, lo Science & Technologies Facilities Council di Oxford, che utilizza una tecnologia denominata ISIS, sfruttando il fascio neutronico in 32 strumentazioni differenti ed anche se il mistero non è stato ancora svelato, lo splendido alabastro si è lasciato finalmente oltrepassare mostrando la massa che i vasi contengono al loro interno.

E a questo punto si è già andati oltre l’invisibile, all’interno del reperto per vederne il contenuto e raccontare – come già detto più volte – storie nuove.
L’ambito in cui questo tipo di indagine offre il maggior contributo scientifico, che innegabilmente incontra anche un grande favore di pubblico, è quello antropologico: ovvero le mummie umane e animali.
Il progresso tecnologico che ha avuto come oggetto l’ambito radiologico, ha influenzato pesantemente e positivamente l’antropologia e l’egittologia. Prima della scoperta dei Raggi X l’esame sulle mummie avveniva tramite lo sbendaggio e non di rado il dissezionamento dei corpi, con la conseguente distruzione del corpo e dispersione di dati scientifici di grande importanza, oltre all’importantissimo aspetto etico che quel comportamento trascurava del tutto.
Al centro di questa analisi non solo diagnostica le due mummie più celebri del Museo Egizio, i coniugi Kha e Merit, la cui prima radiografia fu eseguita nel 1966 rivelando agli studiosi la serie di gioielli e amuleti inseriti all’interno delle bende, posizionati secondo precise indicazioni dei sacerdoti che sovrintendevano il processo di mummificazione.
In seguito la TAC del 2012 ha evidenziato un fatto singolare: gli organi interni dei due coniugi, contrariamente a quanto era in uso, non sono stati eliminati durante la mummificazione, lasciando agli studiosi un enigma da risolvere.
Qui il visitatore diventa testimone di un passaggio importante il cui merito va interamente attribuito all’applicazione della scienza all’archeologia, che ha consentito di passare dallo sbendaggio vero e proprio a quello virtuale.
Il lettore attento avrà notato che questa recensione della mostra non è descrittiva. Non vi si trova la descrizione di un determinato reperto o ampie citazione prese in prestito dall’apparato comunicativo posto lungo il percorso.

Il motivo è semplice: questa mostra è un’immersione e come tale va vissuta in prima persona. Va attraversata senza curarsi del tempo e senza lasciarsi sfuggire nessun dettaglio, perché il messaggio che trapela ad ogni passo regala una consapevolezza nuova e ci mette in comunicazione attiva con il nostro patrimonio. Sono le nostre radici, quel “dove veniamo” che potrà guidarci verso un più consapevole percorso in avanti.
Mai come in questi tempi se ne sente un gran bisogno.