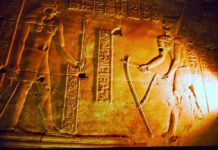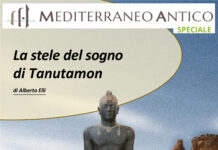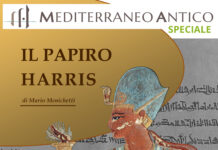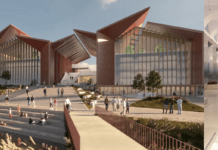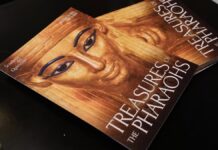Un’imperdibile mostra ci attende a Roma, sul meraviglioso giardino realizzato per la famiglia Farnese e divenuto simbolo rinascimentale e barocco della capitale. Il Palatino e il suo giardino segreto. Nel fascino degli Horti Farnesiani è attualmente visitabile sino al 28 ottobre 2018 presso il Parco archeologico del Colosseo, ove in passato si ergevano tali maestosi giardini. Un percorso che ha origine nella metà del Cinquecento, periodo del suo primo allestimento per volere del cardinale Alessandro Farnese al fine di enfatizzare il prestigio familiare conseguito in virtù delle cariche politiche e istituzionali ricoperte: autocelebrazione confermata dalla scelta della sede presso le antiche rovine imperiali, proprio laddove venne fondata la capitale rappresentando poi il fulcro del potere dall’età augustea.

Curata da Giuseppe Morganti ed organizzata da Electa, la rassegna ha inizio dal confine del Foro Romano in via Nova all’Uccelliere di Colle Palatino con l’ausilio di illustrazioni che guidano il pubblico nella narrazione dei mutamenti subìti dal sito nel trascorrere dei secoli. Dalle iniziali geometrie del verde alla stagione del Gran Tour, durante la quale emerse il fascino romantico e decadente del giardino che ammaliò molteplici artisti e poeti tra cui Goethe, sino al sorgere delle ricerche archeologiche nei primi del Novecento. Allora furono piantati svariati alberi di agrumi, cipressi, allori e tassi, nonché rose e rampicanti, finalizzati a ricreare l’antico incanto del luogo.
Per un simile evento giungono da Napoli due sculture appartenenti al Museo Archeologico Nazionale, le statue Barbaro inginocchiato e Iside fortuna, tornando eccezionalmente alla loro sede d’origine: la prima, anticamente adoperata come portavaso, era costituita da marmo nero e pavonazzetto; la seconda, di marmo bigio morato, fungeva da decorazione ad una nicchia della scala del Teatro di Fontanone. A tale fontana è stato ridonato l’aspetto di un tempo, privandola dell’incrostazione calcarea che era emersa a seguito della crescita di calle e capelveneri nel tardo Ottocento, per far riemergere l’antica composizione di vasche sovrapposte e congiunte da piccole cascate confluenti poi nell’ampia vasca polilobata finale. Inoltre nelle Uccelliere sono stati esposti due maestosi busti, i Daci prigionieri che nel XVII secolo caratterizzavano il criptoportico per accedere al Ninfeo della Pioggia, area ricreativa ideata dai Farnese ed ora luogo di esposizione di innovative installazioni multimediali. Infatti il progetto prevede l’enfatizzazione del luogo mediante l’uso di accattivanti tecnologie digitali immersive, scelta divulgativa che ha soventemente prodotto entusiasti consensi nel pubblico. Vi è un video mapping che, sulla base delle fonti esaminate, rievoca l’aspetto d’origine del complesso dei giardini mediante suggestive prospettive dall’alto che ne mostrano i pergolati, i filari arborei ed i giochi d’acqua.

Promossa dal Parco archeologico del Colosseo e da Electa, la mostra si configura come un itinerario lento e suggestivo: un percorso reale e immaginario al tempo stesso, sino a giungere al belvedere che offre l’ineguagliabile bellezza di Roma, come espresso dal direttore del parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo.
Per l’occasione Electa propone una nuova edizione della guida degli Horti Farnesiani che ne narra la storia arricchita da un interessante apparato iconografico: il testo Il Palatino e il suo giardino segreto. Nel fascino degli Horti Farnesiani, curato da Morganti, descrive la nascita e l’evoluzione del luogo per poi guidare alla scoperta delle strutture ivi conservate e alla ricostruzione ideale dell’assetto iniziale ricorrendo a descrizioni, raffigurazioni e fotografie d’epoca.

La storia di questo straordinario giardino ha origine nel 1537, anno in cui il cardinale Alessandro Farnese acquistò vari appezzamenti dall’area del Foro a quella opposta del Circo Massimo, per poi cederli al fratello Ottavio cui chiese di contribuire all’abbellimento del possedimento familiare. Ne seguì una fase di arricchimento del giardino mediante alberi e fontane per opera per cardinale Ranuccio, alla cui morte rientrò in possesso il cardinale Alessandro per ampliare i possedimenti terrieri inserendo nuovi elementi: un ampio muro delimitante con basamento a scarpa e torrette angolari, un portale centrale, una rampa verso il primo ripiano, il criptoportico ed il Ninfeo degli Specchi quale esercitazione sull’idea di fontana-grotta inserita nel terreno. L’erede Odoardo fece realizzare il Ninfeo della Pioggia (1612-1626) ed un’uccelliera speculare rispetto a quella antica ridonando simmetria al sistema. A metà del Seicento la famiglia si trasferì a Parma ed il giardino apportava un pesante costo durante questa loro fase di declino; in seguito venne tramutato nell’azienda agricola “Reale Azienda Farnesiana” attiva dal 1718 al 1854. Negli anni compresi tra il 1721 ed il 1727 Francesco I, duca di Parma, promosse degli scavi che condussero al rinvenimento dei tre ambienti della Domus Flavias (il Lararium, l’Aula Regia, la Basilica), nonché le sculture colossali di Ercole e Diòniso Farnese.

Durante il dominio napoleonico furono modificate le uccelliere in veste neoclassica e nel 1861 l’imperatore di Francia Napoleone III acquistò gli Orti per realizzare scavi archeologici condotti da Pietro Rosa, il quale procedette alla conservazione e riadattamento delle costruzioni a discapito delle coltivazioni. Nel 1870 il Governo Italiano lo acquistò ed affidò gli scavi a Rodolfo Lanciani che ridusse la superficie dei giardini, fece smontare il portale del Vignola e distruggere la facciata nord ed i casini angolari. Agli inizi del Novecento gli scavi furono condotti dall’archeologo Giacomo Boni che rivalorizzò il Ninfeo degli Specchi allora coperto da piante selvatiche e detriti di scavo, curando anche il giardino con essenze esotiche in ricordo dell’originale funzione di orto botanico del luogo. Nel 1957 fu rimontato il Portale del Vignola, in qualità di accesso monumentale al Parco archeologico del Palatino. Tale Portale era anticamente inserito nel muro di cinta degli Horti Farnesiani e ripartito su due ordini: l’inferiore tuscanico ai cui lati due nicchie, semicolonne e pilastri sorreggono un fregio con alternanze di triglifi e mètope di gigli farnesi; il superiore con arco centrale e loggia a balaustri, presenta paraste decorate dallo stemma Farnese e l’iscrizione “Horti Palatini Farnesiorum” sulla trabeazione poggiata su un capitello ionico. Il primo ordine è tradizionalmente attribuito a Vignola, laddove il secondo ordine fu aggiunto da Giacomo Del Duca in occasione del Giubileo del 1575. Nell’area settentrionale rispetto al Foro Romano vi sono i resti delle mura di fondazione, esemplari di muratura a sacco anticamente inseriti dentro la terra, portati alla luce durante gli scavi archeologici di Giacomo Boni nei primi anni del Novecento e di Alfonso Bartoli nel 1940 circa. Allora nel Teatro d’ingresso semicircolare permeante di luce si accedeva alle terrazze sovrastanti tramite tre ordini di scale, la cui prima rampa è attualmente conservata e diretta verso il Ninfeo della Pioggia.

Nel periodo tra il 2013 ed il 2018 sono stati effettuati i restauri delle Uccelliere Farnese dalla Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici e successivamente dal Parco archeologico del Colosseo finanziato dal World Monuments Fund (WNF) di New York. In questa seconda fase si è tentato di recuperare le linee ed i volumi degli elementi architettonici e delle decorazioni per ricreare parti di modanature che erano andate distrutte, ridonando loro l’iniziale struttura formale con il cromatismo bitonale delle facciate. Le Uccelliere Farnese, il Teatro del Fontanone ed il Casino del Belvedere sono testimonianze concrete degli Horti Palatini Farnesiorum distrutti e modificati durante la campagna di scavo, costituendo dal punto di vista conservativo i migliori esemplari di architetture rinascimentali sul Palatino.
Cuore verde del parco archeologico, il Palatino è congiunzione di natura e cultura, nonché custode della storia e dei miti della città: dalla leggendaria grotta di Romolo e Remo agli ampi cortili dai quali sono state decretate le sorti del mondo antico. Inusuali piante importate dalle Americhe e volatili esotici posti nelle voliere caratterizzavano la magnifica area, benché sia stata spesso sacrificata dagli archeologi a vantaggio del Palazzo Imperiale, rovine appartenenti alle dinastie giulio-claudia e flavia, i cui resti permangono nel sottosuolo. Finalmente adesso è nuovamente visionabile il fantastico giardino caratterizzato da rampe, portici e terrazze da cui ammirare i Fori e la valle del Colosseo, arricchito da testi descrittivi, stampe e vetuste raffigurazioni che ne mostrano l’originale splendore in qualità di sito lussuoso ed elegante, rilassante e contemplativo.
Giorni e orario di apertura: 25 marzo – 31 agosto ore 8,30–19,15 ; 1 – 30 settembre ore 8,30–19,00 ; 1 – 28 ottobre ore 8,30–18,30 ; 1 maggio: chiusura.
Prezzo d’ingresso: intero 12 euro, ridotto 7,50 euro.
Info: www.electa.it ; per visite guidate e biglietti on-line www.coopculture.it , +390639967700.