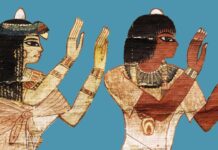Lo scavo in corso di una delle trincee di Oued Beht. Foto di Giulio Lucarini. © Archivio OBAP
Un importante progetto di ricerca scientifica internazionale, frutto della collaborazione tra l’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISPC), l’Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente (ISMEO), l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine (INSAP) di Rabat e il McDonald Institute for Archaeological Research dell’Università di Cambridge, ha recentemente portato alla luce l’insediamento neolitico di Oued Beht, situato nei pressi della cittadina di Khémisset, in Marocco.
Questo paese, situato all’estremo nord-ovest del continente africano, fa parte del Maghreb occidentale, e occupa una posizione geografica strategica che lo collega all’Oceano Atlantico, alla catena montuosa dell’Atlante, al deserto del Sahara e al Mediterraneo occidentale. La potenzialità connettiva del Maghreb è chiara già a partire dall’Olocene antico, con evidenze di mobilità di gruppi di cacciatori-raccoglitori e, successivamente, di comunità pastorali, culminando nella diffusione di gruppi neolitici dalla Penisola Iberica in Africa nordoccidentale (VI-V millennio a.C.).

Anche in epoche successive, il Maghreb ha continuato a dimostrare il suo ruolo di crocevia culturale, specialmente tra l’arrivo dei primi coloni fenici agli inizi del I millennio a.C. fino all’età islamica. Tuttavia, un’analisi approfondita del periodo compreso tra IV e I a.C. era assente, nonostante l’ampia documentazione riguardante le culture del Levante, dell’Egeo, della Valle del Nilo e della penisola iberica. Durante questa fase, il Maghreb doveva costituire un nodo fondamentale in una rete di scambi che lo collegava alla penisola iberica, come dimostrano sia la presenza di manufatti realizzati con materiali esotici di origine africana (ad esempio, l’avorio e l’uovo di struzzo), sia gli studi genetici che rivelano tracce di ascendenze africane in siti della Penisola iberica.

Le indagini dell’Oued Beht Archaeological Project (OBAP), dirette da Giulio Lucarini (CNR-ISPC), Youssef Bokbot (INSAP) e Cyprian Broodbank (Università di Cambridge), hanno preso avvio nel 2021. I primi rinvenimenti nel sito risalgono agli anni ’30 del secolo scorso, quando furono scoperte oltre mille accette in pietra levigata, molte delle quali sono conservate al Museo di Storia e Civiltà di Rabat. Nel 2005, Youssef Bokbot avviò la prima indagine sistematica nell’area.

L’insediamento neolitico di Oued Beht si estende su una superficie di 10 ettari, paragonabile a quella della città di Troia nell’Antica Età del Bronzo. Le ricerche condotte sul sito hanno previsto l’impiego di metodologie diverse, tra cui ricognizioni sul campo, prospezioni geofisiche, rilievi tramite droni e scavi stratigrafici, insieme alle analisi di manufatti archeologici e campioni di piante e animali.

Risalente al Neolitico finale (3400-2900 a.C.), il sito ha restituito importanti testimonianze dell’attività umana in questa parte del Nord Africa, attualmente uniche per questa fase cronologica a ovest della più nota Valle del Nilo. Tra le evidenze emerse si segnalano numerose fosse per l’immagazzinamento di derrate alimentari, confermate dai resti carbonizzati di orzo, frumento e legumi domestici, insieme a pistacchio e olivo selvatici. I resti faunistici includono capra, pecora, bovino e suino domestici, molti dei quali presentano segni di macellazione, suggerendo che questa pratica avvenisse localmente. Tra i reperti materiali figurano strumenti in pietra levigata, come accette, grandi pietre da macina, manufatti in pietra scheggiata e vasi in ceramica – tra cui esemplari dipinti – utilizzati per preparare, conservare e consumare alimenti.
La quantità e la varietà dei reperti litici e ceramici, quasi 20.000 in totale, offrono dati senza precedenti per questa area del continente africano, al di fuori della Valle del Nilo.

Le ricerche condotte fino a oggi e gli studi attualmente in corso sui resti organici e inorganici hanno consentito di collocare il villaggio di Oued Beht nella fase finale del Neolitico, rivelando come la produzione agricola, la lavorazione e lo stoccaggio di alimenti vegetali, nonché l’allevamento e la macellazione di animali domestici, fossero elementi centrali nell’economia della comunità. Tuttavia, il contesto sociale e culturale del Maghreb tra la fine del IV e gli inizi del III millennio a.C. rimane ancora da esplorare, affinché si possa comprendere meglio il ruolo di Oued Beht all’interno del panorama più ampio della tarda preistoria del Mediterraneo occidentale.

Oued Beht Archaeological Project è finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dall’Università di Cambridge e dal British Institute for Libyan and Northern African Studies (BILNAS).

Fonti:
Oued Beht Archaeological Project (OBAP)
Oued Beht, Morocco: a complex early farming society in north-west Africa and its implications for western Mediterranean interaction during later prehistory, in Antiquity, Cambridge University Press 2024, pp. 1-20, open access

Gallery da © Archivio Fotografico Oued Beht Archeological Project