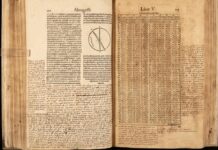La tomba con pareti e pavimentazione in corallo a Berenice, ph. Mariusz Gwiazda PCMA UW
L’ultima stagione di scavi a Berenice condotta dal Polish Centre of Mediterranean Archaeology ha portato alla luce diverse sepolture intatte con ricchi corredi funebri.
Berenice è oggetto di indagine dal 2008 da parte della missione polacco-americana che vede coinvolti il Polish Centre of Mediterranean Archaeology dell’Università di Varsavia e l’Università del Delaware. Il tutto in collaborazione con il Ministero Egiziano per il Turismo e le Antichità.

Fondato da Tolemeo II Filadelfo nel 275 a.C. in onore della madre Berenice I, il sito di Berenice Trogloditica è situato sulla costa del Mar Rosso a confine con il Sudan. La sua collocazione lo pone come punto commerciale strategico di prodotti pregiati come oro e avorio da e per il Mar Rosso, e in Oriente, verso l’India e l’Estremo Oriente anche in epoca romana e successiva.
Le sepolture intatte, che risalgono al IV-V sec. d.C., testimoniano la differenziazione sociale della Berenice dell’epoca, un periodo ancora poco conosciuto per questo sito. Come asserisce il co-direttore dr. Mariusz Gwiazda del PCMA UW, la forma delle sepolture e il corredo funerario sono unici per tutto l’Egitto orientale.
Ma le sorprese non finiscono qui. Le sepolture infatti sono state rinvenute all’interno di una tomba rettangolare di 5m ca. di lunghezza, il cui pavimento è lavorato con lisci coralli bianchi mentre per intonacare i muri è stato utilizzato un composto di corallo e fango. Un unicum per l’epoca e di cui solo Berenice ne è testimone. Le sepolture si trovano all’interno di casse di pietra i cui corpi sono in posizione contratta e legati, forse per recuperare spazio. Il ricco corredo è composto da 700 perline, alcune provenienti dall’Asia meridionale, diversi anelli e orecchini in argento e bracciali in avorio. Non mancano resti che rivelano riti funerari come anfore vinarie e bottiglie in ceramica per l’acqua, scodelle e bruciatori per incenso. Di quest’ultima categoria è particolare un incensiere di pietra che ha la forma della testa di un leone.
A causa dei costi di lavorazione del corallo, gli archeologi presumono che questa tomba comune sia stata realizzata per l’élite di Berenice, come d’altronde farebbe pensare anche la tipologia di corredo.

Lo scopo dei ricercatori è quello di investigare la vita della comunità del Deserto Orientale durante il dominio dei Blemmi, ovvero dal IV al VI sec. d.C., attraverso lo studio dei costumi funerari e delle analisi paleoantropologiche. La popolazione nubiana dei Blemmi aveva il controllo del Deserto Orientale dall’attuale confine Egitto-Sudan fino all’Etiopia, e Berenice continuò ad avere importanza come porto anche in quest’epoca. Del resto, essi tennero il controllo sul santuario di File attivo fino alla sua distruzione da parte dell’imperatore Giustiniano nel 535 o 540 d.C.
Gallery: