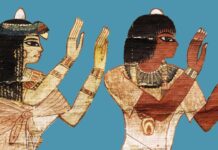Dopo la catastrofica eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., che seppellì Pompei sotto metri di cenere e lapilli, la narrazione storica ha spesso considerato la città come definitivamente morta. Tuttavia, recenti scavi nell’Insula Meridionalis, parte meridionale dell’area archeologica, stanno cambiando radicalmente questa visione: Pompei fu rioccupata, e la vita continuò, anche se in forme nuove e profondamente trasformate.

Subito dopo l’eruzione, alcuni sopravvissuti – presumibilmente privi di risorse o alternative – ritornarono tra le rovine della città. A loro si aggiunsero, con ogni probabilità, persone provenienti da altre zone, senza fissa dimora o in cerca di fortuna. Pompei, pur devastata, rappresentava un’occasione: offriva rifugi tra gli edifici semisepolti, oggetti di valore ancora nascosti sotto le macerie e nel tempo tornò ad essere un luogo vivibile, grazie al graduale ripristino della vegetazione e dell’ambiente naturale.


Le nuove indagini archeologiche hanno fatto emergere testimonianze materiali di questa fase dimenticata della storia pompeiana. Si tratta di focolari, forni, piccoli mulini: elementi che indicano una vita quotidiana semplice e disorganizzata, sviluppatasi tra i piani superiori degli edifici sopravvissuti all’eruzione. Ciò che un tempo era il pianterreno divenne ora seminterrato o cantina, mentre i livelli superiori furono adattati come nuovi spazi abitativi. Quella che un tempo era una città fiorente divenne così una sorta di insediamento spontaneo, fragile e privo delle infrastrutture proprie di una vera città romana.

Il quadro che emerge è quello di un accampamento permanente, un agglomerato umano che resistette per secoli, fino al V secolo d.C., quando una nuova e forse definitiva crisi – forse l’eruzione di Pollena – portò all’abbandono totale dell’area.
Anche le autorità romane tentarono, in un primo momento, di riorganizzare il territorio colpito. L’imperatore Tito inviò due ex consoli, i curatores Campaniae restituendae, con il compito di amministrare i beni degli scomparsi senza eredi e promuovere una rifondazione di Pompei ed Ercolano. Tuttavia, il progetto non ebbe successo. Pompei non tornò mai più a essere un centro vitale, ma restò un luogo di sopravvivenza ai margini del sistema romano.
Il dato più significativo che emerge dagli scavi è anche di tipo storiografico e culturale: per secoli, gli scavi archeologici hanno trascurato o addirittura cancellato intenzionalmente le tracce di questa fase post-eruttiva. L’entusiasmo degli archeologi e del pubblico era tutto concentrato sulla “Pompei del 79”, con i suoi affreschi, arredi e strade perfettamente conservate. In questo contesto, le testimonianze della rioccupazione post-disastro venivano considerate scomode, disturbanti, o semplicemente poco rilevanti, e quindi ignorate.



Come ha osservato Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei e co-autore della pubblicazione sui nuovi ritrovamenti, la Pompei post-79 è stata letteralmente rimossa dalla memoria storica. Eppure, questa “seconda vita” della città racconta molto della capacità di resilienza umana, della precarietà dell’esistenza e delle dinamiche sociali che seguono una grande tragedia.
Quella che oggi riemerge è un’immagine diversa da quella iconica e cristallizzata di Pompei: non più la città elegante e fiorente fermata nel tempo, ma un luogo di sopravvivenza, trasformazione e marginalità. Un insediamento che, pur nelle difficoltà, rappresenta la continuazione della vita. In un certo senso, questa nuova immagine di Pompei completa e arricchisce la narrazione storica, obbligandoci a riflettere non solo sulla grandezza perduta, ma anche sulla fragilità, la speranza e l’adattamento dell’uomo di fronte alla catastrofe.

Source: Pompeii Parco Archeologico