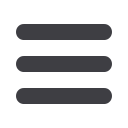

53
probabilità, fu ben più vasto di quanto le stesse fonti sembrerebbero suggerire
9
.
Se, dunque, le testimonianze
sulla vita religiosa dell’uomo egizio comune, o umile, sono praticamente assenti, soprattutto per le fasi storiche
più antiche
10
, supporre che le credenze relative agli spiriti dei defunti ebbero, in realtà, un ruolo di primo piano
nelle credenze degli egizi risulta sicuramente un’ipotesi verosimile.
Già agli inizi del secolo scorso il padre dell’antropologia E. B. Tylor rintracciò l’origine di ogni fenomeno religioso
nel culto dei defunti. Sebbene una simile interpretazione di matrice rigidamente evoluzionista e positivista sia
decisamente superata non sono mancati studi successivi che l’abbiano ripresa rielaborandola. Ad esempio,
l’antropologo cognitivista S. Atran ha recentemente sostenuto che le credenze relative agli spiriti dei morti sia-
no uno dei fenomeni religiosi maggiormente diffusi nelle più diverse culture e in ogni contesto storico, gografi-
co e sociale, perché intrinsecamente connesse sia con esperienze comuni a tutti gli esseri umani (quali il lutto)
che, soprattutto, con alcune strutture cognitive proprie di ogni individuo. Si tratterebbe, in pratica, di un’idea
particolarmente “buona da pensare” per via della sua “pertinenza” in molte situazioni importanti di interazione
tra ambientale e sociale
11
. Partendo da un simile presupposto non sarebbe errato, dunque, ipotizzare che le
potenti famiglie nobiliari emerse con la crisi del potere faraonico sul finire dell’Antico Regno abbiano rielabora-
to un patrimonio preesistente di credenze che, pur essendo ampiamente diffuse, conobbero solo in questo
modo una prima consistente attestazione su materiale non deperibile.
Effettivamente, gli indizi di un simile sentire religioso nel corso della civiltà faraonica sono molteplici. Già nelle
mastabe degli alti funzionari dell’Antico Regno il defunto è spesso descritto come un essere sovrumano do-
tato di grandi poteri con i quali può talvolta punire i profanatori della sua tomba. E anche ben oltre il Medio
Regno le credenze relative ai poteri ultraterreni dei morti giocarono un ruolo fondamentale nella vita religiosa
degli egizi, come testimoniano chiaramente i dati relativi al culto domestico degli antenati rinvenuti a Deir
el Medina
12
. Non sarebbe errato, dunque, sostenere che nel sistema religioso egizio esistette una dimensione
per certi versi diversa dalle sofisticate speculazioni sapienziali della grande letteratura religiosa. Si tratta di
credi prevalentemente basati sul continuo contatto tra i viventi e gli spiriti dei defunti che dovevano prevedere
una serie di complesse credenze sulla sopravvivenza oltre la morte non solo dell’individualità della singola
persona, ma anche del suo ruolo e della sua funzione sociale, un simile insieme di convinzioni che dovette ca-
ratterizzare l’esperienza religiosa quotidiana di tutti gli egizi, dal più potente sovrano al più umile dei contadini.
Approfondire le nostre conoscenze sul culto degli antenati egizio, dunque, non solo può aiutarci nell’arduo
compito di ricostruire (seppur in modo piuttosto vago) le credenze degli uomini e delle donne comuni dell’an-
tica valle del Nilo, ma potrebbe fornire un’interessantissima chiave di lettura per comprendere in modo più
approfondito la stessa religione legata all’autocelebrazione delle più ricche e potenti élite, se non lo stesso
spinoso problema dell’originalissima concezione della regalità divina egizia. Accettando una simile prospettiva,
infatti, l’importanza religiosa ricoperta dal sovrano defunto
risulta arricchirsi di nuovi e interessanti significati: Il destino
divino oltremondano riservato al faraone non doveva co-
stituire solo un privilegio finalizzato all’ostentazione di un
grande potere, ma doveva assolvere, innanzitutto, una fun-
zione ben precisa strettamente connessa a questo aspetto:
il faraone non solo era l’uomo più potente di tutto l’Egitto
e, di conseguenza, il più influente fra tutti gli antenati
13
, ma
il suo stesso ruolo politico faceva sì che egli racchiudesse
nella sua persona l’intera comunità su cui regnava
14
.
La so-
pravvivenza ultraterrena del sovrano garantiva
,
dunque, il
perpetuarsi e la continuità dell’intero popolo egiziano inte-
so come collettività e, di conseguenza, il prevalere dell’or-
dine sociale – a cui di fatto corrispondeva quello cosmico
– sulle forze caotiche.
9 J. BAINES, Practical Religion and Piety, JEA 73 (1987), p. 86.
10 J. BAINES, Op. Cit., JARCE 27 (1990),pp. 12 e ss.
11 S. ATRAN, In God we Trust, (2002)Oxford.
12 R. J. DEMARÉE, Akh iqer en Ra steale, (1981) Leiden.
13 Cfr. Pepi I PT 365.
14 R. B. FINNESTAD, The Pharaoh and the “Democratization” of Post-mortem Life, in: G. ENGLUND (a cura di), The religion of the ancient Egyptians: Cognitive structures and popular expressions. Proceedings of Symposia in
Uppsala and Bergen, (1989) Uppsala, p. 89 e ss.
Renata
Shiavo
Renata Schiavo è nata a Siracusa. Da
sempre appassionata di miti, leggende e
storia antica, si è laureata in egittologia
presso l’Università di Pisa, specializzan-
dosi sia in filologia (Lingue e culture del
Vicino Oriente) che in Archeologia (curri-
culum “Egitto e Vicino Oriente”). Durante
gli anni universitari è stata redattrice della
rivista letteraria AEOLO e ha preso parte
a diverse campagne di scavo in Italia...
leggi tutto

















