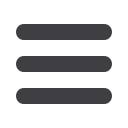

monete riportano l’immagine della tipica galea, ve-
loce e maneggevole.
Nel 229 a.C., i frequenti attacchi alle navi italiche
diedero spunto a Roma per dichiarare guerra agli
Ardiei. Teuta fu inizialmente costretta a negoziare
una tregua con i R omani, c he ne approfi ttarono
per stabilire degli avampostiaDurazzoe adApollonia.
Gli Illiri si trovano costretti a una difficile scelta di
campo: da un lato i Romani, dall’altro i Macedoni;
malauguratamente, optarono per quest’ultimi, tro-
vandosi in gravissime difficoltà soprattutto dopo
la clamorosa sconfitta subita da Filippo V di Mace-
donia nel 168 a.C. a Pidna.
Incassata questa vittor ia, l’anno segu ente le le-
gioni romane si presentarono alle porte di Passa-
ron (la ca pitale dei Molossi) con l ’ordine di
saccheggiare le città: soldati e cavalieri ricevettero
come bottino rispettivamente duecento e quattro-
cento denari, mentre le mura cittadine venner o
rase al suolo e centocinquantamila persone furono
vendute sul mercato degli schiavi.
Nel 167 a.C. tutte le città comprese tra il fiume Dri-
nos e A oos (la cosidde tta Atintania) ricevet tero
l’ordine di attaccare e saccheggiare le città illiriche
che avevano appoggiato Perseo di Macedonia; fu-
rono risparmiate solo quelle che avevano aiutato i
Romani.
Lucio Anicio Gallo celebrò il trionfo nella capitale:
davanti al carro del pretore vittorioso fu fatto sfi-
lare l’ultimo re illirico, Genzio (da cui, tra l’altro, se-
condo Plinio, deriverebbe il nome della genziana!)
con la moglie e i fig li, suo fratello Caravanzios e
altri membri dell’élite locale.
Finiva in questo modo la secolare storia dell’Illiria
indipendente ma iniziava una nuova fase di stabi-
lità politica e sviluppo economico. Le aree conqui-
state furono divise tra le neoistituite provincie di
Macedonia e dell’Illirico.
L’archeologia è s tata in grado di ve rificare sul
campo la distruzione e l’abbandono di alcuni centri
minori come Dimallum, Olympe, Coragus, Brysaka,
e il trasferimento degli abitanti verso i centri prin-
cipali; Apol lonia, Amathus e O ricum c he erano
state fedelia Roma ottennero lostatuto di città «li-
bere e immuni» mentre alt rove furono insediati
dei col oni provenien ti dall’ Italia. N onostante l a
conquista romana però, la regione rimase sempre
legata alla cultura greca: i t eatri continuavano a
essere molto frequentati, la g ente s i r itrovava
nell’agorà, le antiche magistrature furono rispet-
tate e continuò l’uso del greco – parlato e scritto –
anche se le iscrizioni ufficiali venivano redatte in
latino.
Solo a Oricum, dove stazionava la flotta romana, si
respirava uno stile di vita particolarmente “italico”.
8. Apollonia e Butrinto
Ad Apollonia, Gaio Ottavio attese agli studi di reto-
rica e, con ogni probabilità, passeggiò per il centro
della città in compagnia di Agrippa, ammirando le
statue esposte nelle ampie stoai ellenistiche del-
l’agorà. Proprio qui, il futuro Augusto ebbe modo
di consultare un indovino che gli vaticinò un d e-
stino luminoso; una predizione quanto mai azzec-
cata v isto c he, poc o t empo dopo, l’inaspettato
assassinio di Giulio Cesare gli aprì la strada per la
scalata al potere imperiale.
In età imperiale, la cerchia di mura (lunga 4 k m)
presentava ampi segni di rifacimento, segno tangi-
bile della tumultuosa storia cittadina. Il muro più
antico (VII sec a.C ) fu realizzato con blocchi qua-
drangolari di sagoma irregolare, venendo rimoder-
nato, due secoli più tardi, con una nuova cortina in
parte in pietra, in parte in mattoni; in seguito, fu-
rono aggiunti ulteriori bastioni q uadrangolari,
adatti ad ospitare catapulte e macchine da getto
con cui resistere agli attacchi dei Molossi e dei Ma-
cedoni.
54
speciale albania
Bastione orientale delle mura di Apollonia


















