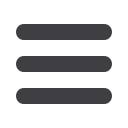

era attraversata da un’importante strada di origine
preistorica diretta in Macedonia.
Negli anni Settanta, proprio alla base della piatta-
forma naturale sui cui sorgeva l’antica città, l’ar-
cheologo Neritan C eka h a messo in luce una
singolare necropoli reale edificata nel corso del IV
sec a.C.
Dimostrando un notevole spirito pratico, le tombe
furono r icavate nella parete rocciosa dell’antica
cava da cui erano state prelevate le pietre neces-
sarie per edificare la cinta della cittadella supe-
riore.
Cinque tombe allineate lungo una falesia rocciosa
mostrano un’architettura di maggior prestigio e
una combinazione eclettica di motivi architettonici
veramente peculiari. La prima presenta una ca -
mera scavata nella roccia con due bancali laterali
destinati ad ospitare i defunti. I capitelli ionici del a
facciata e molti elementi decorativi sono una pa-
lese citazione delle f amose t ombe macedoni di
Verghina e di P idna, in part icolare di quel la del
padre di Alessandro, Filippo II.
Una sec onda t omba fu realiz zata su du e li velli:
quello superiore presenta un finto portico semicir-
colare concluso da una camera e decorato con ri-
lievi rappresentanti uno sc udo circolare illirico e
un elmo di tipo greco; l’ambiente inferiore fu i n-
vece destinato a camera funeraria vera e propria
e dotato di due splendidi sarcofagi di stile elleni-
stico a forma di letto funebre.
Il Museo di Tirana raccoglie il ricco corredo sco-
perto nel 1972 nella camera inferiore, composto da
armi, vasi, gioielli, una maglia in ferro e un elmo
da guerriero. La foggia dei reperti – tipici del III sec
a.C. – por ta ad escludere che la deposizione sia
contemporanea alla costruzione della tomba; evi-
dentemente l ’ambiente f u reimpiegato pe r dare
sepoltura a d u n per sonaggio di alto lignaggio,
forse quel Monunios che aveva sognato la crea-
zione di un potente regno illirico esteso fino al lago
di Ochrid.
Nelle im mediate vicinanze si trova una t erza
tomba scavata nella roccia che rappresenta un uni-
cum: la piccola camera sepolcra le è, infa tti, sor-
montata da un te atro i n miniatura che pot eva
ospitare un numero molto ridotto di persone. Sem-
bra naturale collegare questa singolare sistema-
zione architettonica ai banchetti e alle sacre rap-
presentazioni che venivano inscenate in occasione
della com memorazioni funebri, onor e normal -
mente riservato a personaggi di alto lignaggio.
6. Illiri, pirati e grandi bevitori
Le informazioni che ci sono giunte sul carattere e
la civiltà degli antichi Illiri sono piuttosto frammen-
tarie e limitate, sicuramente filtrate dalla mentalità
e dall’opinione degli scrittori romani e greci che le
hanno tramandate.
I Romani – che avevano conosciuto il mondo illirico
attraverso l’Adriatico – rimasero colpiti dalla loro
proverbiale abilità di marinai e dalle veloci navi ca-
ratterizzate da una doppia fila di rematori, le fa-
mose liburne.
Gli indizi sulla talassocrazia illirica non mancano:
gli Illiri giunsero a Corfù prima dei Corinzi (nel IX
sec. a.C.) e visitarono diversi santuari greci del-
l’Egeo, lasciandovi iscrizioni e donativi per cele-
brare le loro imprese.
Nell’antichità, commercio e pirateria non erano di-
sgiunti, e gli Illiri si conquistarono sul campo il ti-
tolo di pirati per eccellenza. «La gente illirica era
selvaggia e la pirateria erauna cosanormale» (Stra-
bone VII, 5); «i Liburni, altra gente illirica, che rapi-
navano il mare Ionio e le isole con le loro navi veloci
e leggere, donde ancor oggi i Romani chiamano
liburne le biremi leggere e rapide» (Appiano, 3).
Filippo V d i Macedonia a veva g rande stima d ei
cantieri navali illirici e ordinò loro ben cento navi
da guerra, cosa mai accaduta prima.
Data la relativa facilità di navigazione del Canale
d’Otranto, non c’è poi da stupirsi che i mitografi
greci e romani (Strabone, Festo e Antonio Liberale,
in particolare) accennino al contributo di gruppi di
Illiri alla gen esi delle pop olazioni dei Dauni, de i
Peucezi e dei Messapi in Puglia.
Le fonti r iportano anche alcuni particolari d ello
stile di vita delle classi più ricche, talora fedel-
mente talora con spirito polemico o denigratorio.
In generale sembra che gli aristocratici avessero
una certa predilezione per il vino. Ateneo (II-III sec
52
speciale albania


















