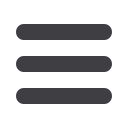
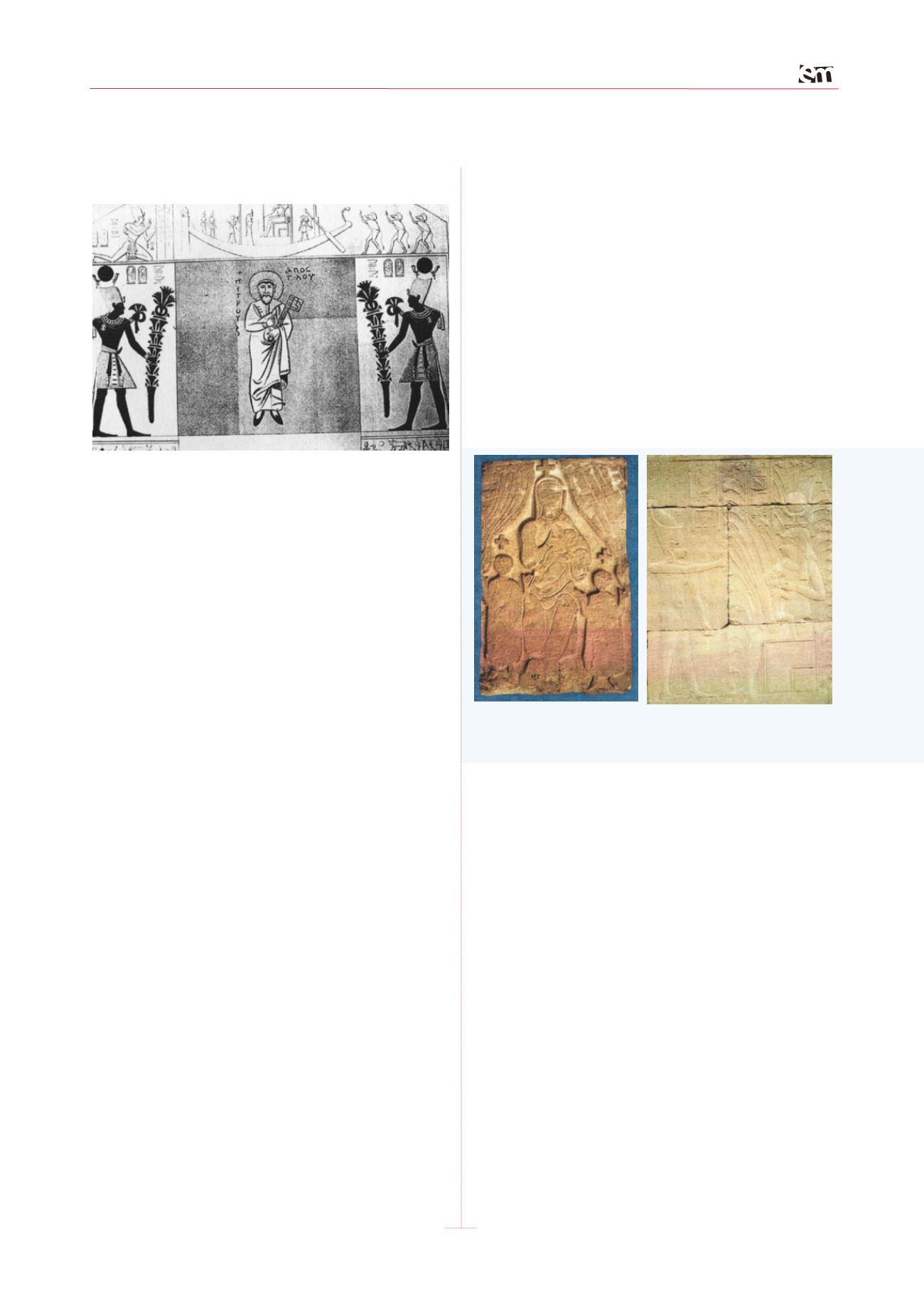
19
Così Lucie Duff Gordon, residente britan-
nica, descriveva nel XIX secolo quel partico-
larissimo intreccio di influssi e culture che
solo nella Valle del Nilo poteva essere osservato.
Cristianesimo e, successivamente, islami-
smo, si innestano infatti su di un substrato
millenario fatto di antichissimi riti e cre-
denze che non scompaiono al contatto con
le nuove religioni, anzi, le contaminano e le
integrano con elementi tipicamente egiziani
riuscendo, allo stesso tempo, a conservare
la propria identità resistendo tenacemente
alle soppressioni e continuando a sopravvi-
vere per secoli radicate nella sensibilità popo-
lare. Ed è proprio per diretta conseguenza di
ciò che il cristianesimo egiziano assume
molte caratteristiche importanti che lo di-
stinguono da quello che si diffonderà in
altre parti del mondo Mediterraneo inte-
grando nei suoi riti reminiscenze di pratiche
faraoniche, elementi di cultura ellenistica e
bizantino/egiziana ed il dinamismo tipico
della civiltà araba.
Se dunque nei livelli istituzionalmente più
elevati e formalizzati del rito statale è evi-
dente la volontà di inserirsi all’interno delle
tradizioni religiose di derivazione faraonica
(non dimentichiamo che lo stesso Alessan-
dro Magno si farà proclamare dall’Oracolo di
Siwah “Figlio di Amon”), i ceti popolari con-
tinuano a celebrare riti e superstizioni infor-
mali e primitivi grazie ai quali si perpetuerà
nei secoli la forza vitale del paganesimo.
Sono infatti innumerevoli le testimonianze
di amuleti o rozze figurine di terracotta
delle divinità più popolari usate come por-
tafortuna, le suppliche quotidiane agli dei,
la devozione per gli animali ritenuti sacri, le
formule magiche per la protezione divina.
In numerosi casi assistiamo, inoltre, ad un
ampliamento del culto tradizionale di una
divinità egizia la quale assume significato
universale e si diffonde in tutto il paese con
caratteristiche non incompatibili a quelle at-
tribuite a livello locale. Nella ideologia tole-
maica, infatti, divinità come Horo, Iside,
Osiride, Amon, Hathor, Anubi, assumono
particolare rilievo divenendo onnipresenti.
Il culto della dea Iside, in particolare, suscitò
un particolare interesse anche oltre i confini
della Valle del Nilo diffondendosi, nel corso
del periodo romano, in ogni parte del mondo
mediterraneo ed esercitando, allo stesso
tempo, una duratura influenza sull’arte e
sulla letteratura. Madre di Horo e sposa di
Osiride, la dea era inoltre un modello natu-
rale di identificazione per le donne della di-
nastia tolemaica: la stessa Cleopatra VII
venne salutata a Roma come manifesta-
zione di Iside.
Ma è soprattutto nei templi dei villaggi e
delle città che si focalizza la devozione po-
polare. E’ infatti sufficiente analizzare il nu-
mero e l’importanza dei luoghi di culto,
anche di importanza secondaria, per com-
prendere pienamente il ruolo da essi svolto
C U L T U R A
Figura 7 - Wadi el-Sebu'a, rappresentazione di San Pietro accom-
pagnata dall'iscrizione greca con il suo nome.
Figura 8 - Frammento in pietra con rilievo raffigurante la Vergine
Maria fra due santi mentre allatta il Bambino. La scena rivela
l'influenza dell'Isis Lactans egizia.


















