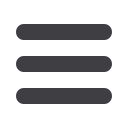
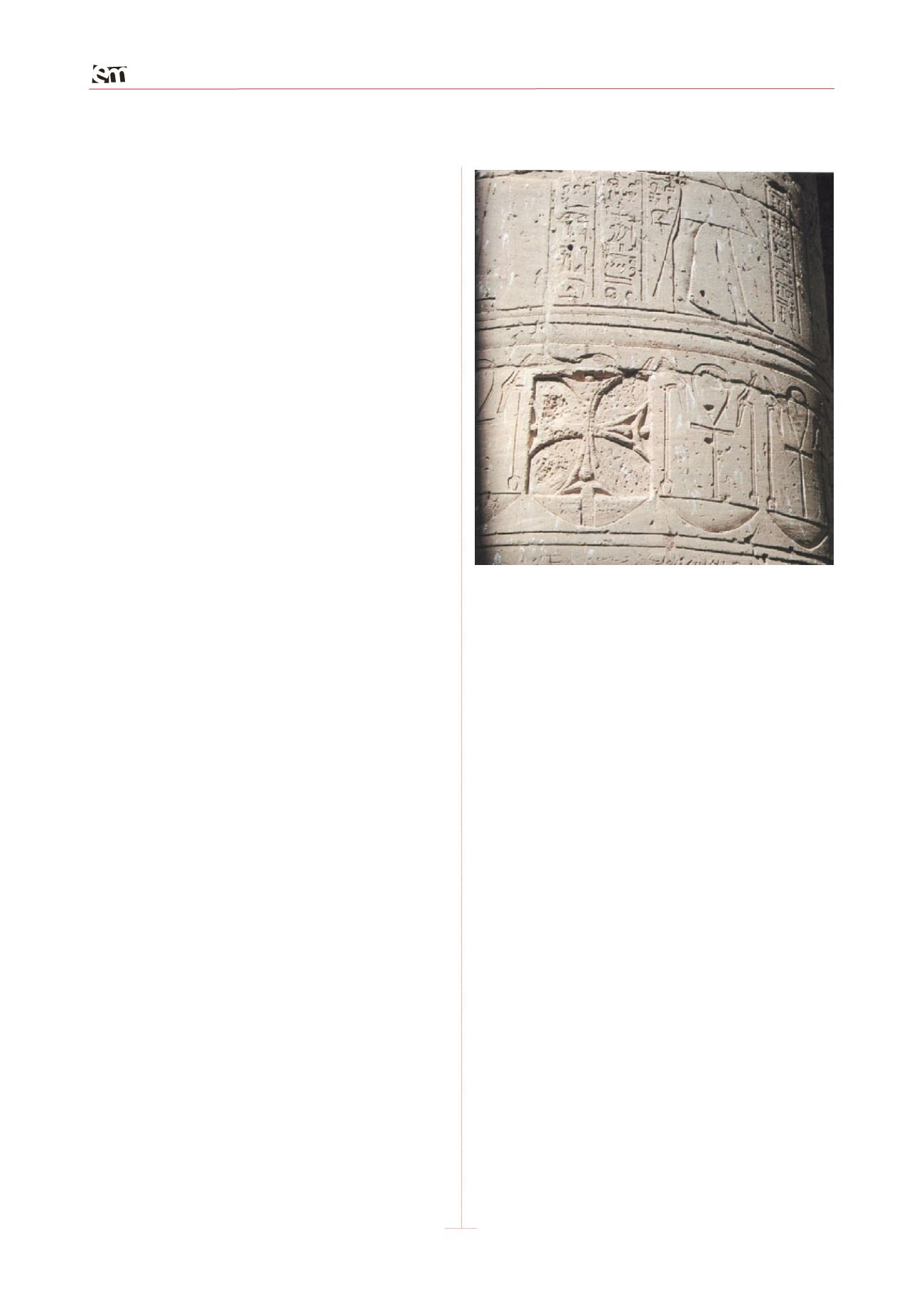
16
della Capitale, appannaggio di eruditi ed
uomini di cultura, quello che, ad ogni modo,
più tenacemente sopravviveva tra la popo-
lazione, soprattutto nelle aree più periferi-
che, era l’antichissimo paganesimo egiziano
che si aggrappava tenacemente, ed ormai
disperatamente, agli ultimi templi ancora
non sfregiati dal fanatismo cristiano. Tutta-
via la sorte del paganesimo era ormai se-
gnata, le misure repressive dei patriarchi e
le spedizioni imperiali volte alla conver-
sione della Nubia, oltre il confine meridio-
nale dell’Egitto, lo videro ridursi
drasticamente. Dietro tali spedizioni, ovvia-
mente, vi erano pressanti necessità volte
alla tutela della stabilità imperiale: la pres-
sione esercitata dalle popolazioni nomadi
sulla regione meridionale delle Cateratte
era infatti vista come uno dei principali fat-
tori di instabilità del potere centrale. L’en-
tità del pericolo che essi potevano
rappresentare per l’Egitto meridionale può
essere valutata da un appello del Vescovo
di Siene, il quale invoca protezione per le
sue chiese costantemente minacciate dai
Blemmi. Altre fonti invece riportano un as-
sedio, sempre perpetrato dai Blemmi, al Mo-
nastero Bianco di Shenute, il quale
mantenne per tre mesi un totale di venti-
mila rifugiati. Piegare queste popolazioni al
Cristianesimo assumeva in quest’ottica un
forte significato politico: significava sotto-
metterle al potere teocratico dell’impera-
tore il quale, a sua volta, poteva assicurarsi
un controllo stabile sulla ricca regione nu-
biana e sul deserto orientale, tra il Nilo ed il
Mar Rosso, terra di ricche miniere d’oro e
smeraldi.
Il 531, anno in cui un decreto di Giustiniano
ordina la definitiva chiusura del tempio di
Philae, ultimo baluardo della cultura pa-
gana in terra d’Egitto, la cui apertura era
stata garantita fino allora dagli stessi
Blemmi, assume dunque un profondo signi-
ficato simbolico: segna la fine del pagane-
simo nella Valle del Nilo e la vittoria di un
Cristianesimo che, con la conversione delle
tribù nubiane, estenderà la propria in-
fluenza fino all’Etiopia.
Se dunque nel VI secolo non vi erano più
minacce esterne a minare la stabilità della
comunità cristiana, fermenti di disgrega-
zione stavano iniziando a germogliare pro-
prio all’interno della stessa. Con
l’incremento del numero dei fedeli e dell’im-
portanza politica delle istituzioni ecclesia-
stiche sorsero infatti scissioni ed
intolleranze che frantumarono, spesso in
modo irreversibile, l’univocità dell’ortodos-
sia cristiana.
Le dispute dottrinali sulla natura cristolo-
gica, concretizzate nelle dottrine manichee,
gnostiche e, soprattutto ariane, assunsero
presto valenza politica: si avverte, soprat-
tutto nelle deliberazioni del Concilio di
Nicea (325 d.C) e nella condanna della dot-
trina ariana, la necessità di ribadire e riaf-
fermare l’importanza ecumenica del
patriarca egiziano che, di fatto, sentiva di-
minuire il proprio prestigio di fronte all’im-
portanza politica che stava acquisendo
Costantinopoli, assurta a Nuova Roma, ed
alle pretese di primato avanzate dal ve-
scovo della Capitale dell’Impero.
La rottura definitiva tra Alessandria e Co-
C U L T U R A
Figura 4 - Croci copte sulle colonne della sala ipostila del tempio
di Philae.


















