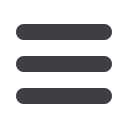

di donne potè accedere all’Università del Cairo.
E’ proprio tra il 1870 e il 1890 che si inizia a parlare
di emancipazione femminile come elemento ne-
cessario allo sviluppo dei paesi arabi e dunque di
istruzione femminile. Non si può dimenticare, a tal
proposito, che il dibattito sulla condizione della
donna a inizio Novecento è per lo più portato
avanti da uomini. Solo a partire dagli anni Venti
dello stesso secolo si ha la nascita delle prime as-
sociazioni di donne. E’ proprio in questo momento
storico che nascono anche i primi salotti letterari
in Medio Oriente e appaiono molte riviste e opere
letterarie femminili. Proprio sui giornali diretti e
scritti da donne e che si rivolgono ad un pubblico
femminile vengono elaborati i primi discorsi fem-
ministi.
La prima di queste riviste
“Al-Fata”
(La ragazza) fu
fondata ad Alessandria nel 1892 da Hind Nawfal.
L’Egitto è considerato la culla del movimento fem-
minista in Medio Oriente e il paese arabo in cui
questo movimento si sviluppò maggiormente.
Comunque in tutto il mondo arabo la liberazione
della donna e la liberazione della nazione erano
progetti che andavano di pari passo. I discorsi fem-
ministi erano spesso intrisi di anticolonialismo. Le
attiviste ritenevano che l’emancipazione della
donna si potesse realizzare solo attraverso l’affer-
mazione di Stati indipendenti.
Il femminismo islamico e la religione
Le cause che hanno contribuito all’affermazione
del femminismo islamico sono tre: l’opposizione
all’islamismo nelle sue forme più retrograde e pa-
triarcali; la critica all’Occidente e all’universalismo
dei diritti di cui il femminismo occidentale è una
delle espressioni; il riaffermarsi della religione
nell’ambito pubblico e privato.
Per molte donne, dunque, la religione è divenuta
uno strumento per conquistare diritti e spazi nella
società e il femminismo islamico il collante che
tiene insieme diverse identità: essere donna, mu-
sulmana, praticante e protagonista della realtà
storica e sociale.
A tal proposito alla fine degli anni Ottanta del No-
vecento si è andato diffondendo l’uso di rileggere
in gruppo il Corano e altri testi importanti della tra-
dizione islamica. Dagli incontri nelle case private
si è passati a riunione nelle moschee. In Egitto, per
esempio, le donne hanno ancora l’abitudine di in-
contrarsi in alcune moschee cairote per studiare
le sacre scritture senza l’intermediazionemaschile
e facendosi guidare da studiose formatesi in pre-
stigiose università come quella di Al-Azhar al Cairo.
Come si è già detto, il movimento islamico si basa
sul principio che l’Islam sia dalla parte delle donne,
ma a causa di una distorsione nella lettura dei testi
sacri, questa verità è rimasta nascosta tra le pa-
role del Corano. Ristrette élite maschili si sono ar-
rogate il diritto di interpretare il messaggio reli-
gioso, negando il punto di vista femminile. La su-
bordinazione delle donne è il risultato della loro
esclusione dalla formazione della giurisprudenza
islamica e dall’occultamento del loro ruolo soprat-
tutto nel VII secolo d. C, cioè alla nascita dell’Islam.
Le attiviste e le teologhe sostengono che non biso-
gna confondere le leggi attualmente in vigore con
il concetto di
“shari’a”
: infatti le prime sono produ-
zioni umane e quindi soggette all’errore, mentre
la seconda rappresenta la volontà divina che è
eterna e immodificabile. Dunque sono le leggi ad
essere patriarcali e non la
shari’a
e di conseguenza
non ci sono letture del Corano “corrette” per ogni
epoca. Al contrario: il libro sacro deve essere in-
terpretato alla luce della realtà vigente. Solo la co-
munità formata da musulmani e musulmane può
decidere quale interpretazione vada accettata e
quale rifiutata e non una ristretta cerchia di uomini
autolegittimatasi a parlare in nome della religione.
Inoltre, secondo le femministe islamiche, Muham-
18
e g i t t o m o d e r n o


















