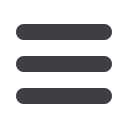

Accanto alle femministe islamiche si trovano atti-
viste, come l’egiziana Heba Raouf Hezzat e Nadia
Yassine, che affrontano un discorso di genere al-
l’interno di gruppi di militanza islamica. Non sono
esattamente definibili come femministe islamiche,
anche se queste donne, che ricoprono ruoli impor-
tanti in partiti politici e associazioni islamiste,
hanno influenzato il movimento femminista.
Le militanti islamiste hanno sradicato molti ste-
reotipi legati al ruolo della donne nella società
e hanno cercato risposte ai problemi della con-
dizione femminile in una cornice religiosa.
La riforma del codice di famiglia in Marocco
(“
mudawwana”
) ha rappresentato uno dei suc-
cessi del femminismo islamico, ma anche dell’at-
tivismo delle forze islamiste.
Nonostante la vicinanza tra i due movimenti, le
differenze politiche tra le femministe islamiche e
le islamiste sono notevoli: le prime vogliono af-
fermare un Islam progressista all’interno di strut-
ture di governo laiche, le seconde sono impegnate
nella realizzazione di Stati islamici, o almeno di
Stati influenzati dalla religione dal punto di vista
istituzionale. Ciò che è importante notare è che
per entrambi i gruppi la centralità dell’Islam non
implica un ritorno al passato, ma una reinvenzione
sociale alla luce delle nuove esigenze che caratte-
rizzano il XXI secolo.
La storia
Il femminismo nel mondo arabo nasce alla fine
dell’Ottocento, all’interno della
“Nahdah”,
il movi-
mento composto da intellettuali di diverse religioni
impegnati nella rinascita culturale dei paesi arabi
tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. E’ auto-
nomo dal femminismo occidentale, anche se ci
sono sempre state numerose interazioni tra attivi-
ste arabe e europee ed è caratterizzato da tratti
nazionalisti, indipendentisti e da una tendenza al
panarabismo.
I fattori che hanno portato alla nascita del femmi-
nismo arabo sono di due tipi: interni ed esterni.
Questi ultimi riguardano la penetrazione econo-
mica e culturale delle potenze europee e la critica
dei colonizzatori verso la condizione della donna.
I fattori interni, invece, sono legati al contesto so-
ciale in cui presero forma le prime lotte per
l’emancipazione femminile. Infatti nelle città del-
l’Impero ottomano, come in quelle egiziane, si pra-
ticava la segregazione sessuale. Alle donne delle
classi alte era imposta anche la reclusione: pote-
vano uscire raramente e solo coprendosi la testa e
il volto. La segregazione era simbolo di status so-
ciale e di prestigio. In realtà solo le donne bene-
stanti erano quasi totalmente escluse dalla vita
pubblica, poichè potevano permettersi di non la-
vorare e delegare alla servitù il compito di uscire
per svolgere mansioni domestiche.
Le donne delle classi inferiori non potevano rima-
nere in casa e dunque si velavano e uscivano, ma
solo per sbrigare gli impegni strettamente neces-
sari. Le contadine, invece, non si coprivano mai il
volto, in quanto il velo rappresentava un ostacolo al
lavoro.
A questa situazione si aggiungeva la condizione di
ignoranza che accomunava le donne di tutte le
classi sociali. Le donne hanno cominciato a stu-
diare solo dalla seconda metà del XIX secolo: in
casa e con precettori di solito europei quelle ap-
partenenti alle classi alte; in scuole pubbliche
quelle dei ceti medi.
Infatti in Egitto la prima scuola di Stato per ra-
gazze aprì nel 1873, ma vi erano già scuole femmi-
nili private, legate alle missioni cristiane o al
mondo islamico. Solo nel 1929 un ristretto gruppo
17
e g i t t o m o d e r n o


















