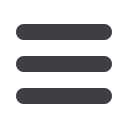

A
N
G
O
L
O
D
I
F
I
L
O
L
O
G
I
A
21
venne terminato in alcune sue parti ancora in-
compiute con l’inserimento di in grandioso
scalone, ad opera dell’architetto Giuseppe
Maria Talucchi
6
(1782 -1863).
Ora, con il prossimo spostamento della Galle-
ria Sabauda, partiranno i lavori di ristruttura-
zione che modificheranno completamente
l’esposizione dei reperti egizi.
Parlare della storia del palazzo significa par-
tire dalle origini romane di Torino. Come testè
detto l’edifico è secentesco, ma insisteva su
un’area che presentava già un utilizzo prece-
dente con un notevole impianto stratigrafico.
Visitando le sale, ora chiuse al pubblico per il
sempre imminente inizio dei lavori di amplia-
mento, dei sotterranei del museo (dov’erano
esposte, a beneficio di chi non abbia ancora
avuto modo di visitare le collezioni torinesi, le
sepolture dei nomarchi, in primis Dyefahapi e
le magnifiche tele provenienti da Gebelein,
nonchè il sarcofago di Iqer, del Medio Regno,
recante un passo dei cosiddetti “testi dei sar-
cofagi”) ci si imbatteva, sulla sinistra proce-
dendo verso il termine dell’ampio salone, in un
muro.
In molti domandavano di cosa si trattasse. Eb-
bene, questo muro costituisce parte della cinta
muraria dell’antica Augusta Taurinorum (nome
latino di Torino), fondata in età Augustea (30
a.C – 14 d.C.). Le mura avevano uno spessore di
circa 2,50 metri ed un altezza pressapoco di 7
metri e delimitavano un perimetro rettango-
lare di m 770X710, smussato all’angolo Nord-
Ovest.
Il muro è realizzato in opera cementizia. La
parte superiore presentava un filare in mat-
toni, asportato in epoca imprecisata. Come in
ogni castrum romano sulle mura si aprivano
quattro porte (Porta Praetoria, Porta Principa-
lis Sinistra, Porta Decumana e Porta Principa-
lis Dextera). Da qui partivano gli assi principali
viari (cardo, da nord a sud e decumano, da est
ad ovest). Agli angoli delle mura ed ad inter-
valli di otto metri erano presenti delle torri di
guardia.
Nel momento in cui il visitatore era nel sotter-
raneo, estasiato dinanzi alla bellezza dei re-
perti ivi esposti, si trovava al di fuori della
Torino romana.
Con la caduta dell’impero romano anche que-
st’area è abbandonata e subisce un rapido de-
grado.
In epoca medievale sui resti delle mura, ormai
quasi invisibili ed in buona parte interrati, si in-
sedia una taverna, con tutti gli annessi ed i
connessi delle taverne medievali. Ecco quindi
che potremmo immaginare scene di vita quo-
tidiana, con viandanti che giungono dal più o
meno lungo viaggio, chiedere all’oste un pasto
ed una stanza per dormire oppure, con fare
ammiccante, l’indicazione di qualche ragazza
per allietar la notte del solitario ramingo.
Della taverna sono rimaste delle porte, copia
delle quali è esposta sopra il muro romano,
dietro l’ascensore. Ecco quindi vedere dipinto
un monaco grassottello mentre sta entrando
in taverna e, nella porta di fianco, una corpu-
lenta ostessa.
Passano gli anni, la taverna viene abbando-
nata e rasa al suolo, ed eccoci giungere nel pe-
riodo secentesco con il sorgere sopra le sue
ceneri di un collegio di Gesuiti: il Collegio dei
Nobili. Divertente notare che nel luogo di per-
dizione (la taverna medievale, con lo stuolo di
prostitute) sorge adesso un luogo di preghiera!
Ecco quindi partire i lavori all’erigendo Palazzo
dei Nobili nel 1679, sotto la direzione dell’archi-
tetto Michelangelo Garove, su progetto del-
l’abate teatino Guarini, col patrocinio di Carlo
Emanuele III
7
(1701-1773).
1 Carlo Felice fu Re di Sardegna dal 1821 sino alla morte
2 Fu un numismatico. Nel 1823 fu chiamato a far parte della commis-
sione incaricata di catalogare la collezione Drovetti.
3 Bernardino Drovetti: fu ufficiale dell’esercito Napoleonico durante la
campagna d’Egitto. In seguito svolse l’attività di console fran-
cese in Egitto. Fu grande collezionista di antichità, raccolte prin-
cipalmente nell’area tebana, che costituirono il nucleo dei musei
di Torino, Parigi e Londra.
4 Architetto e teorico dell’architettura. Fu tra le figure principali del
barocco. Fu altresì autore di alcune opere di matematica e filosofia.
5 Lavorò sotto i Savoia come urbanista ed architetto ducale. Realizzò
l’altare maggiore della Chiesa di San Filippo a Torino.
6 Architetto. Fu autore di alcune tra le opere più significative di archi-
tettura neoclassica in Piemonte.
7 Detto il Laborioso e soprannominato dai piemontesi Carlin. Re di
Sardegna, duca di Savoia, marchese di Monferrato.


















