
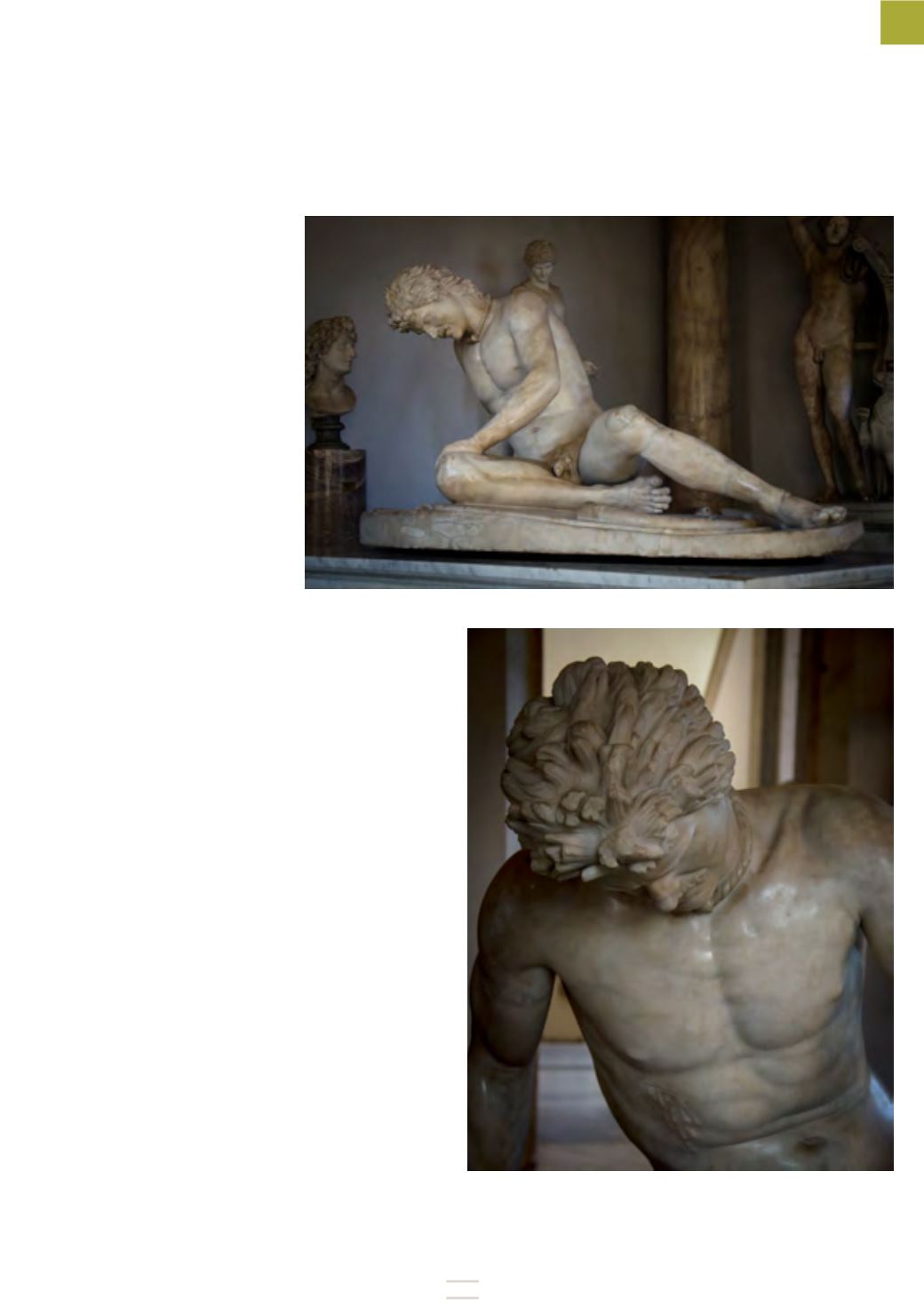
107
tini e poi i Selgiuchidi nell’alto Medio Evo, portarono a un generale disfa-
cimento del tessuto sociale pergameno, anche se una lettera ricevuta
dallo storiografo Georgios Acropolites da parte del futuro imperatore
bizantino Teodoro II Lascaris, databile intorno al 1250, contiene un reso-
conto entusiasta sulla qualità e la quantità delle opere che aveva potuto
ammirare a Pergamo, di cui fa un minuzioso elenco. Anche il
pater anti-
quitatis
Ciriaco di Ancona visitò
Pergamo per ben due volte (1431
e 1444), descrivendo con grande
emozione quel luogo che ancora
doveva avere gran parte delle
sue strutture quasi integre e i
viaggiatori dei secoli XVII e XVIII
non mancarono quasi mai di in-
serire nel loro itinerario il sito
dell’antica città della Misia.
Conclusioni
Abbiamo fin qui parlato in preva-
lenza delle attività politiche e mi-
litari che hanno portato Perga-
mo ad essere uno dei più
prestigiosi regni del periodo elle-
nistico. E prima di parlare dell’ar-
chitettura pergamena e poi nello
specifico del Grande Altare di
Pergamo (che verranno trattati nel prossimo numero
del magazine), è necessario fare cenno all’impegno
che la dinastia Attalide profuse - non meno di quanto
fece per le attività belliche - a favore dell’arte, della
scienza e delle lettere, accogliendo a corte personaggi
illustri e colti a cui diede protezione, come assai più
tardi fecero i Medici, ai quali gli Attalidi non di rado
sono associati. Eumene poteva vantare una solida
amicizia con Licone, discepolo di Stratone di Lampsa-
co al quale successe come scolarca nella scuola peri-
patetica fondata da Aristotele, e con Arcesilao di Pita-
ne, scolarca dell’Accademia Platonica. Del successore
di quest’ultimo, Lacide, era invece in rapporti di amici-
zia Attalo I. I sovrani illuminati di Pergamo posero
quindi le condizioni affinché il loro regno diventasse
uno dei centri di maggiore spiritualità ellenistica, riva-
leggiando in questo con Alessandria e Antiochia. Al
centro di questa attività, focolare e motore attivo di
questo movimento culturale, vi era senza dubbio la
biblioteca pergamena, che descriveremo architettoni-
camente nel corso della seconda parte di questo arti-
colo, fondata da Eumene e arricchita da ogni sovrano
che gli è succeduto. La rivalità con la più celebre Bi-
blioteca alessandrina alimentò aneddoti al limite del
vero, anche se non vi è dubbio che la nascita della
carta pergamena fu dovuta al desiderio degli Attalidi
di arginare l’uso del papiro, da cui dipendeva gran
parte dell’economia egiziana, grazie alle grandi quantità esportate so-
prattutto a Roma. Si narra ad esempio che Antonio, all’indomani del
Galata morente
Galata morente


















