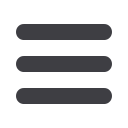
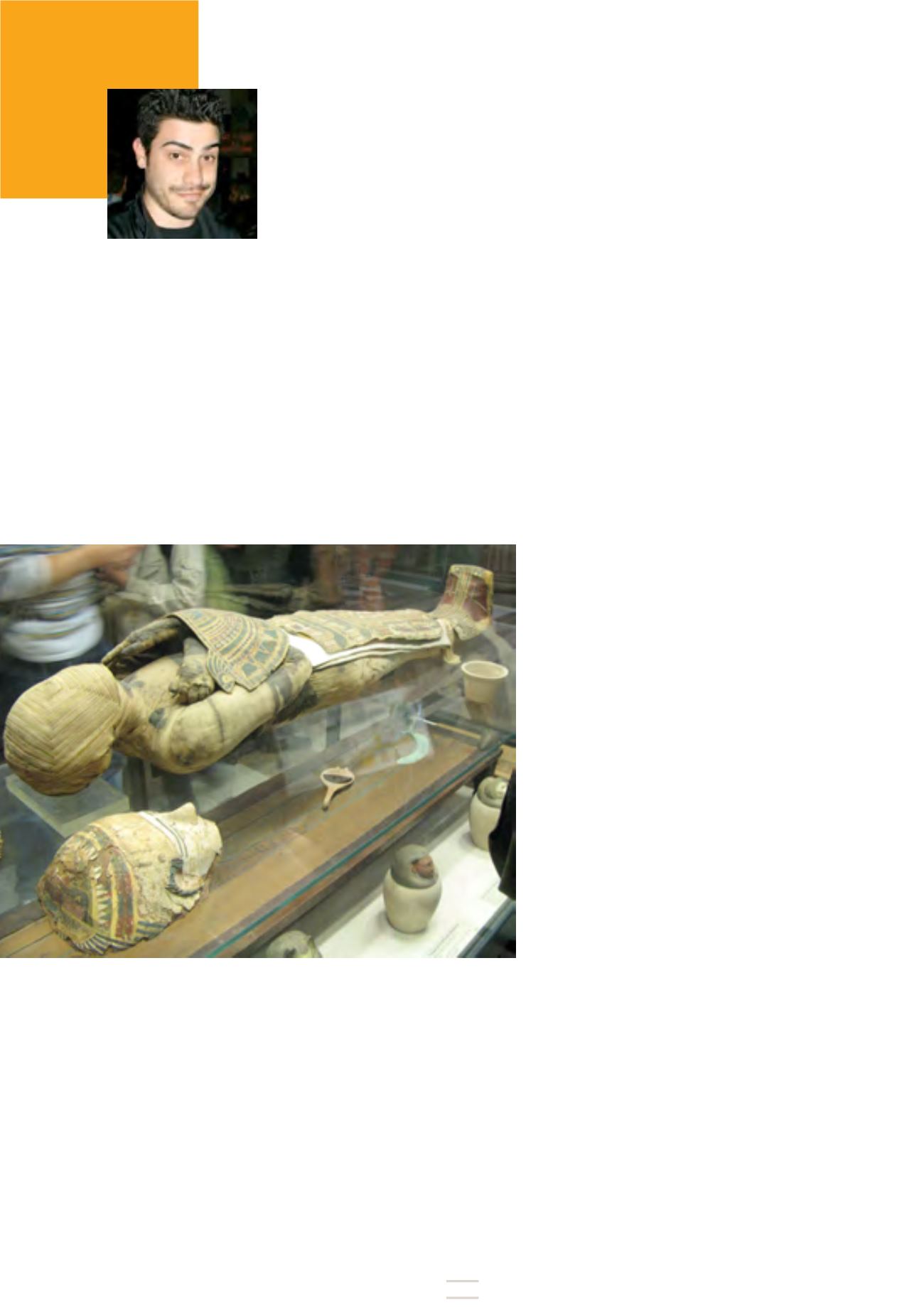
42
Mummie: è giusto esporre resti umani nei musei?
Mattia
Mancini
EGITTOLOGIA
È ancora in corso la mostra “
Ancient Lives: new discoveries
”, vero fenomeno mediatico dell’anno incentrato
sulle nuove analisi su otto tra le centinaia di mummie conservate presso il British Museum. Il successo che ha
avuto l’evento ha riacceso una disputa ideologica che s’infiamma ogni volta che viene organizzata un’esposi-
zione del genere: è giusto esporre resti umani nei musei? Si tratta del legittimo risultato di ricerche scientifiche
o dell’irrispettosa profanazione di cadaveri? Molti sono stati gli articoli scritti sull’argomento, così ho deciso di
cogliere l’occasione per riportare anche la mia personale opinione. Naturalmente, la presente riflessione si
concentrerà sul mondo dell’egittologia che è quello più vicino alla mia formazione, anche se il discorso potreb-
be essere allargato allemigliaia di collezioni archeologiche, antropologiche e di storia dellamedicina del mondo.
Prima di tutto, però, va fatta una considerazio-
ne generale sul rapporto che la società occi-
dentale ha avuto e tuttora ha con lamorte. Nel
corso della storia, si è quasi sempre cercato di
non mescolare l’ambito dei viventi con quello
dei defunti creando appositi luoghi, fuori dai
contesti abitativi, dove deporre le salme. Il mo-
tivo di fondo è semplice, cioè evitare che la de-
composizione dei corpi possa diffondere ma-
lattie contagiose o avvelenare le fonti d’acqua
e di cibo. Esistono delle eccezioni come le inu-
mazioni “casalinghe” nella Gerico neolitica o
come nel caso delle cosiddette “tribù delle
mummie” dei Dani, gruppi primitivi della Papua
Nuova Guinea che ancora oggi vivono con i
corpi imbalsamati dei loro antenati; ma, in ge-
nerale, le tombe sono sempre
extra moenia
.
Tale consuetudine è stata ufficializzata anche
da celebri provvedimenti legislativi, tra cui
spiccano la
Tavola X
delle duodecim
tabula-
rum leges
del 451-450 a.C. («
Hominem mortu-
um in urbe ne sepelito neve urito
») e l’
Editto di
Saint Cloud
emanato da Napoleone Bonaparte nel 1804 e ispiratore del carme “
Dei Sepolcri
” di Ugo Foscolo.
Oltre alle basilari motivazioni igienico-sanitarie, sono fondamentali anche i retaggi culturali e religiosi che hanno
plasmato il nostro rapporto con la morte. Il Cristianesimo predica la sacralità del corpo umano come dono di
Dio; per questo, la cremazione è mal vista o addirittura vietata in previsione della resurrezione finale dopo il
Giudizio Universale. Tuttavia, è possibile trovare casi a parte anche nel Cattolicesimo, come nel
Convento dei
Frati Minori Cappuccini
di Via Veneto a Roma, dove le ossa dei monaci sono state utilizzate per secoli come
semplice materiale da costruzione per realizzare decorazioni architettoniche. Qui, il corpo era considerato un
semplice involucro dell’anima, senza alcuna importanza dopo il trapasso.
Se avessero conosciuto il loro destino, molti Egizi avrebbero preferito la stessa sorte di questi frati romani. Fin
dall’antichità, infatti, i tombaroli smembrano o danno alle fiamme le mummie per raggiungere più facilmente i
preziosi amuleti in esse contenuti. A partire dal Medioevo, invece, i corpi imbalsamati erano commerciati in
Mummia di età tolemaica (III-II sec. a.C.), Louvre, Département des Antiquités égyptiennes.
fonte:
commons.wikimedia.org/wiki/

















