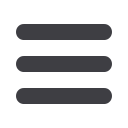
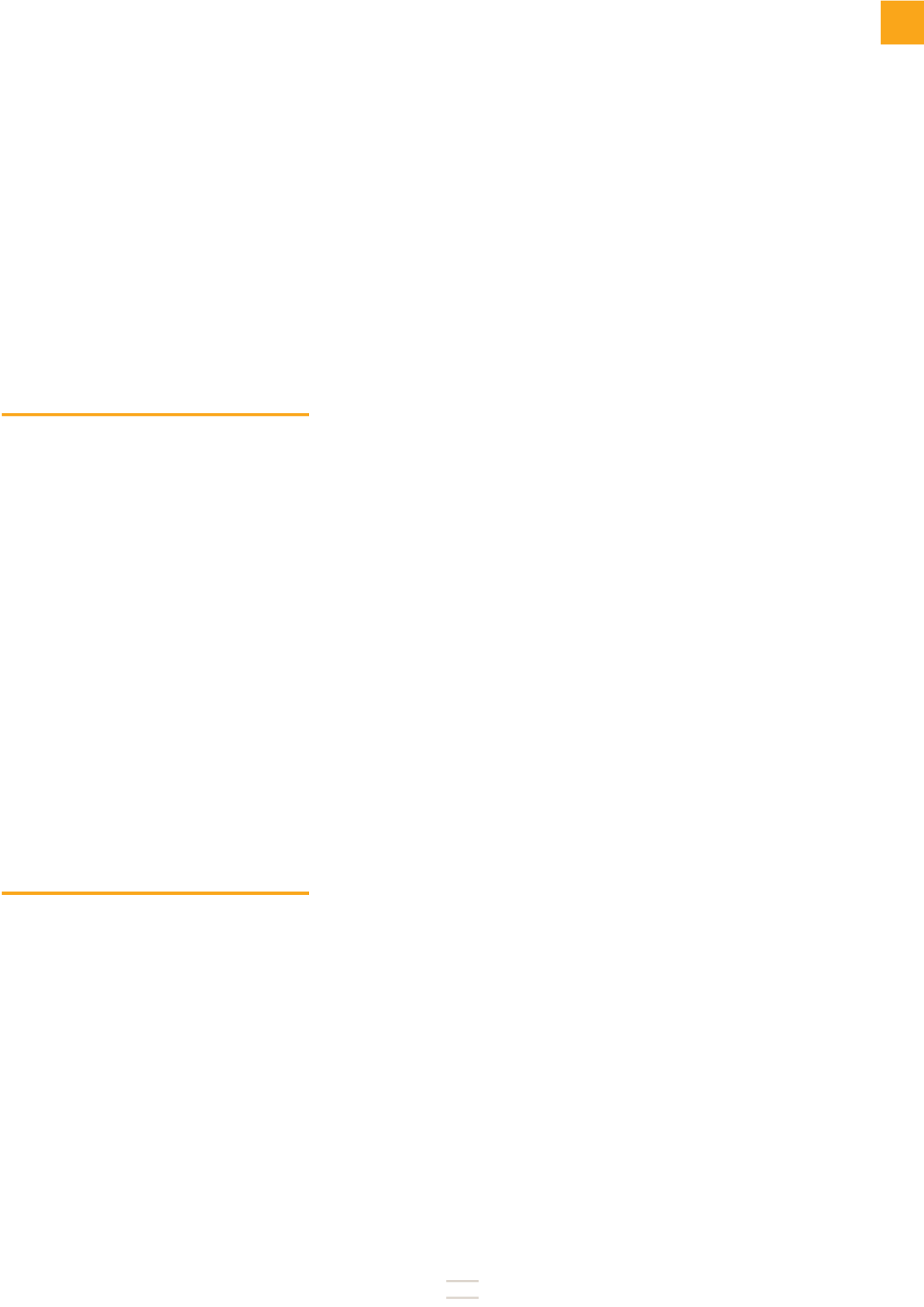
39
Ripariafu risolto deviando il corso del fiume e rettificandone il traccia-
to. Il cimitero prende il nome di “monumentale”
5
proprio per i numerosi
monumenti e le numerose opere d’arte presenti al suo interno. Proprio
per questo motivo la Comunità Europea inserì il Monumentale torinese
nel volume “Arte e Architettura funeraria”, insieme a quelli di Dublino,
Madrid e Genova. Il sarcofago di cui parleremo è oggi noto come sarco-
fago “Parvis”, dal nome dell’ultimo proprietario. Nella foto 1 è raffigurato
il monumento in questione.
Per un qualche astruso motivo non compare in nessuna delle guide ai
monumenti del cimitero sinora pubblicate, però è menzionato nel Ca-
talogo dei Beni Culturali pubblicato dalla Soprintendenza Archeologica
del Piemonte. Attualmente il sarcofago non funge da sepoltura: infatti
è semplicemente appoggiato sulla copertura di una cripta, segnalando
quindi solo la presenza di una tomba: si potrebbe quindi considerare
come una “stele”. Il materiale di costruzione è il granito rosa proveniente
dalle cave di Assuan, la forma è quella di un parallelepipedo. Si tratta
di un blocco unico: è probabile che dalla cava venne estratto un unico
blocco dal quale, al termine della lavorazione, vennero ricavati sia il sar-
cofago che il coperchio. Una recente misurazione ha confermato i vecchi
dati: 2,40 metri di lunghezza, 1,10 di larghezza e 1,25 metri di altezza. Si
tratta di un sarcofago anepigrafe, con tutte le facce lisce e senza alcuna
decorazione. Nonostante sia da più di cent’anni esposto alle intemperie
la conservazione è molto buona. In epoca recente, fatta incidere dal Par-
vis, un’iscrizione ricorda come lo stesso Giuseppe Parvis, di cui in seguito
parleremo, si distinse per le sue gesta in Egitto. Il sarcofago presenta
le caratteristiche dei sarcofagi litici dell’Antico Regno: a suffragare que-
sta datazione è il confronto con quello esposto nel Museo Egizio di To-
rino, proveniente dalla mastaba 44 di El-Giza e scoperto dal Lepsius, di
dwA-n-Ra
6
“Dua-en-Ra” che fu uno dei figli del sovrano Chefren. E’ quindi
probabile che quello del Parvis provenga da un laboratorio reale attivo
durante il regno di questo sovrano. Sicuramente il defunto seppellito in
origine faceva parte della corte del faraone: solo a questi personaggi era
infatti concesso il privilegio di farsi inumare nei pressi della tomba reale;
inoltre l’utilizzo del granito proveniente da Assuan era prerogativa di chi
apparteneva alla famiglia del re: molto rari sono i casi di utilizzo di que-
sto materiale da parte di personaggi non facenti parte della famiglia del
sovrano. Generalmente i sarcofagi in pietra presentano una cassa mo-
nolitica chiusa da un coperchio, anch’esso monolitico. Essendo il costo,
tra lavorazione e trasporto, decisamente elevato e quindi praticamente
impossibile da affrontare per un qualsiasi privato, anche se di alto rango,
sia la tomba che il sarcofago erano doni del sovrano. Di ciò ne è testimo-
nianza un’iscrizione presente nel sarcofago di
Mr.S-anx
III nella quale si
legge che l’intera sepoltura venne donata dalla mamma della defunta, la
regina
htp-Hr.S
II
7
.
Nell’Antico Regno i blocchi per la costruzione dei sar-
cofagi di granito non erano estratti direttamente dalla roccia viva, tecnica
che sembrerebbe essere iniziata solo nel Medio Regno, ma si lavorava su
pietre già staccatasi in maniera naturale. Su questi massi veniva eviden-
ziato il contorno del futuro sarcofago mediante piccole cavità, nelle quali
venivano in seguito inseriti cunei di legno bagnati con acqua che, gonfiati
dall’umidità, producevano delle fratture nella pietra
8
.
5 Tale nome è relativamente recente: infatti fu alla metà degli anni ’80 del secolo scorso che l’allora assessore ai cimiteri, Beppe Lodi, propose in
giunta la nuova denominazione.
6 Suppl. 1839, 1839.
7 Regina nel corso della IV dinastia, moglie del sovrano Djedefra. Di questo sovrano poche sono le notizie giunte sino a noi: il Canone Reale, esposto
a Torino, gli attribuisce solo 8 anni di Regno.
8 Tracce di questa tecnica si possono ancora scoprire in molte cave, in primis quelle di Assuan.
"Per un qualche
astruso motivo
non compare
in nessuna
delle guide ai
monumenti del
cimitero sinora
pubblicate, però
è menzionato
nel Catalogo dei
Beni Culturali
pubblicato dalla
Soprintendenza
Archeologica del
Piemonte."


















