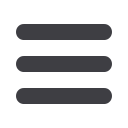

20
Mi piaceva studiare, mi piaceva insegnare, ho sulla coscienza un esercito di studenti e molti ottimi scolari, alcu-
ni dei quali esercitano o hanno esercitato la disciplina egittologica in varie università, altri sono anche attivi in
modo eccellente nell’archeologia in Egitto. Ora che sono Emerita ho potuto lasciare a Pisa la mia eredità di
cattedra di prima fascia a una allieva e collega, anzi ci sono a Pisa due colleghe egittologhe, Marilina Betrò e
Flora Silvano, ricercatrice e archeologa. Penso di aver dato un esempio di coraggio e un buon contributo alla
ricerca scientifica con l’aver fondato nel 1978 la rivista, che ancora oggi dirigo e che è arrivata al vol. 36, “Egitto
e Vicino Oriente” (EVO), specchio dell’unità scientifica per l’area mediterranea antica nell’Università di Pisa che
dagli anni ’70 era divenuta la sede universitaria italiana dove erano rappresentate le più importanti discipline
orientalistiche.
L’Università italiana negli ultimi anni ha subìto profondi mutamenti che generalmente vengono consi-
derati in modo negativo. Sentiamo continuamente fare riferimento all’estero come unica soluzione per
ottenere una formazione adeguata alle aspettative dello studente. Come vede lei oggi l’Università italiana
e qual è il suo pensiero riguardo alla tentazione di andare a studiare altrove?
Ho già detto quanto debba ai miei soggiorni presso università straniere. Considero un privilegio aver avuto
maestri in Italia e in Europa e in Egitto; li ricordo non solo per il docet accademico ma in molti casi anche per
le loro qualità di esempi morali oltre che scientifici. Dico dunque ai nostri giovani che una formazione all’estero
è un’esperienza assolutamente positiva, dopo aver ben saputo ricavare conoscenza e metodi già in Italia pres-
so le nostre università e istituzioni, anche coi grandi limiti che le recenti politiche universitarie hanno causato.
Se non erro nel 1966 l’Universi-
tà di Pisa comincia la sua avven-
tura di scavo in Egitto, ereditan-
do da Achille Vogliano gli scavi a
Medinet Madi dove, negli anni
che precedettero il secondo
conflitto mondiale, già aveva ri-
trovato i resti di un tempio risa-
lente al regno di Amenemhat III
dedicato a Renenutet e Sobek.
Per una decina di anni l’ateneo
pisano e quello milanese, da cui
dipendeva il Vogliano prima di
trasferirsi a Berlino, hanno col-
laborato assieme. Lei ha par-
tecipato come protagonista a
questa attività sul campo, alla
sua organizzazione – congiunta
prima e in solitaria poi – , get-
tando i presupposti per quella
che diventerà poi una sistema-
tica attività di scavo. Cosa ci
racconta di quel periodo? Come
l’ha vissuto?
Bisogna che porti qualche aggiustamento a quanto lei scrive, nel senso che il 1966 è l’anno della ripresa dell’at-
tività archeologica a Medinet Madi da parte dell’Università di Milano; in questo sito del Fayum Achille Vogliano
aveva compiuto le sue grandi scoperte, tra il 1935 e il 1939, quando la seconda guerra mondiale lo costrinse a
sospendere l’attività. Io entro in questa storia in quanto mi fu chiesto di essere il direttore responsabile degli
scavi a Medinet Madi, quindi l’Università di Pisa entra in contatto con il Fayum tramite me, che ero docente di
egittologia dell’Università di Pisa. I lavori milanesi nel Fayum furono interrotti nel 1969 a causa della situazione
bellica egiziana e gli scavi poterono riprendere in altri siti della valle del Nilo, nel 1970-71 ad Assuan, in collabo-
razione con il Centre de Documentation et d’Étude sur l’Égypte ancienne (CEDAE) del Cairo; fu studiata la strut-
tura architettonica e rilevate tutte le iscrizioni geroglifiche scolpite nel tempio (da datare ai regni di Tolomeo III
Cartina del Fayum


















