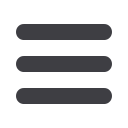

19
La prima donna egittologa in assoluto – nel senso ac-
cademico del termine – è stata Christiane Desroches
Noblecourt e lei, professoressa, è stata la prima donna
italiana a laurearsi in Egittologia. Al pari della
Noblecourt, alla sua laurea è seguita subito un’intensa
attività che l’ha portata a diventare una studiosa di li-
vellomondiale. L’essere donna è stato per lei un valore
aggiunto, oppure ha dovuto impiegare più energie per
trovare quella che doveva diventare la sua strada?
Non solo sono stata la prima donna laureata in egittolo-
gia, ma, a quanto mi risulta, la prima persona laureata
in egittologia in Italia e certamente anche la prima do-
cente donna nella disciplina. Ho conosciuto molto bene
Christiane Desroches Noblecourt, era una donna di tem-
pra eccezionale e che ha dato contributi insostituibili
all’archeologia. La mia carriera non è stata usuale per
una donna che nei primi anni cinquanta del secolo scor-
so si laureò sì in lettere, la facoltà considerata la più “femminile”, anzi
l’unica femminile, nel senso di “debole”, fra quante offriva l’università
italiana, e in una materia che allora (più di oggi certamente) era con-
siderata una “curiosità” più che una “scienza”: l’Egittologia, una disci-
plina che a metà del novecento era presente nell’offerta accademica
italiana solo con un insegnamento, e neppure di ruolo, all’Università
di Milano, mentre a Pisa esisteva soltanto un incarico gratuito; in am-
bedue gli atenei i corsi erano tenuti da Sergio Donadoni, uno dei miei
maestri, il quale ha festeggiato, pochi mesi fa, il suo centesimo com-
pleanno. Una cattedra di ruolo di Egittologia in Italia si ebbe solo nel
1958, contemporaneamente a Roma (per Giuseppe Botti) e a Milano
(per Sergio Donadoni); mentre a Pisa soltanto dopo dieci anni esatti
ne fu istituita una per me. Certo nel 1955 dovette apparire singolare
e fuor dal modello delle brave ragazze di famiglia borghese la mia
intraprendenza (qualità che mi differenziava dalla media delle lau‑
reate, ma anche dei laureati, va detto…), in quanto, nei tre anni suc-
cessivi la laurea pisana, andai all’estero alla ricerca di specializzazioni
nelle materie egittologiche (archeologia e filologia, ieratico e demotico
a Copenhagen, a Parigi e al Cairo, ma anche con “deviazioni” sull’ara-
maico delle colonie giudaiche e fenicie d’Egitto, miei interessi princi-
pali di allora e anche nel seguito), grazie anche alla comprensione e al
sostegno dei miei genitori (un pensiero speciale a mia madre, una
donna e una insegnante, di alto intelletto progressista) i quali aggiun-
sero il necessario alle tenuissime borse di studio disponibili allora e
mi aiutarono finché l’Egittologia non mi dette sufficiente pane e…
brioche. Furono fondamentali quegli anni di formazione all’estero, mi
permisero di assorbire presso specialisti quanto più possibile di cono-
scenze - di intessere una rete di rapporti umani e di colleganza - e di
abituarmi alla libertà anche intellettuale.
Lei ha vissuto l’università italiana sia come studentessa sia come do-
cente. Ha avuto maestri illustri e grazie al suo lavoro oggi abbiamo
egittologi capaci e preparati. Cosa ricorda volentieri, o anche mal vo-
lentieri se vuole, del suo periodo di formazione e cosa del periodo in
cui giovani studenti si sono formati grazie al suo impegno? Ci sono
aneddoti che vuole raccontarci?
Articolo di giornale che riporta l’esperienza di studiose italiane a Parigi, tra
le quali Edda Bresciani (in alto la seconda da sinistra)


















