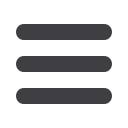

lizziamo i nserito nel discorso della produ -
zione, degli scambi commerciali, etc. etc. etc.,
cambia, almeno per me!
Torno a ll’immagine de ll’uomo co n in mano
uno spiedo e mi accorgo che ha un ventaglio
in mano.
Come si poteva modulare l’intensità del fuoco
per cuocere gli alimenti? La risposta è anche
in quell’immagine: con l’utilizzo di un venta-
glio (e vari altri espedienti). Cuocevano supie-
tra o consumavano i cibi crudi che andavano
mangiati cr udi. Cuocevano con la tecnica
dell’arrosto e del bollito, insomma, non di solo
pane e birra viveva l’abitante della Ta Mery e
sopratutto usava le pentole. Il discorso sui
forni per cuocere il pane è altrettanto avvin-
cente. E si parla sempre e solo di cibo!
Poi, c he gli Egizi avessero u n de bole pe r il
cibo (come tutti noi) mi sembra ampiamente
supportato dalle trac ce che loro stessi ci
hanno lasciato; inf atti, erano fermamente
convinti di doversi procurare il cibo suffi -
ciente per l’eternità e per farlo hanno escogi-
tato molt e s oluzioni, comprese quelle di
ricorrere alle formule magiche. Con fidando
che le parole si tramutassero in realtà, si affi-
davano a frasi scritte su papiro o su altro ma-
teriale, come : “Prendi il tuo pane che non
muffisce, la tu a bi rra che n on in acidisce!”.
Con la stessa speranza si delegava tale com-
pito alle rappresentazioni su pareti o ai mo -
dellini in l egno decorati di produttori di cibo:
il tutto finalizzato a soddisfare le esigenze
alimentari d el d efunto. R icorrere alla sfe ra
magica era più semplice che mettersi lì a pre-
parare i manicaretti e un modo per non ritro-
varsi senza scorte era qu ello di “Dire le
parole: Fame non venire da Teti. Vattene […]
poiché Teti è sazio; non ha fame Teti, per quel
pane di Horo c he e gli h a ma ngiato, che ha
preparato per lui la grande cuoca, perché egli
se ne saziasse e perché tornasse al suo stato.
Teti non ha sete […] Amset, Hapi, Duamutef e
Qebehsenuf [ i quattro figli d Ho rus nda] al-
lontanano qu esta fame che è n el ventre di
Teti, questa sete che è nelle labbra di Teti”.
Tutti i giorni presso la tomba del defunto do-
vevano essere portati cibi e bevande, affinché
venisse consumato il ban chetto ritu ale alla
sua presenza, che era garantita grazie a una
statua o alla stele d’offerta (prassi diversa a
seconda delle epoche). La stele, un elemento
verticale in p ietra decorato con le immagini
del defunto e con l’elenco preciso della quan-
tità di alimenti a sua disposizione, diventava
un elemento imprescindibile per la sopravvi-
venza nell’al di là.
Ricapitolando:
- cibo fisicamente portato dai vivi e lasciato
su tavole, bacili o altari d’offerta per officiare
il rito quotidiano;
- formule da recitare per allontanare lo spettro
della fame;
- attestazione di quanto spettante tramite la
stele.
A tutto questo, va aggiunto il cibo lasciato di-
rettamente nella camera del de funto: pani ,
carrube, frutti, carne di anatra seccata e sa-
lata, cosce di bue, birra, vino. E non è il solo
corredo del già citato Tutankamon a lasciarci
queste informazioni (pensiamo alla tomba di
Kha o degli Ignoti al Museo Egizio di Torino o
a tante altre sepolture).
L’eternità è l unga e l’appe tito vien m an-
giando.
Insomma, ricostruirò solo r icette, ma a ben
vedere, lo facevano già nell’antichità!
[Approccio m etodologico I II] Archeoricette
non nasce per essere una “rievocazione sto-
rica” e nella mia mente è molto chiaro il con-
fine tra comprensione e adattamento,
ricostruzione e rielaborazione, studio filolo-
gico e lavoro che si concretizza sui fornelli: se
possono essere ricostruiti i contesti con una
relativa credibilità è praticamente impossibile
la traduzione sul piano pratico dell’esperienza
dei sapori. Sono cambiati gli alimenti (anche
se sempre gli stessi) sono cambiati gli attrezzi
(anche se sempre gli stessi). Sono consape-
vole ch e l a fedeltà filolo gica no n sia l’ ele-
mento principale per rievocare un’emozione
o un gusto ed il tentativo è di fornire diversi
spunti pe r c omprendere “come poteva e s-
sere” : ecco il perché del contorno storico che
78
archeoricette


















