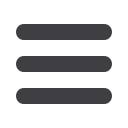
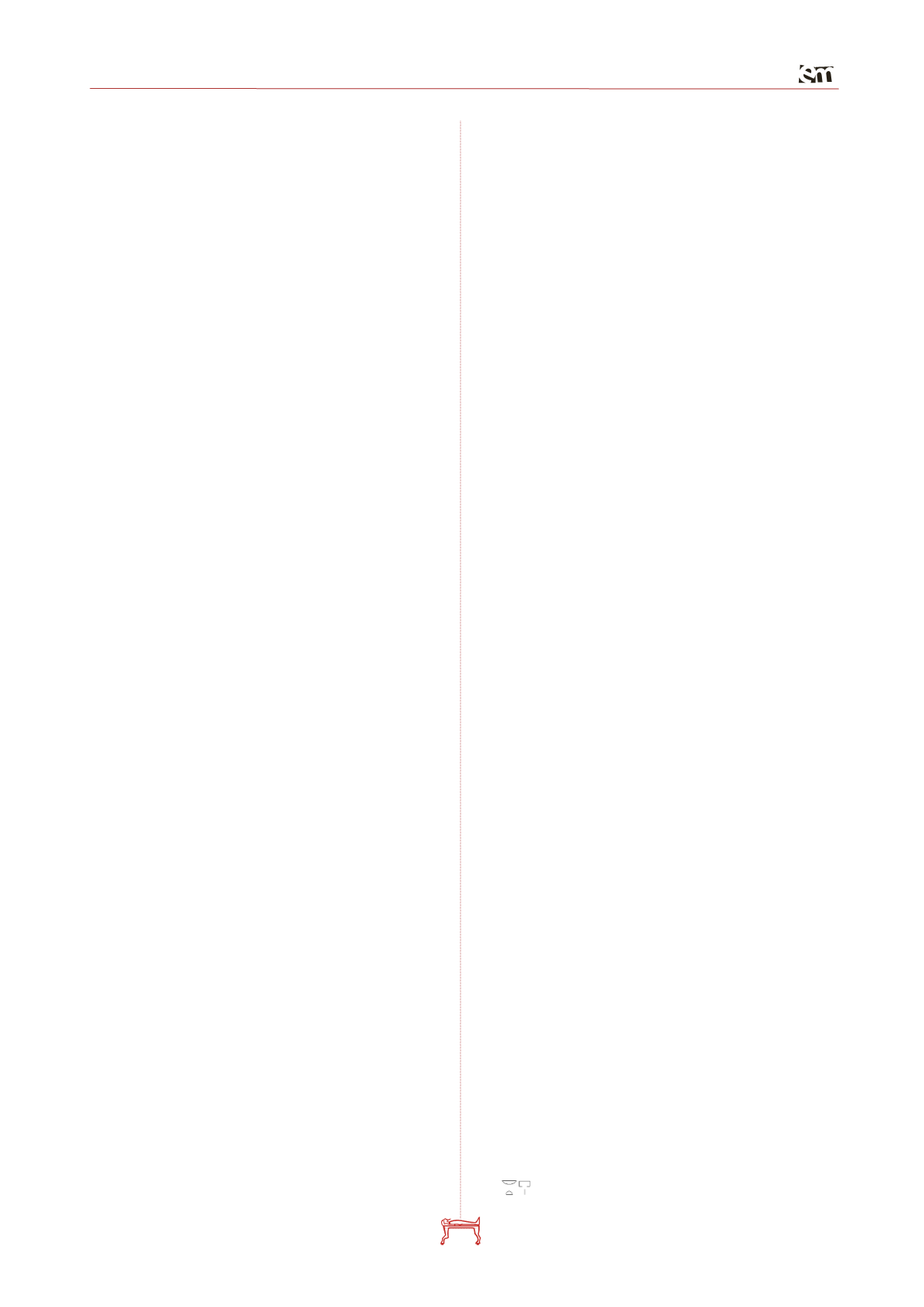
67
speciale deir el-medina
questa simbologia parrebbe rifarsi al capitolo
I del Libro dei Morti, nel quale si legge: “Inizio
dei capitoli dell’uscire di giorno, della celebra-
zione e glorificazione, dell’uscire e calare
nella necropoli. E’ una cosa utile nel bell’Occi-
dente, che si dice il giorno del seppellimento,
dell’entrare dopo l’uscire……
17
”. Per assicu-
rarsi la benevolenza degli dei, numerosi inni
erano scritti s ulle pareti. La costruzione d i
una tomba richiedeva numerosissima mano-
dopera
18
: oggigiorno siamo a conoscenza
delle tecniche costruttive grazie alle sepol-
ture reali ed ai progetti
19
pervenutici che te-
stimoniano, tra l’altro, l’eccezionale maestria
raggiunta dagli egizi del tempo. C onfron-
tando infatti il progetto su papiro con l’effet-
tiva esecuzione della tomba scopriamo che
questa si discosta di pochissimo dalla plani-
metria prevista. Pur non essendocene perve-
nuti è praticamente certo che anche per le
tombe pr ivate es istessero progetti similari.
Quasi tutte le tombe tebane, come quelle di
Pa demi, presentavano vivaci colori: essendo
l’egizio molto legato alle simbologie, ogni co-
lore aveva un di verso significato. Il nero è il
colore della terra bagnata dal limo del Nilo e
del mondo dell’oltretomba: Osiride è spesso
ritratto con la pelle nera. Il bianco è il simbolo
della purezza: ne lle p itture e rano i nfatti g li
stranieri ad indossare abiti dai molteplici co-
lori. Invece il rosso è utilizzato per rappresen-
tare la cattiva sorte e la paura più profonda:
il deserto è di questo colore. A volte il simbolo
del Basso Egitto, la corona rossa, viene raffi-
gurato dipinto di verde, per evitare che il co-
lore rosso possa nuocere al defunto. Il verde
simboleggia la rinascita: Osiride è spesso raf-
figurato così. Il blu è il colore del dio Amon: di
tale colore s pesso sono parrucche e barbe
delle divinità. Il giallo è il colore dell’immor-
talità. Per convenzione, nelle pitture, l’uomo è
ritratto di colore scuro, mentre la donna di co-
lore chiaro: ques to perché l’uomo opera al-
l’aria aperta, inv ece la d onna, e ssendo l a
signora della casa
20
si occupa delle faccende
domestiche. Le raffigurazioni tombali subi-
rono profondi cambiamenti, seguendo il va-
riare de lla s ocietà. Nell’epoca r amesside,
epoca che ci ha offerto il maggior numero di
ipogei, diminuiscono le scene di vita quoti-
diana a vantaggio di quelle legate all’aspetto
funerario. Nell’uomo egizio, infatti, si è instau-
rato un certo timore della morte, come si può
rilevare d alla co mparsa s ulle pa reti de lle
tombe di formule magiche tratte dal Libro dei
Morti. Si assiste ad un certo ritorno ai temi
dell’Antico Regno, anticipando in parte la di-
nastia XXVI: nelle iscrizioni tombali si esclu-
dono tut ti i s egni c he po trebbero a rrecare
danni al defunto e ciò vale anche per quanto
riguarda i faraoni. Il sovrano Sethi, nello scri-
vere il proprio nome, non utilizza il pericoloso
animale che rappresenta Seth, ma un animale
innocuo. Il malvagio serpente Apopi viene
raffigurato con pugnali conficcati nel corpo,
come nella già citata tomba dell’operaio In-
herkha (TT359), per impedirgli di nuocere in
alcun modo.
Gli ipogei degli operai sono situati su una col-
lina nel lato meridionale del villaggio. Le
tombe e rano d i pr oprietà deg li a bitanti e ,
come le abitazioni, potevano essere oggetto
di eredità e di vendita; nessun ipogeo o sup-
pellettile risulta essere un dono del faraone
salvo poche eccezioni. Tra queste l a tomba
TT8, appartenuta al sovrintendente dei lavori
Kha, rinvenuta intatta nel 1 906 da Ernesto
Schiaparelli e i cui reperti costituiscono una
delle più importanti sezioni del Museo Egizio
di Torino.
Ben presto la collina utilizzata per le sepol-
ture divenne interamente costellata di ipogei:
ciò causò la costruzione di alcune tombe
dalla forma inconsueta allo scopo di evitarne
altre precedenti. Il numero crescente di sepol-
ture contribuì a far nascere la piaga dei furti
al loro interno, perché le operazioni di con-
trollo si facevano sempre pi ù c omplesse.
Spesso a ccadeva che dur ante i la vori le
tombe venissero casualmente riaperte: nel
caso non risultasse nessuna sepoltura al suo
interno, ne diventava proprietario colui che
l’aveva aperta. Dalla lettura di ostraka e papiri
apprendiamo di una vera e propria “lotta” per
accaparrarsi tombe vuote: è divertente imma-
ginare ad esempio Pabak, probabilmente un
operaio, introdursi nella tomba con estrema
circospezione alla debole luce di una torcia,
17 ”Testi religiosi egizi”, a cura di S. Donadoni, pg. 155.
18 Nel prossimo numero si tratterà delle tecniche costrut-
tive e della manodopera utilizzata.
19 Uno di questi, in duplice copia, è esposto nel Museo
Egizio di Torino: si tratta della tomba di Ramesse IV.
20
"


















