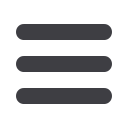

rirono misteriosamente ed al loro posto com-
parvero croci ansate dipinte che furono identi-
ficate dai cristiani come segno di salvezza.
Seppure permeata di elementi leggendari
che, ad un'analisi archeologica possono risul-
tare scarsamente attendibili, la testimonianza
di Rufino evidenzia un processo in atto che
portò alla rilettura ed all'assimilazione di ele-
menti stilistici ed iconografici desunti sia dal-
l'ambiente ellenistico tardo-antico, dal quale
era permeata la società egiziana dopo il pe-
riodo tolemaico-romano, sia da quel substrato
propriamente egizio che verrà progressiva-
mente svalutato dalla fase “augustea” per es-
sere relegato ad un livello sempre più
“etnografico”, ridotto ad esclusivo appannag-
gio delle classi subalterne.
Come sottolinea Sergio Donadoni nel suo
contributo in occasione del XXVIII Corso di Cul-
tura sull'Arte Ravennate e Bizantina, è inevita-
bile che la realtà locale tenda a regredire ed
appropriarsi della cultura altrui, quella che dà
prestigio ed il cui possesso permette di parte-
cipare ai vantaggi della borghesia urbana.
Gli stessi sacerdoti preposti all'ufficio degli
antichi culti, che per primi dovrebbero farsi de-
positari della tradizione, compaiono spesso in
statue alla maniera ellenistica, abbigliati con
abiti classici seguendo una tendenza opposta
a quella che si era verificata sotto i Tolomei. Le
immagini popolari di culto, dunque, escono
dagli schemi faraonici e ne acquisiscono di el-
lenizzati; “L'Egitto diviene elemento di esoti-
smo nel suo stesso paese, di cui si riescono ad
assumere temi iconografici specifici ma non
certo le qualità intime” (S.Donadoni, 1981).
L'antica cultura, divenuta isola di “arcaicità il-
lustre e pittoresca ma non vitale”, per quanto
accuratamente tenuta segregata e artificiosa-
mente carezzata, appare oramai partecipe di
una cultura e di un mondo che sono generica-
mente quelli mediterranei e romani.
Alla luce di tali considerazioni, come lo
stesso Donadoni conclude, è da escludere che
l'arte della comunità cristiana d'Egitto, dotata
di propri peculiari caratteri e linguaggio svilup-
patosi come realtà autonoma, venga giustifi-
cata nella definizione della sua personalità
dalla presenza nel paese di quella massa di po-
polazione di tradizione non greca che, con la
crisi della classicità, sarebbe finalmente riu-
scita a riaffermare le proprie esigenze cultu-
rali. Sarebbe dunque errato ritenere la vecchia
arte faraonica un fermento represso del potere
romano ma dotato di vitalità e vigore latente
che determinano una rinascita di antichi desi-
deri formali. Il mondo faraonico, le sue ideolo-
gie e le sue iconografie erano ormai in
inarrestabile declino, ridotte a semplici schemi
tipologici ed affidate alle classi più misere ed
incolte, pertanto condannate all'oblio.
Escluse sporadiche eccezioni, dunque, una
tale origine dell'arte copta deve essere ricon-
siderata; essa va intesa invece come la forma
assunta in Egitto dall'arte tardoclassica prima
e da quella bizantina poi, mentre le cadenze
del suo linguaggio devono essere considerate
alla luce della cultura imperiale alla quale
l'Egitto partecipa ormai interamente.
Sarebbe pertanto errato considerare una re-
altà complessa come quella che traspare dai
rilievi e dai dipinti copti come una semplice
propaggine dell'arte bizantina e tardoclassica.
In essa, infatti, convergono e si fondono molte-
plici esperienze dialettali che vanno dalle raf-
finatezze alessandrine della capitale fino alle
rustiche terrecotte popolaresche dei villaggi
egiziani ancora intrise delle ataviche remini-
scenze faraoniche.
Inevitabilmente, dunque, ad una ricerca mi-
rata appariranno numerosi i riscontri puntuali
con particolari faraonici: le colonne presen-
tano ancora foglie di palma come quelle che
C U L T U R A
17
Figura 6 - Bawit, Cappella XXVIII, abside est
: nicchia dipinta
con Madonna che regge un medaglione contenente l'immagine
del Bambino (Badawy, 1978).


















