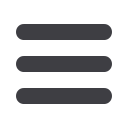
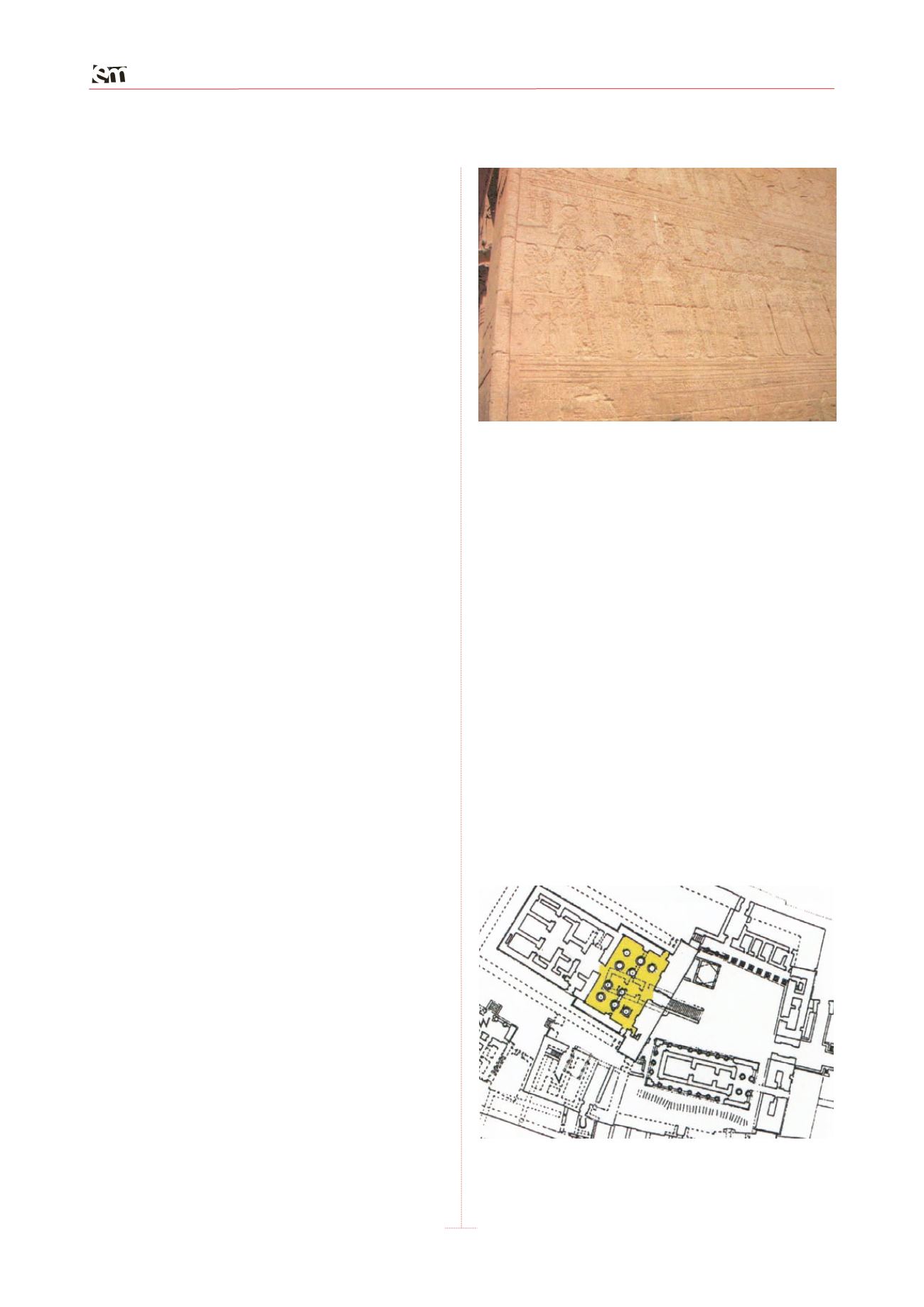
14
come sovversiva e pericolosa.
Da oppresso, il Cristianesimo si era ormai
tramutato in oppressore: liberata dalle catene
che fino ad allora ne avevano limitato le esi-
genze, non solo cultuali, ma anche ideologiche,
la nuova religione aveva iniziato ad erigere
chiese e monasteri in tutta la Valle del Nilo,
plasmando il tessuto urbanistico ed artistico
delle sue città e divenendo, a sua volta, perse-
cutrice delle resistenze pagane che tenace-
mente si opponevano alla condanna, all'oblio.
Una stima esatta della reale forza del Cri-
stianesimo nell'Egitto dell'inizio del V secolo è
praticamente impossibile. Indubbiamente con
il trionfo della Chiesa sancito dall'Editto di Mi-
lano, promulgato da Costantino nel 313, aveva
intrapreso la propria inarrestabile ascesa una
religione che comunque già nel II secolo si era
manifestata con una certa forza. Nel 400, ad
ogni modo, la prevalenza non è ancora così pa-
lese: i pagani hanno ormai perso la maggio-
ranza numerica ma rimangono comunque
organizzati ed in grado di contrastare effica-
cemente le incursioni cristiane. Anche dopo il
450, quando la vittoria cristiana è ormai ac-
quisita, la situazione si presenta ancora con-
fusa: una forte minoranza di pagani difende
ancora con tenacia le proprie convinzioni, sep-
pure in modo più silenzioso e privata dei suoi
templi, che venivano spogliati e sfregiati, del
suo clero e delle sue solennità. La cultura del
tempio faraonico, chiusa all'interno delle pro-
prie sacre mura, era destinata ad estinguersi:
entrando negli antichi santuari i cristiani inter-
pretarono le scene riprodotte sulle pareti
come atti di culto a demoni, cui sarebbero stati
fatti anche sacrifici umani.
Proprio dalle modalità di danneggiamento
delle stesse figure si evince una sopravvivenza
della memoria del potere che alle immagini
viene attribuito: alla frequente distruzione dei
volti si associano mutilazioni particolari che in-
teressano prevalentemente mani e piedi:
l'icona (sia essa figura o anche solo segno ge-
roglifico), infatti, risente ancora del potere at-
tivo che ad essa era attribuito in epoca
faraonica. Estranea era la concezione dell'
“arte per l'arte”, ogni immagine era forza at-
tiva capace di agire nel reale e di perpetuare
all'infinito le azioni compiute. Mutilandone le
estremità, dunque, le “rappresentazioni demo-
niache” dei templi erano rese inoffensive nel
rispetto di una procedura già conosciuta in
Egitto fin dal III millennio a.C.
Le evidenze archeologiche individuano nuclei
di resistenza pagana anche nella stessa capi-
tale ma, più frequentemente, nelle zone del-
l'Alto Egitto, focalizzate in alcune regioni o
attorno a determinati culti, come quello della
dea Iside, che riuscirono a sopravvivere fino
alla conquista araba.
Un attento esame di tali informazioni ar-
cheologiche proverebbe certamente una vita-
lità molto tardiva del paganesimo, in grado di
lasciare tracce della sua esistenza fino all'alba
dell'VIII secolo, periodo al quale vengono fatte
risalire le tre tombe pagane collocate fra le
trenta cristiane emerse a seguito degli scavi
nel cimitero di Karara. Mentre, dunque, la
massa pagana dei barbari e delle tribù nomadi
del deserto orientale garantisce in Alto Egitto
Figura 2 - Philae
, rilievi sfregiati sulle torri del Secondo Pilone.
Figura 3 - Tempio di Iside a Philae
, evidenziata la sala ipostila tra-
sformata in chiesa dai cristiani dopo la chiusura del tempio ad
opera di Giustiniano.
C U L T U R A


















