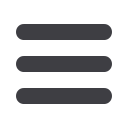

C U L T U R A
15
la sopravvivenza dei focolai di paganesimo, nel
deserto occidentale non cessano le incursioni
di clan nomadi contro i monasteri e la resi-
stenza degli antichi culti si concentra nella po-
polazione dei Blemmi.
Già noti nel periodo romano, essi occupavano
la regione estesa tra il Nilo ed il Mar Rosso e
vengono generalmente descritti dagli storici
contemporanei come un popolo di indomabili
pastori, guerrieri dediti alle razzie delle caro-
vane, allevatori di cammelli ed, infine, come i
veri padroni delle favolose miniere d'oro e pie-
tre preziose che esistevano in abbondanza nel
“Deserto del Bogah”, situato ad oriente del
Nilo.
L'entrata in scena dei Blemmi nell'Alto Egitto
e all'interno delle controversie religiose si col-
loca ai primi anni del V secolo e si accompagna
all'ondata di terrore diffusasi con le loro incur-
sioni in tutta la Tebaide, da Siene ad Antinoe.
Il “Sinaxario di Costantinopoli”, la cui compila-
zione risale probabilmente al VI secolo, offre
una dettagliata descrizione delle scorrerie e
dei massacri perpetrati dai Blemmi che vive-
vano sulle coste arabe e africane del Mar
Rosso ai danni degli eremiti copti del deserto
orientale egiziano. In particolare si menziona
un'incursione, risalente ai tempi di Diocleziano
(284-305), seguita da una strage, avvenuta nel
410, di 43 monaci sulla costa del Mar Rosso da
parte di 300 Blemmi che avevano raggiunto
dall'Arabia la costa africana a bordo di grandi
piroghe.
Il comandante Massimino, per ordine dell'im-
peratore Marciano (450-457), costrinse i
Blemmi ad accettare una pace di cento anni,
ed essi acconsentirono a condizione che fosse
loro concesso di recarsi in pellegrinaggio al
tempio di Iside a Philae ed i permesso di por-
tare periodicamente la statua sacra all'interno
del loro territorio, al fine di ottenere la prote-
zione e le grazie della dea.
Ma la minaccia dei Blemmi, seppure sopita,
non era stata soppressa e, alla morte di Massi-
mino, essi si rivoltarono nuovamente e costrin-
sero il prefetto di Alessandria Floro ad
intervenire per il rinnovamento del trattato dei
cento anni.
Verso la fine del trattato ripresero le razzie
in tutta la Nubia e l'imperatore Giustiniano, per
ottenerne la sottomissione, decretò la chiu-
sura del tempio di Philae, che si poneva in Alto
Egitto come ultimo baluardo di un paganesimo
ormai agonizzante. L'imperatore inviò a tale
scopo in Egitto Narsete il quale imprigionò i
preti, saccheggiò i tesori del tempio e tra-
sportò le statue di culto a Costantinopoli.
Le antiche dottrine erano ormai al tramonto,
sempre più frequentemente interpretate come
culti di carattere demoniaco.
Una tale capillare presenza tuttavia, seppure
rinnegata e combattuta dalla nuova religione,
non scomparve con la chiusura dei templi an-
tichi ma rimase viva e presente attraverso
l'arte, le credenze e i riti assimilati soprattutto
dalla devozione popolare, elementi difficil-
mente controllabili dai dogmi del cristianesimo
ufficiale.
INFLUSSI ICONOGRAFICI PROVENIENTI
DALL'EREDITA' FARAONICA – analogie e
distinzioni
In un panorama storico-culturale così com-
plesso non saranno infrequenti gli influssi ico-
nografici pagani che influenzeranno la
nascente arte della nuova religione. Spesso so-
pravvalutati, negati, ridimensionati, gli apporti
dell'eredità faraonica che contamineranno
l'iconografia, le tematiche e la definizione
della “mitologia” cristiana d'Egitto, rappresen-
tano tuttora un nodo critico che merita di es-
sere verificato ed approfondito alla luce della
documentazione pervenutaci, in modo da va-
lutare quali elementi dell'antica religiosità fa-
raonica siano stati tramandati dopo il
“filtraggio” della cultura ellenistica.
Tra le concezioni più rappresentative di tale
contatto vi è sicuramente quella relativa alla
concezione dell'aldilà: il nascente cristiane-
simo, probabilmente, attinse e riorganizzò
temi ed immagini desunti dalla complessa dot-
trina oltremondana faraonica come il motivo
della rinascita dopo la morte o l'elaborazione
di un luogo di punizione per le colpe com-
messe in vita, elementi che trovano puntuale
riscontro nella letteratura funeraria del Nuovo
Regno.
La stessa concezione della discesa di Gesù agli
inferi, elaborata nel corso del IV secolo, è stata
letta come una trasposizione del modello egi-


















