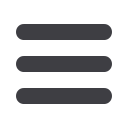
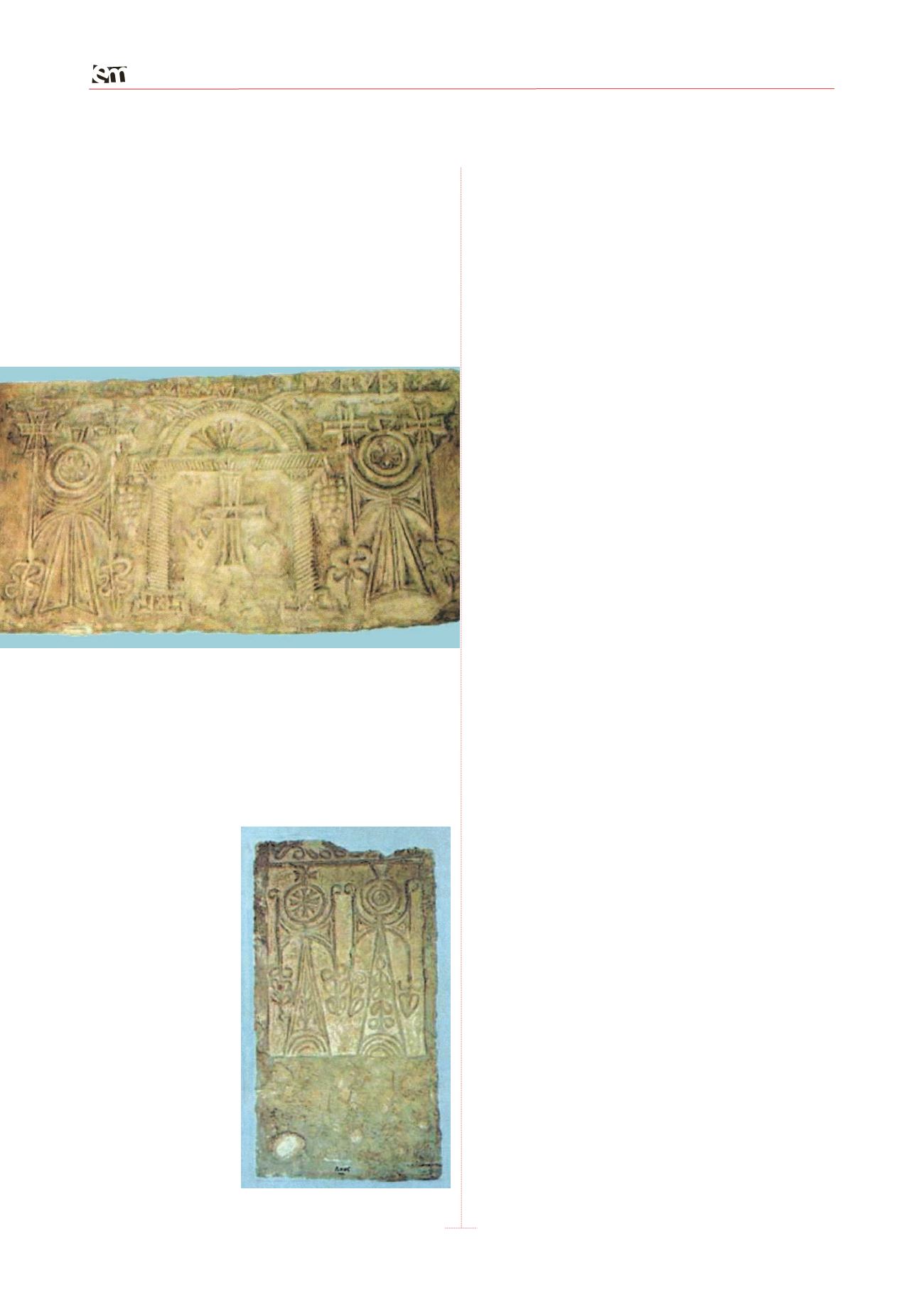
zio del percorso notturno del sole, tappa obbli-
gata per la rigenerazione dell'intero cosmo, a
cui partecipa non solo la divinità solare, ma
anche Osiride, modello del defunto che aspira
alla rigenerazione e alla resurrezione.
La manifestazione più evidente di reinter-
pretazione iconografica riguarda il simbolo
ankh
, anticamente simbolo di vita, associato
alle figure divine e spesso presente all'interno
dell'iconografia ufficiale faraonica: con tale
segno, infatti, terminano i raggi del disco so-
lare che nel periodo amarniano illuminano il
sovrano e la famiglia regale per sottolineare,
con facile simbolismo, come ogni vivente tra-
esse la vita dal ca-
lore del dio.
Ingrandito e nor-
malizzato nel dise-
gno, il geroglifico
venne presto assi-
milato nel sistema
iconografico della
comunità cristiana
d'Egitto come em-
blema della croce di
Cristo. Interessante
è, a tal proposito, notare le modifiche e le varianti
che hanno interessato il simbolo sui diversi monu-
menti cristiani: l'ansa si può presentare formata da
due o più segni concentrici, con motivo di rosacea
all'interno o modellata in modo da assumere essa
stessa l'aspetto di una corona di foglie, simbolo di
vittoria. In molti casi il segno geroglifico viene di-
rettamente affiancato alla croce, come si può
notare nell'esemplare conservato al Museo
Copto del Cairo (inv. 4302), nel quale il simbolo
cristiano, inserito all'interno di una struttura
architettonica con colonne tortili e sormontata
da una conchiglia, emblema di rigenerazione,
associa all'alpha e all'omega di ispirazione
evangelica l'antico retaggio faraonico decorato
da motivi fitomorfi, tralci di vite e motivi a ro-
setta all'interno dell'ansa.
Non sarebbe ragionevole, inoltre, negare al
simbolo egiziano cristianizzato un carattere so-
lare collegato con l'antica dottrina solare farao-
nica, come sottolinea Edda Bresciani nel suo
saggio contenuto all'interno del XXVIII Corso di
Cultura sull'Arte Ravennate e Bizantina, la
quale evidenzia una stretta associazione fra
vita e luce presente già all'interno dei testi
evangelici. Infatti, una significativa variante
del segno ankh in ambito copto, ed evidente
anche negli esempi precedentemente riportati,
prevede uno svasamento molto accentuato
della parte inferiore in modo tale che l'insieme
assume l'aspetto del geroglifico akhet, antica-
mente usato per indicare l'orizzonte, con il
disco solare che emerge dall'incavo delle mon-
tagne. La croce o il monogramma cristologico
veniva collocato nell'ansa a conferma ulteriore
della fusione tra simbolo solare pagano e sim-
bolo di culto cristiano.
Alla luce dei dati archeologici in nostro pos-
sesso possiamo perfino fissare alla fine del IV
secolo il momento in cui la croce ansata viene
assimilata nell'iconografia cristiana egiziana:
secondo la tradizione tramandata nella Storia
Ecclesiastica di Rufino (2,29), infatti, la cristia-
nizzazione dell'antico simbolo faraonico sa-
rebbe iniziata dopo la distruzione del Serapeo
di Alessandria nel 391 quando, in seguito ad
una disputa tra cristiani e pagani relativa al si-
gnificato del segno emerso dalle rovine del
tempio, le statue di Serapide che adornavano
le porte e le finestre delle case della città spa-
Figura 5 - Il Cairo,
Museo Copto, inv. 8552
:
frammento di stele con
rielaborazione del segno
geroglifico ankh (Atalla,
Coptic Art, vol II)
16
C U L T U R A
Figura 4 - Il Cairo, Museo Copto, inv. 4302
: frammento in pietra
decorato con croce affiancata dal segno geroglifico ankh (Atalla,
Coptic Art,
vol.II)


















