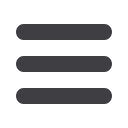
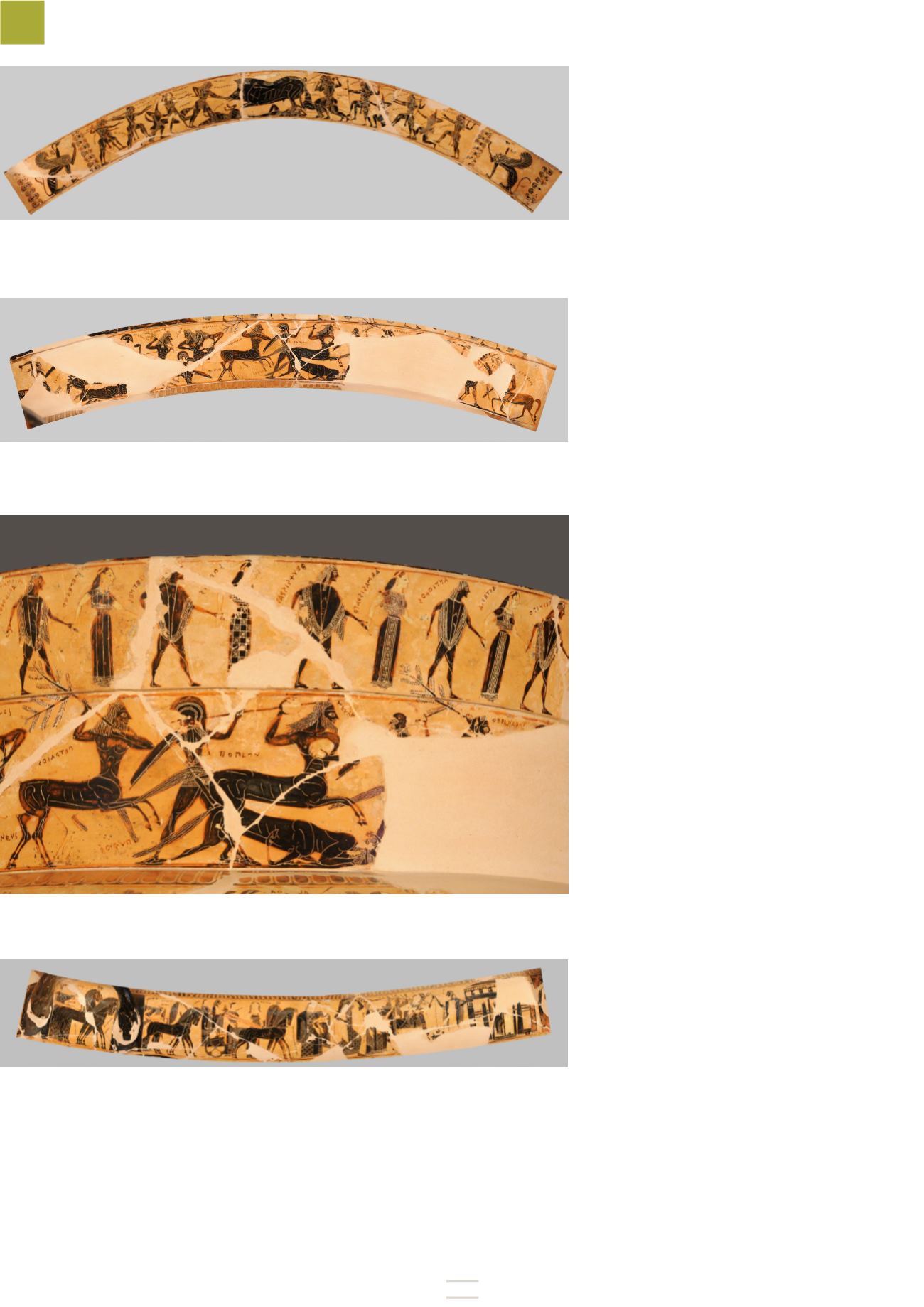
84
stocratico, mutuato direttamente dalla
Grecia. In letteratura la forma è nota in
diverse tipologie che si differenziano
per la particolare conformazione delle
anse: si parla di cratere a colonnette,
cratere a volute, cratere a calice. Nel
caso presente, il Vaso François può es-
sere classificato come cratere a volute
in virtù della particolare conformazio-
ne delle anse che dalla spalla del vaso
si chiudono all’altezza del labbro de-
scrivendo una vera e propria voluta. La
peculiarità che lo contraddistingue sta
nella straordinaria armonia che il cera-
mista ha saputo donare all’esemplare;
infatti, nonostante le dimensioni siano
davvero fuori dal comune, queste non
hanno minimamente sconvolto la resa
finale. Il Vaso che, date le proporzioni,
in mani meno esperte di quelle di Er-
gotimos, il ceramista, avrebbe corso il
rischio di apparire massiccio e pesante,
si presenta in realtà straordinariamen-
te elegante, armonico, quasi “leggero”
nonostante la sua imponente figura.
L’argilla con cui è stato realizzato pre-
senta il caratteristico colore rosso/
arancio, indice di una discreta compo-
nente ferrosa nella miscela che con-
traddistingue le produzioni attiche da
quelle corinzie che risultano invece es-
sere più pallide e più chiare, tendenti
al camoscio. Lo studio delle compo-
nenti mineralogiche e petrografiche
permette, oltretutto, di circoscrivere le
aree geografiche di reperimento e di
lavorazione delle materie prime, quin-
di, conseguentemente, di identificare
provenienze nonché ricostruire le rot-
te commerciali attraverso cui venivano
veicolate le merci.
A tale proposito, specifichiamo che in
Etruria nel corso del VI sec. a.C. le im-
portazioni di prodotti attici diventaro-
no via via sempre più copiose in ordine
alla sempre più crescente richiesta di
beni di lusso da parte dei ceti più ab-
bienti. Il cratere di Chiusi, in quanto ceramica attica a figure nere, rientra perciò pienamente nello scenario
storico – culturale appena delineato; si crede che sia stato il vicino centro di Vulci a veicolare i prodotti redi-
stribuendoli verso le città dell’interno. Solo in questo modo si spiegherebbe infatti il recupero di un oggetto
tanto imponente ed ingombrante, perciò difficile da trasportare, quanto prezioso in una città interna che non
ha contatti diretti con le coste.
foto 6 / Vaso François, lato A, orlo. Rappresentazione della Caccia al Cinghiale Calidonio. (Foto su conces-
sione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana – Firenze)
foto 7 / Vaso François, lato B, collo. Rappresentazione della battaglia tra Centauri e Lapiti. (Foto su concessione
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana – Firenze)
foto 8 / Vaso François, lato B, collo, Rappresentazione della battaglia tra Centauri e Lapiti. (Foto su
concessione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana – Firenze)
foto 9 / Vaso François, registro principale. Raffigurazione delle Nozze di Peleo e Teti. (Foto su concessione
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana – Firenze)


















