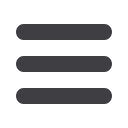
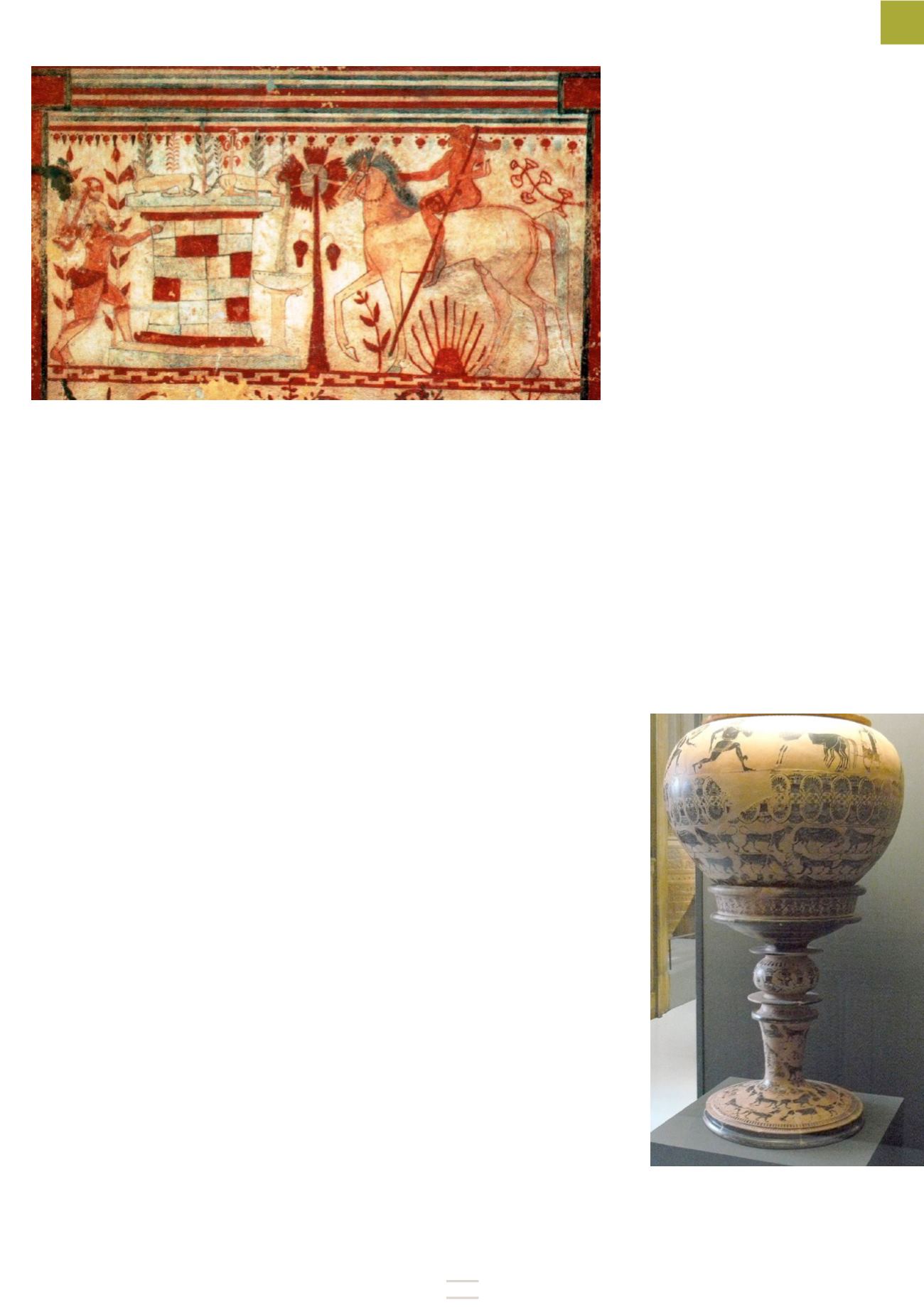
87
torno alle quali ruotava il suo desti-
no e la sorte di Troia: se il ragazzo
non avesse raggiunto i 20 anni, la
città sarebbe caduta e la guerra
si sarebbe finalmente conclusa,
Achille sarebbe stato l’eroe da cui
Troilo sarebbe stato ucciso. Dun-
que, Atena consigliò ad Achille di
pianificare un agguato al giovane
figlio di Priamo e l’eroe, consapevo-
le del fatto che Troilo fosse dedito
ad accudire i suoi cavalli, ordì un
agguato al giovane presso la fonta-
na di Timbra, un’area appena fuori
la città di Troia, dove sorgeva un
tempio dedicato ad Apollo.
Achille però, alla vista del giovane,
si innamorò perdutamente al punto che non riuscì a sferrare il colpo finale. Troilo scappò immediatamente per
salvarsi la vita e si rifugiò nel vicino tempio di Apollo dove Achille lo raggiunse per dichiarare il proprio amore.
Il giovane però rifiutando, scatenò inevitabilmente l’ira dell’eroe che, con un colpo di lancia, lo decapitò. A que-
sto proposito, vale approfondire brevemente l’arrivo e l’adozione del mito di Achille e Troilo in Etruria. Fin dalla
metà del VII sec. a.C., con la fondazione delle prime colonie euboiche nel Sud Italia, la cultura greca comincia
a permeare le realtà sociali, economiche e culturali indigene, tanto da creare una forte unione
(
κοινὴ, koinè)
linguistica ed etnica che trova manifestazione tangibile di sé nelle architetture e nei beni materiali recuperati
e studiati dagli archeologi. Il mondo greco comincia cioè a influenzare fortemente le realtà italiche sotto tutti i
punti di vista; non sarà infatti un caso che si cominci a costruire templi in muratura, si utilizzino tegole e coppi
per le coperture piuttosto che acroteri dipinti e terrecotte architettoniche a decorazione degli edifici. Mano a
mano che si instaura uno scambio reciproco tra cultura locale e mondo greco, si nota un passaggio graduale
ma tangibile che nel corso del tempo porta a manifestazioni inequivocabili,
come l’adozione di impianti ortogonali perfettamente squadrati in isolati, se-
condo le teorie di Ippodamo di Mileto, come dimostra il sito etrusco di Mar-
zabotto
6
. Uno scambio che si concretizza non solo nella cultura materiale ma
che influenza inevitabilmente anche il sacro e tutti gli aspetti della ritualità;
dal momento in cui si entra in contatto con un mondo nuovo, comincia un
vero e proprio processo di acculturazione in senso greco dell’Etruria, come
dimostra, ad esempio, il santuario emporico di Gravisca (VI sec. a.C.), nell’area
portuale di Tarquinia, dove iscrizioni in lingua greca su ceramiche attestano il
culto di Afrodite, Demetra, Hera ed Apollo.
Tra le iscrizioni compaiono menzioni di Afrodite anche in lingua etrusca, Tu-
ran, ad indicare che la dea greca è stata pienamente assimilata. Inoltre, all’in-
fluenza greca è da attribuire il fenomeno dell’antropomorfizzazione degli
dei etruschi. Si viene quindi a stabilire una profonda affinità ed un profondo
legame tra le due compagini, tanto che risalgono ancora al VI sec. a.C. monu-
menti di forte ed indubbia influenza greca che raffigurano scene mitologiche
a cui partecipano le divinità. In questo ambito rientra pienamente il Vaso
François poiché, in virtù delle scene raffigurate, diventa l’emblema di questo
profondo scambio culturale tra le due realtà. Non è un caso dunque che sul
cratere sia rappresentata la scena dell’agguato di Achille a Troilo, episodio
tanto caro al mondo greco e che diventa in breve tempo uno dei miti più
frequentemente attestati in Etruria. Una delle manifestazioni che testimonia
l’approdo di questo mito in territorio magno greco è senza dubbio rappre-
sentata dall’Heraion di Paestum, non a caso colonia di confine tra territorio
6 Camporeale 2004, pp. 168 ss.
foto 15 / Tomba dei Tori, Tarquinia – necropoli di Monterozzi. 540 a.C. rappresentazione dell’agguato di Achille a
Troilo. (ph P. Bondielli)
foto 16 / Pittore della Gorgone. Dinos a figure
nere. 590 - 580 a.C. Museo del Louvre, Parigi.


















