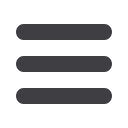

82
profonda conoscenza del mondo antico e la sua grande intuizione non lo abbandonò nemmeno in occasione
della ricognizione e dello scavo dei due tumuli localizzati presso la necropoli di Fonte Rotella; infatti, proprio in
quell’occasione, il giovane recuperò il cratere che, in virtù della forma, delle dimensioni, dei registri decorativi
e delle nuove convenzioni iconografiche non ancora riscontrate prima del 580 a.C., è considerato un vero e
proprio unicum della ceramografia, segnando inevitabilmente un momento fondamentale nella storia delle
importazioni attiche in Etruria. Oggi non è soltanto il simbolo della città di Chiusi ma è anche e soprattutto il
segno tangibile della grande apertura commerciale e culturale verso il Mediterraneo, la Grecia e l’odierna Tur-
chia occidentale, che ha comportato, come felice conseguenza, l’adozione di mode e stili accolti e rielaborati
localmente in Etruria.
Dunque, era l’autunno inoltrato del 1844 quando il François inaugurò le indagini archeologiche di due tumuli;
le prime operazioni di scavo rivelarono che le due strutture erano state violate e depredate già in antico, per
cui parte dei corredi era andata irrimediabilmente persa. I tombaroli che erano riusciti a violare la tomba, spez-
zarono intenzionalmente il cratere riducendolo in grossi frammenti che furono disseminati tra dodici stanze e
due corridoi. Il 3 novembre del 1844 furono recuperati i primi frammenti pertinenti al cratere; questi furono
immediatamente affidati alle mani esperte dei restauratori Vincenzo Manni e Giovan Gualberto Franceschi
che, in un primo tentativo di ricostruire ipoteticamente la forma del vaso, constatarono lamancanza di circa un
terzo dell’intera sagoma. Nella primavera del 1845 il giovane recuperò altri cinque frammenti; fu così possibile
integrarli e restituire l’esemplare alla sua originaria maestosità. I restauratori reputarono opportuno colmare
le parti lacunose del cratere con uno strato di gesso su cui resero a tempera le campiture pittoriche mancanti;
unmetodo ben poco ortodossoma che all’epoca fu considerato all’avanguardia e che permise di poter apprez-
zare la fisionomia dell’esemplare e le scene raffigurate. Nel luglio del 1845 il cratere fu portato a Firenze e nell’a-
gosto dello stesso anno, fu acquisito dall’Erario toscano dal Granduca Leopoldo II (1824 – 1859) ed un mese
più tardi fu esposto presso il
“Gabinetto dei Vasi Etruschi”
agli Uffizi. L’acquisto del vaso comportò un grande
sacrificio per le casse grandu-
cali: furono infatti versati 500
zecchini per la permanenza
e l’esposizione del cratere
all’interno della Galleria, cifra
che al tempo avrebbe potuto
permettere una permanenza
di circa sei mesi in Toscana,
pari ad un anno di vitto e al-
loggio nella città di Firenze.
Negli anni seguenti, mentre
un contadino stava arando
i campi attorno all’area inte-
ressata dagli scavi, fu casual-
mente recuperato un ultimo
frammento che fu donato alla
nobile famiglia degli Strozzi;
nel 1866, il marchese Carlo
donò il frammento agli Uffizi
e fu deciso di esporlo in ve-
trina accanto al cratere. Sfor-
tunatamente, il
Vaso François
subì un danno ingente quan-
do, il 9 settembre del 1900,
uno scellerato custode del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, preda di un atto d’ira, scagliò un pesante
sgabello in legno nella viva speranza (suo malgrado) di colpire un collega con cui era in accesa discussione. Per
sfortuna e per fortuna, “mancò l’obiettivo”, centrando però in pieno il cratere che si ridusse in 368 frammenti
(foto 3)
;
il Vaso fu immediatamente restaurato e restituito al suo splendore originario grazie all’intervento
esperto e preciso di Piero Zei; il restauratore colse questa occasione per inglobare il frammento donato dagli
Strozzi e fino ad allora esposto in vetrina. La rocambolesca storia del Vaso François però non si esaurisce con
questo tanto assurdo quanto incredibile e folle episodio; infatti, poco più di sessanta anni dopo, il 4 novembre
foto 4 /Vaso François, lato B. 570 a.C. Museo Archeologico Nazionale di Firenze. (Foto su concessione della Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Toscana–Firenze)


















