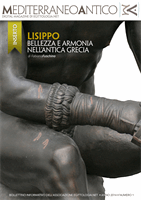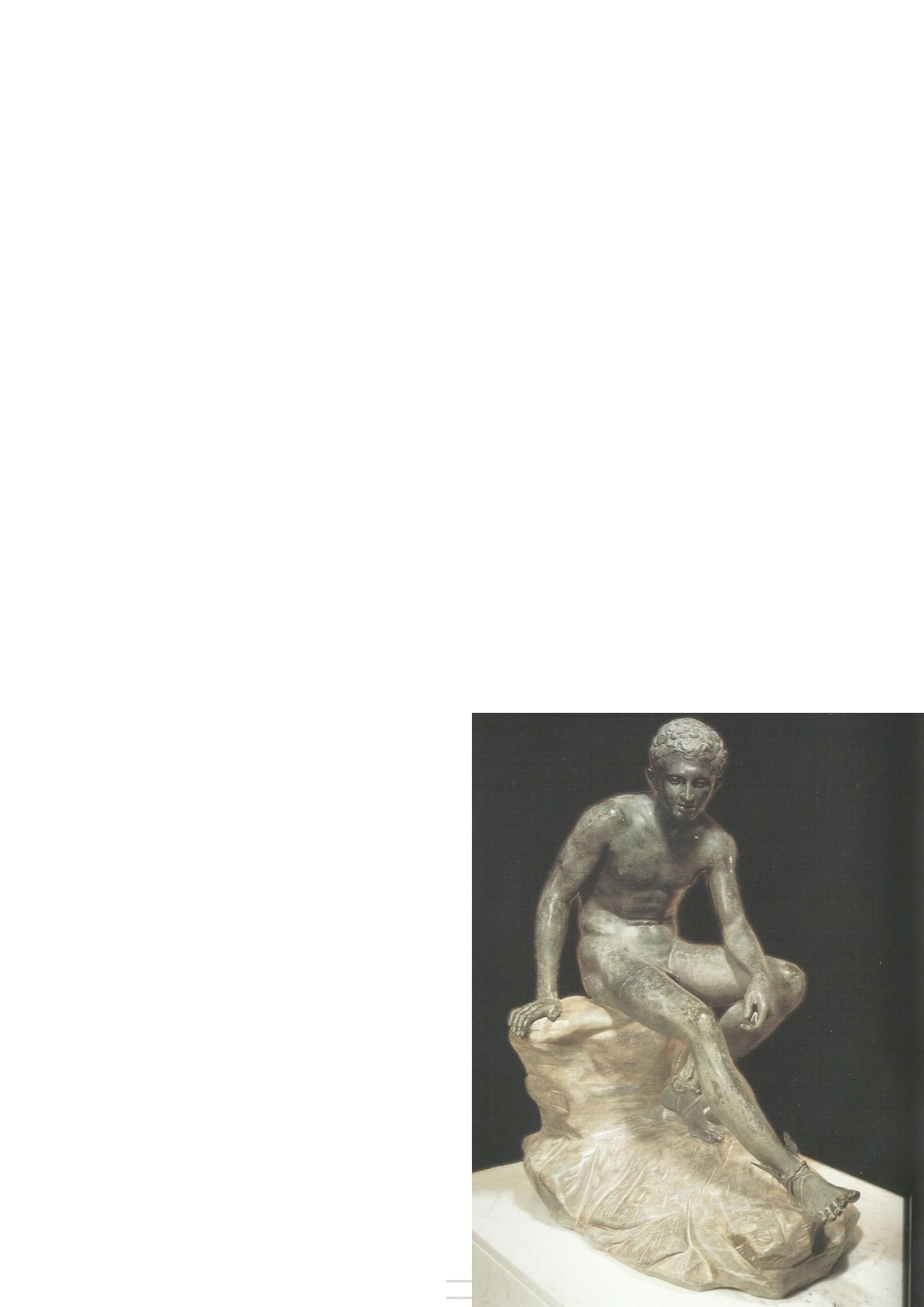
9
LISIPPO (LÚSIPPOJ, LYSIPPUS)
E’ dunque in que-
sta temperie storica, culturale e artistica che si svi-
luppa la personalità di Lisippo protagonista della
presente trattazione. Lisippo
(390 /385 a.C.) sculto-
re, particolarmente bronzista, originario di Sicione
(Arcadia), è considerato l’ultimo tra i grandi maestri
della scultura greca classica. Attivo dal 372-368 a.C.
fino alla fine del IV secolo a.C., la sua ακμή è fis-
sata al 328 ca.20, in concomitanza con il regno di
Alessandro Magno, di cui egli fu l’artista prediletto e
il ritrattista ufficiale21. L’artista terminerà la carriera
al servizio di un altro re macedone,
Cassandro I, tra
il 316 e il 311 a.C
22
.
La sua formazione cominciò verosimilmente sulle
opere di
Policletoe sulla scultura peloponnesiaca,
nonostante
Duride di Samolo dicesse formato al di
fuori di ogni scuola emaestro
23
. Di Lisippo si celebra-
vano le ricchezze messe da parte al termine della
carriera; secondo Plinio, infatti, l’artista avrebbe pro-
dotto mille e cinquecento bronzi circa
24
.
Lo scultore lavorò a lungo nella sua città per poi
spostarsi in diversi centri della Grecia: le sue ope-
re sono ricordate a Tespi, Sicione, Argo, Olimpia,
Corinto, Megara, Atene, in Beozia, a Delfi, in Etolia, in
Acarnania, in Tessaglia, in Macedonia, a Lampsaco,
a Myndos, a Roma, a Taranto25; esse rappresen-
tavano divinità, esseri mitologici o allegorie (Zeus,
Diòniso, Eracle, Posidone, Eros, le Muse, le impre-
se di Eracle, un satiro, Helios, Kairos) atleti, ritratti
(la poetessa Praxilla, Alessandro e i suoi compa-
gni, Efestione, Seleuco, Pythes, Polidamas, Troilos,
Cheilion, Kalhkrates, Xenarches, Esopo, Socrate,
Pelopida, il gruppo di Daochos), animali come il
Leone caduto per Lampsaco, portato a Roma nei
20 Plin., Nat. hist., XXXIV, 51
21 Alessandro nonmancava di dedicare nelle città la propria immagine ufficiale, di cui L. aveva l’esclusiva nel
bronzo, tanto che Cicerone (Primi Accademici, 2, 85) si chiedeva:
“Lisippo, con lo stesso rame, con la medesima
lega con la fìnitura del suo bulino e tutto il resto, non avrebbe potuto fare cento Alessandri tutti uguali?”
.
In qualità
di ritrattista del sovrano, L. è considerato il fondatore del ritratto individuale che, riproducendo l’aspetto
esteriore del soggetto, ne suggeriva anche le implicazioni
psicologicheed emotive.
22 La data iniziale dell’attività di L. veniva fissata dalla critica attorno al 368 rifacendosi a una base firmata
che sosteneva la statua del generale tebano Pelopidamorto nel 369; in realtà Pelopidamorì nel 364 e la data
d’inizio dell’attività di L. può essere in linea di massima confermata, avendo egli eseguito a Olimpia nel 372
la statua di Troilo, vincitore nelle corse dei carri (Paus., VI, 1, 4-5). MORENO, 1995, p. 384. L’ultima citazione
sicura dell’attività di L. è quella relativa all’ordinazione di un gruppo che rappresentava una caccia al leone da
parte di Alessandro, dedicata dal re Cassandro nel santuario di Delfi nel 318. GIULIANO, 1961, p. 655.
23Plin., Nat. hist., XXXIV, 61:
Lysippum Sicyonium Duris negat ullius fuisse discipulum, sed primo aerarium fabrum
audendirationemcepissepictorisBupompiresponso.Eumenim interrogatum,quemsequereturantecedentium,dixisse,
monstrata hominum multitudine, naturam ipsam imitandam esse non artificem
(
Duride dice che L. di Sicione non
fudiscepolodialcuno,eche,dapprima fabbrobronzista,presecoraggioeosòaffrontare ledifficoltàdell’arte
in seguito al responso del pittore Eupompo. Era stato domandato, infatti, a costui chi fosse il suo modello tra
i maestri antecedenti, ed Eupompo aveva risposto, mostrando la folla, che si doveva imitare la natura non
un artista.
24 Plin., Nat. hist., XXXIV, 37:
“
Ilnumerodellestatuesarebbestatorivelatodopo lasuamorte,quando l’erederuppe
lo scrigno, perché L. era solito porvi una moneta d’oro dal compenso di ogni statua”.
All’interno dell’elenco pliniano
sono però comprese anche repliche e riduzioni, mentre le opere vere e proprie sarebbero circa cinquanta
(comprendono quelle conosciute solo tramite fonti letterarie, quelle di cui si conoscono copie o riproduzioni
varie, o di cui sono rimaste i basamenti originali e quelle attribuite su basi stilistiche). Il tono favolistico riflette
larealecircolazionedellamonetaaureaaltempodiL., inparticolaredeglistateridiFilippo,diAlessandroedei
Diadochi che erano tra i committenti dello scultore e dai quali anche Apelle pretendeva il pagamento in oro.
25 L. è l’unico dei grandi maestri di questo periodo che si sia trasferito in Occidente per opere di lungo
impegno quali i colossi di Taranto.
4 / Ermes in riposo