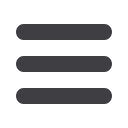

75
foto 8 (©Francesca Pontani) Dettaglio di una delle Vittorie alate del soffitto
Una terza iscrizione è il testo ripetuto, con diversa impaginazione, sulle due basi di statue
6
rinvenute, negli
anni 1662-1663, in prossimità della facciata orientale e occidentale della piramide, che soprattutto ci fornisce
importanti indizi per circoscrivere i tempi della costruzione del monumento tra il 18 a.C. e il 12 a.C.:
M(ARCUS) VALERIUS MESSALLA CORVINUS, / P(UBLIUS) RUTILIUS LUPUS, L(UCIUS) IUNIUS SILANUS, / L(UCIUS)
PONTIUS MELA, D(ECIMUS) MARIUS / NIGER, HEREDES C(AI) CESTI, ET / L(UCIUS) CESTIUS, QUAE EX PARTE AD /
EUM FRATRIS HEREDITAS, / M(ARCI) AGRIPPAE MUNERE, PER/VENIT, EX EA PECUNIA, QUAM / PRO SUIS PARTI-
BUS RECEPER(UNT) / EX VENDITIONE ATTALICOR(UM), / QUAE EIS PER EDICTUM / AEDILIS IN SEPULCRUM / C(AI)
CESTI EX TESTAMENTO / EIUS INFERRE NON LICUIT.
Il primo tassello cronologico che si ricava da questa iscrizione è che gli eredi di Caio Cestio commissionarono
e curarono l’erezione di due statue bronzee impiegando la somma di denaro proveniente dalla vendita degli
Attalica
7
, cioè i preziosi arazzi intessuti d’oro che erano stati introdotti nell’uso funerario da Attalo III, re di Per-
gamo. Caio Cestio infatti aveva richiesto nel testamento di riporre nel sepolcro vesti e arazzi di gran pregio, ma
questo desiderio si rivelò irrealizzabile a causa dei provvedimenti suntuari, cosicchè le stoffe furono vendute
e con il ricavato vennero fatte fondere due statue di bronzo dorato con cui venne ornato il lato orientale della
piramide. Parti di queste furono rinvenute durante gli scavi seicenteschi. Tale vendita avvenne quindi dopo il
18 a.C., anno in cui fu promulgata la lex Iulia sumptuaria contro l’ostentazione del lusso nelle cerimonie pub-
bliche, comprese quelle funebri, da
porre verosimilmente in relazione
con l’editto dell’edile nominato nell’i-
scrizione
8
, che impedì agli eredi di
ottemperare alle disposizioni testa-
mentarie del defunto
9
. Non era più
ammesso lo sfoggio del lusso, il cor-
redo non si poteva più comporre di
oggetti preziosi, eccettuati i fili d’oro
che legavano i denti del defunto. Il
secondo termine cronologico, den-
tro il quale i lavori per la costruzione
della piramide devono essersi con-
clusi è invece il 12 a.C., anno della
morte di Marco Agrippa, che figura
tra i beneficiari del testamento
10
.
DENTRO LA PIRAMIDE DI ROMA
La Piramide di Caio Cestio è costitui-
ta da un imponente nucleo in opera
cementizia, all’interno del quale venne realizzata la camera sepolcrale, raggiungibile tramite un breve divertico-
lo della via Ostiense che conduceva ad un recinto, delimitato da un muro in opera quadrata in tufo. Ai quattro
angoli della piramide erano disposte altrettante colonne poste su alte basi, due di queste vennero ricollocate
nella posizione originaria in seguito al loro rinvenimento nel corso degli scavi del 1656. La piramide ha una
base quadrata di 29,50 metri (100 piedi romani) ed è alta 36,40 metri (125 piedi romani). La struttura poggia
sopra una fondazione di travertino ed è costruita in opus caementicium con paramento in laterizio, ricoperto
da blocchi di marmo, materiale preziosissimo utilizzato in molti monumenti dell’antica Roma. Le pietre tagliate
e sagomate sulla stessa via Mormorata
11
importante scalo litico, provenivano via mare dalle antiche e rinoma-
te cave di Luni, in Toscana. Una volta giunte nel porto di Ostia venivano fatte risalire attraverso il Tevere fino
in prossimità del luogo dove oggi la piramide sorge. Una lastra “a scomparsa” sigillava l’accesso al sepolcro.
Un corridoio rivestito di mattoni conduce dal lato nord-occidentale dentro alla camera sepolcrale con pare-
ti affrescate, percorribile attraverso il cunicolo comunicante con una porta che venne aperta nel corso del
6 / cm 84 x 79 x 44; 79 x 72 x 51
7 / “ex ea pecuniam, quam pro suis partibus receperunt ex venditione attalicorum”
8 / “per edictum aedilis”
9 / “eius inferre non licuit”
10 / “Marci Agrippae munere”
11 / nel quartiere di Roma Testaccio, dove erano presenti enormi depositi di marmi e di pietre che a Roma giungevano attraverso il Tevere o via terra e qui ammassati in attesa di essere venduti o lavorati.


















