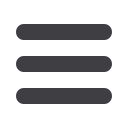

Dopo la bella edizione dello scorso anno dedi-
cata al 150° dell’Unità d’Italia, quest’anno il
Salone Internazionale del Libro celebra il suo
venticinquesimo compleanno. Da una parte ri-
marchiamo la soddisfazione per la continuità
che questa manifestazione è riuscita a rita-
gliarsi, d’altro canto non possiamo trascurare
evidenti segni di usura di una manifestazione
che celebra stancamente un settore in pro-
fonda crisi, in una città dilaniata dalla crisi, in
un periodo dove quotidianamente non si parla
d’altro che di crisi.
Nato da un’idea di Guido Accornero e Angelo
Pezzana, storico libraio torinese, sul modello
dell’omonimo Salon parigino, il Salone Inter-
nazionale del Libro ha finito per superarlo per
ricchezza di contenuti e per numero di visita-
tori, raggiungendo i vertici delle manifesta-
zioni europee del settore. Passato alla
gestione della Fondazione per il Libro, la Mu-
sica e la Cultura, ha registrato un successo
crescente, con un numero di visitatori ormai
costantemente oltre le 300.000 unità l’anno.
Se è pur vero che questi numeri sono stuzzi-
canti, cerchiamo ora di dare una lettura un po’
più approfondita, distinguendo le varie tipolo-
gie di visitatori.
Come prima considerazione esaminiamo le vi-
site delle scolaresche, categoria che rinpingua
in modo significativo il tanto decantato nu-
mero di visitatori ma che, di fatto, è commer-
cialmente inesistente. Specialmente nelle
giornate di giovedì e venerdì si incontrano de-
cine di scolaresche di ogni ordine e grado che
migrano tra i corridoi del salone: dai (pochi) li-
ceali attenti alle novità del mercato editoriale
ai (tanti) studentelli attentissimi alle mini-
gonne delle standiste, per concludere con i
bambini delle scuole elementari o materne
accompagnati attraverso gli stand con uno
stranissimo e ingegnoso sistema anti-smarri-
mento: una sorta di imbragatura tipo muta di
cani (o tiro di renne, se preferite…). Il risultato
di queste orde erranti è malinconicamente co-
stante da anni: gli studenti guardano (se
guardano), ma non comprano! E se è pur vero
che un contatto con il mondo dell’editoria può
teoricamente stimolare alla lettura mi do-
mando come questi ragazzi, abbandonati a
loro stessi, riescano a cogliere dei contenuti
del salone.
Passiamo ora ad esaminare l’altra parte del
pubblico: succede che deve pagare un bi-
glietto d’ingresso in linea con la crisi (cioè
spropositamente caro, 10 euro). Mi domando
come non ci si renda conto che in un mo-
mento come questo occorrerebbe trovare un
incentivo, stimolare il pubblico all’acquisto
concordando con gli editori una linea di
sconto o, paradossalmente, chiedendo agli
stessi uno sforzo economico in più e non far
pagare l’ingresso, o applicare prezzi equi. Non
capisco per quale motivo un lettore attento
debba acquistare libri al salone quando è risa-
puto che il suo libraio di fiducia gli applicherà
comunque uno sconto!
È pur vero che per i piccoli editori come noi
questo salone è un evento irrinunciabile, in
quanto le grandi catene di distribuzione
spesso non espongono nelle loro vetrine libri
che non siano ritenuti best-sellers, e quindi
appartenenti ai grandi gruppi editoriali: l’im-
60
S A L O N E I N T E R N A Z I O N A L E D E L L I B R O
Dietro le quinte
del Salone Internazionale
del Libro
di Carlo Ruo Redda


















