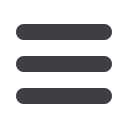
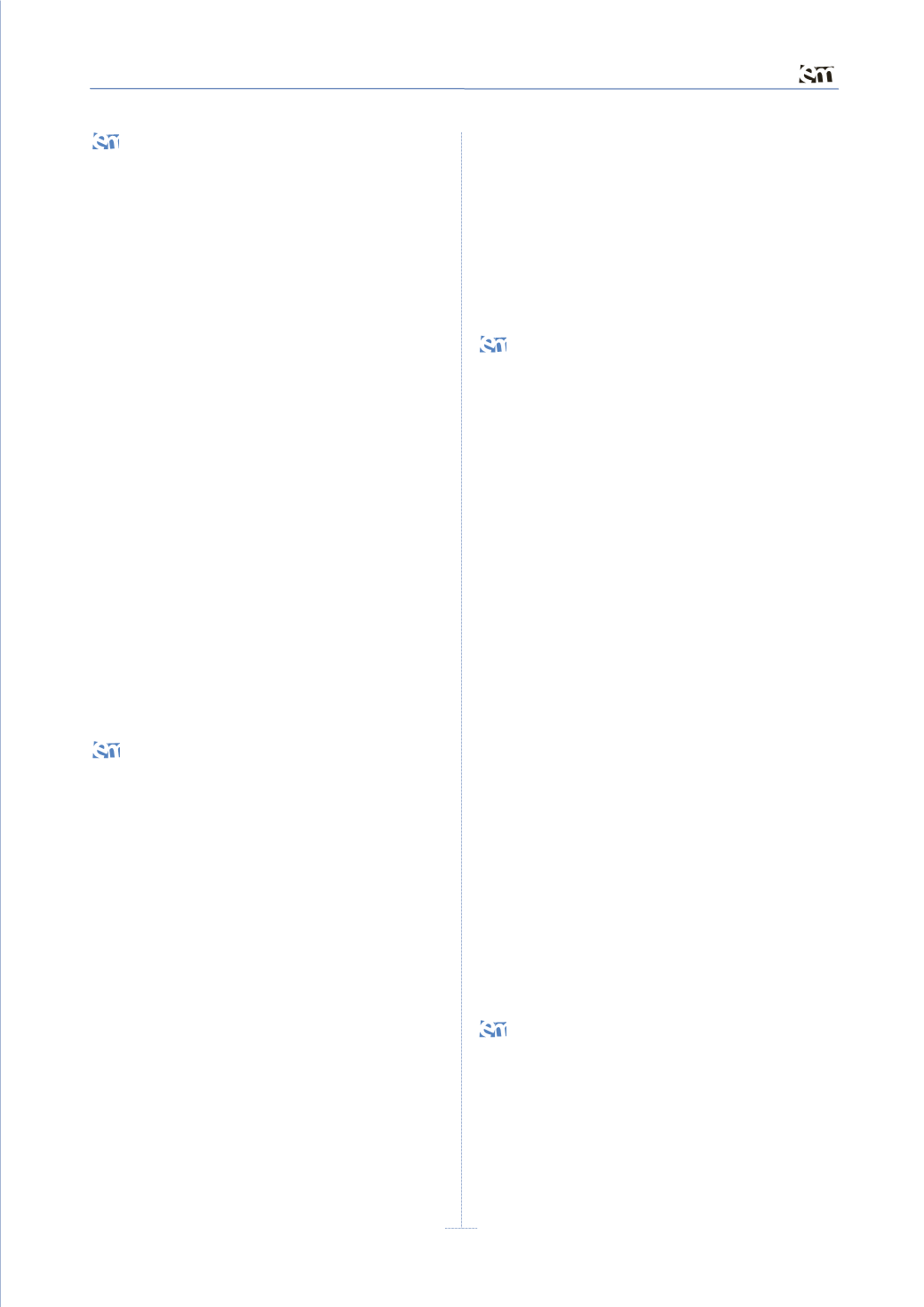
33
Perché un libro sulla musica nel-
l’antico Egitto?
Tra i musicologi vi è una tendenza generale a
far cominciare la storia della musica dal-
l’epoca ellenistica ed ovviamente con brevi
accenni, per poi saltare direttamente alla na-
scita del sistema temperato. Ciò avviene per-
ché esiste ancora una certa diffidenza verso
quei popoli che giudichiamo “primitivi”.
L’idea che la storia proceda in maniera li-
neare come il tempo cronologico ha pervaso
le menti di molti studiosi, ma è possibile di-
mostrare che tempo e storia seguono un per-
corso circolare e quindi sarebbe più giusto
parlare di storia-tempo, ovvero un processo
inscindibile che si muove seguendo la geo-
metria di una spirale conica. Questo vuol dire
che gli avvenimenti storici non sono esclu-
sivi, ma si ripetono sempre nello stesso cir-
colo di eventi solo con uno spostamento
temporale. Questa lunga premessa è la base
per affermare che la musica nell’antico Egitto
aveva la stessa valenza e le stesse funzioni
che ha per noi del XXI secolo. Dunque è im-
portante che si cominci a parlare dei nostri
antenati musicisti dando loro la giusta collo-
cazione e il giusto riconoscimento nella sto-
ria della musica.
Nella scrittura del volume qual è
stato il momento più difficile del percorso
creativo e quale quello più esaltante?
Il momento più difficile è stato il reperimento
delle fonti. Libri sull’Antico Egitto ne esistono
molti, ma solo pochissimi sono i testi che
hanno affrontato apertamente il problema
musicologico, tra questi troviamo i lavori di
Curt Sachs, Hans Hickmann e Lisa Manniche.
Uno degli aspetti più ansiogeni è stato il do-
vere affrontare la materia da diversi punti di
vista, quello testuale (le traduzioni dal gero-
glifico), l’interpretazione dei rilievi e dei di-
pinti, le tecniche di costruzione e l’uso dei
materiali. Il problema della prospettiva nella
raffigurazione egizia è il primo punto da ana-
lizzare poiché diventa difficile riuscire a com-
prendere la postura esatta dei musicisti
intenti nella’arte di suonare. Hickmann aveva
già compreso la questione fino ad esprimere
la possibilità che la posizione delle mani
avesse un significato reale, gestuale, non ca-
suale. Comparando i testi al di sopra delle raf-
figurazioni con l’analisi delle posizioni delle
mani è possibile compilare una tabella di
“modi” con un significato ben definito. Pro-
babilmente è proprio quest’analisi la parte
più esaltante della stesura del libro poiché si
riesce ad entrare dentro la mente degli anti-
chi musici e alla fine puoi quasi immaginare
di essere li con loro ad esibirti.
Nella gerarchia sociale ma soprat-
tutto nell' immaginario collettivo come si
evolve la figura del musicista?
I musicisti avevano un ruolo molto simile, per
non dire progenitore, al modo in cui li consi-
deriamo oggi. Nell’Antico Egitto erano rite-
nuti “stolti” coloro che si esibivano nelle
taverne, noi oggi li chiameremmo Piano Bar
o in altri casi “artisti di strada”. C’erano mol-
tissime categorie musicali così come anche
repertori e generi, si va dalla musica liturgica
a quella profana e d’amore, dai canti del la-
voro a quelli per le celebrazioni folkloristiche.
È interessante notare che la musica poteva
essere eseguita in formazioni da Camera, di-
remmo oggi, come il duo (arpa e voce), il trio
(arpa, liuto e percussioni), quartetto e orche-
stre intere. Questo è un punto importantis-
simo perché dimostra l’esistenza di una
prassi armonico-melodica e una evoluzione
nel concepire la musica come un lavoro. Non
era un caso che alcuni dei migliori musicisti
seguivano i sovrani durante i loro viaggi e
che gli stessi fossero dei dipendenti di questa
o quella corte. Una curiosità invece deriva
dalla musica profana. Il Duo Hekenu (arpa) ed
Iti (cantante chironomia) erano considerati
molto famosi e alcune loro canzoni sono pa-
ragonabili, leggendo i testi, alle canzoni di un
Gigi D’Alessio, questo per far comprendere
come l’uso della musica non fosse differente
dal nostro.
Quanto c’è di Antico Egitto nella mu-
sica di oggi?
Tutto. La musica occidentale è figlia della
musica faraonica, ma non bisogna dimenti-
care che questa è di derivazione sumera. In-
fatti le analogie con l’epoca mesopotamica
sono tantissime così come le influenze co-
struttive sugli strumenti e le caratteristiche
l o s c a f f a l e
“
”
“
”
“
”
“ ”
:
:
:
:


















