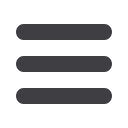
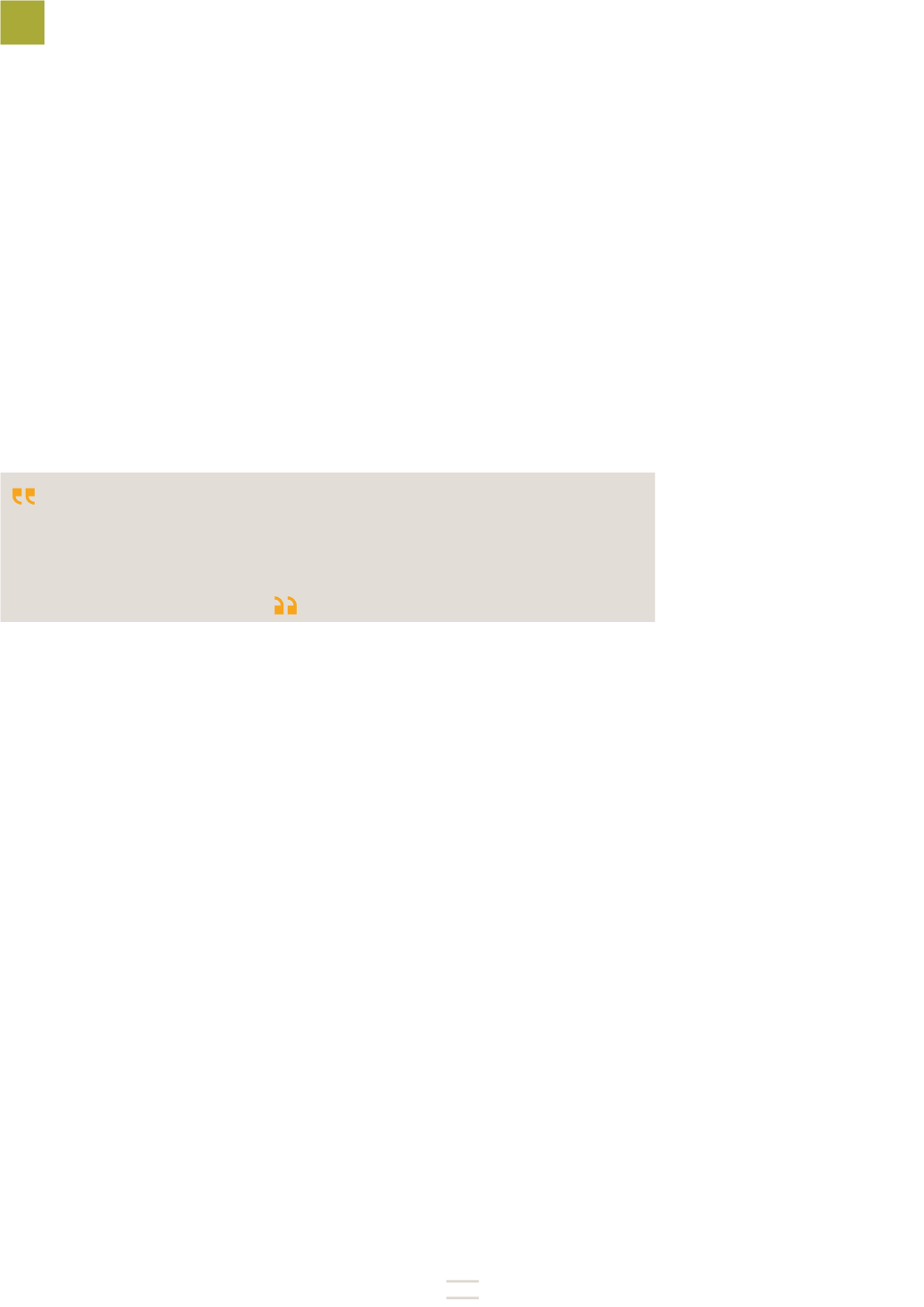
68
siro-palestinese, terra ricca di fermento religioso e meta di pellegrinaggi, si sviluppò in maniera importante:
rifiorirono strutture insediative preesistenti, furono costruiti nuovi centri monastici, luoghi di pellegrinaggio e
l’agricoltura subì un impulso produttivo; le infrastrutture seguirono questo andamento con l’intensificazione e
la fortificazione delle arterie di comunicazione e commerciali. La Siria non presenta un carattere unitario archi-
tettonico: la disomogeneità delle materie prime disponibili, causata dalle differenze morfologiche del territorio,
è risultato un elemento determinante per le diversità stilistiche: a nord è presente il massiccio calcareo, zona
ricca di materiale litico adatto al taglio e di legno per le coperture. Si è evidenziata, in questa zona, una fiorente
attività edilizia religiosa tra il V e il VI secolo d.C.; l’altopiano interno caratterizzato da argilla e pietre laviche; la
parte a sud di Damasco con la sua abbondanza di basalto ma con scarsa presenza di legname.
L’architettura religiosa continua a subire l’influenza della tradizione antica con edifici a pianta basilicale pur ap-
portandone dei sostanziali cambiamenti: le colonne vengono sostituite da pilastri rettangolari in pietra. La scel-
ta dei pilastri fu funzionale, perché ritenuti più adatti a sostenere la spinta degli archi che separano gli ambienti
creati dalla navata centrale con quelle laterali; si registra la presenza di un tipico elemento decorativo a rilievo,
definito nastro siriano, utilizzato per alleggerire da un punto di vista estetico le facciate. Il complesso di Qalat
Seman, sempre nella zona siriana (seconda metà del V secolo d.C. edificato intorno alla colonna dell’ascesi di S.
Simeone Stilita) non presenta particolari tratti di influenza imperiale o elementi della tradizione locale: costitu-
ito da quattro corpi basilicali a tre navate che formano una croce greca dai lati dell’ottagono centrale. A Seleu-
cia Pieria, Apamea, Resafa e
Bostra sono invece presenti
degli edifici a pianta centra-
le, elemento tipicamente si-
riano, con un’esedra semi-
circolare posta su ogni lato
e circondato da un elemen-
to esterno che ne segue il
profilo. In Palestina sembra
comparire intorno al VI secolo d.C. lo schema triabsidale e gli esempi sono attestati a Gerasa (chiesa del Ve-
scovo Procopio e SS. Pietro e Paolo), ad Amwas, a Beth Yerah e a Susita-Hispos. Da segnalare, inoltre, risalente
al VI secolo d.C., ma con buone probabilità eretta su struttura di epoca precostantiniana, l’edificio di culto a
Ras Siaga sul Monte Nebo. Gli edifici di culto in Mesopotamia sono realizzati con una sala longitudinale rettan-
golare, con facciata priva di ingressi che trovano collocazione sui lati lunghi: elemento riconducibile all’impianto
palatino assiro. Il presbiterio posto a ovest si chiude con un abside rettangolare divisa in tre ambienti. Anche
le strutture monastiche meritano qualche accenno, se pur breve. Su questi edifici appare evidente l’influsso
locale. I fattori determinanti per le varianti sono dovuti: alla concezione che ogni regione ha sviluppato sul
fenomeno del monachesimo; alla funzione specifica che l’edificio avrebbe svolto anche a carattere difensivo.
Ad esempio l’Egitto, tra il IV e il VII secolo d.C., presenta dei complessi costituiti da agglomerati di piccole strut-
ture abitative e fabbriche destinate al lavoro; il tutto è distribuito su un territorio ampio con la presenza di una
chiesa, centro nevralgico del culto. Caso diverso è costituito dai monasteri di epoca protobizantina siropale-
stinesi: strutture destinate alla difesa e all’organizzazione amministrativa del territorio circostante. Tali insedia-
menti potevano essere integrati nelle linee dell’organizzazione difensiva bizantina, alla stessa stregua degli in-
sediamenti urbani, che avrebbero costituito un limes. Il limes era un complesso di opere viarie e di fortificazioni
già realizzate lungo i confini esterni dall’Impero romano; nella terminologia moderna non esiste una parola
equivalente che possa descrivere il concetto sottostante a tale frontiera “liquida”. Il limes bizantino non era un
confine rigido bensì flessibile e adattabile alle condizioni geomorfologiche e alle differenze militari e culturali
delle popolazioni adiacenti; inoltre, il sito fortificato svolgeva un ruolo di controllo amministrativo e di organiz-
zazione territoriale. I limites coincidevano con le grandi arterie di comunicazione terrestri e fluviali, ciò per con-
sentire spostamenti rapidi dell’esercito regolare con le truppe ausiliare, per lo più composte da locali, lasciate
a presidiare il sito. Esistevano tre percorsi di fondamentale importanza il cui controllo era strategico: la strata
Diocleziana, che, passando daDamasco collegava laMesopotamia settentrionale alla costa siro palestinese e ai
porti del Mar Rosso (coincideva anche con la linea difensiva della zona siro palestinese conosciuta anche come
“limes arabicus”); un percorso collegava Costantinopoli con la regione pontico–caspica; un’altra via di comuni-
cazione partiva dall’antica Iconium (l’attuale Konya in Turchia) e portava fino in Persia attraversando l’Armenia.
La successiva crisi degli insediamenti lungo il limes arabicus, causata dalla forte pressione dei Sasanidi, portò
La Siria non presenta un carattere unitario
architettonico: la disomogeneità delle materie prime
disponibili, causata dalle differenze morfologiche del
territorio, è risultato un elemento determinante per
le diversità stilistiche


















