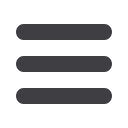
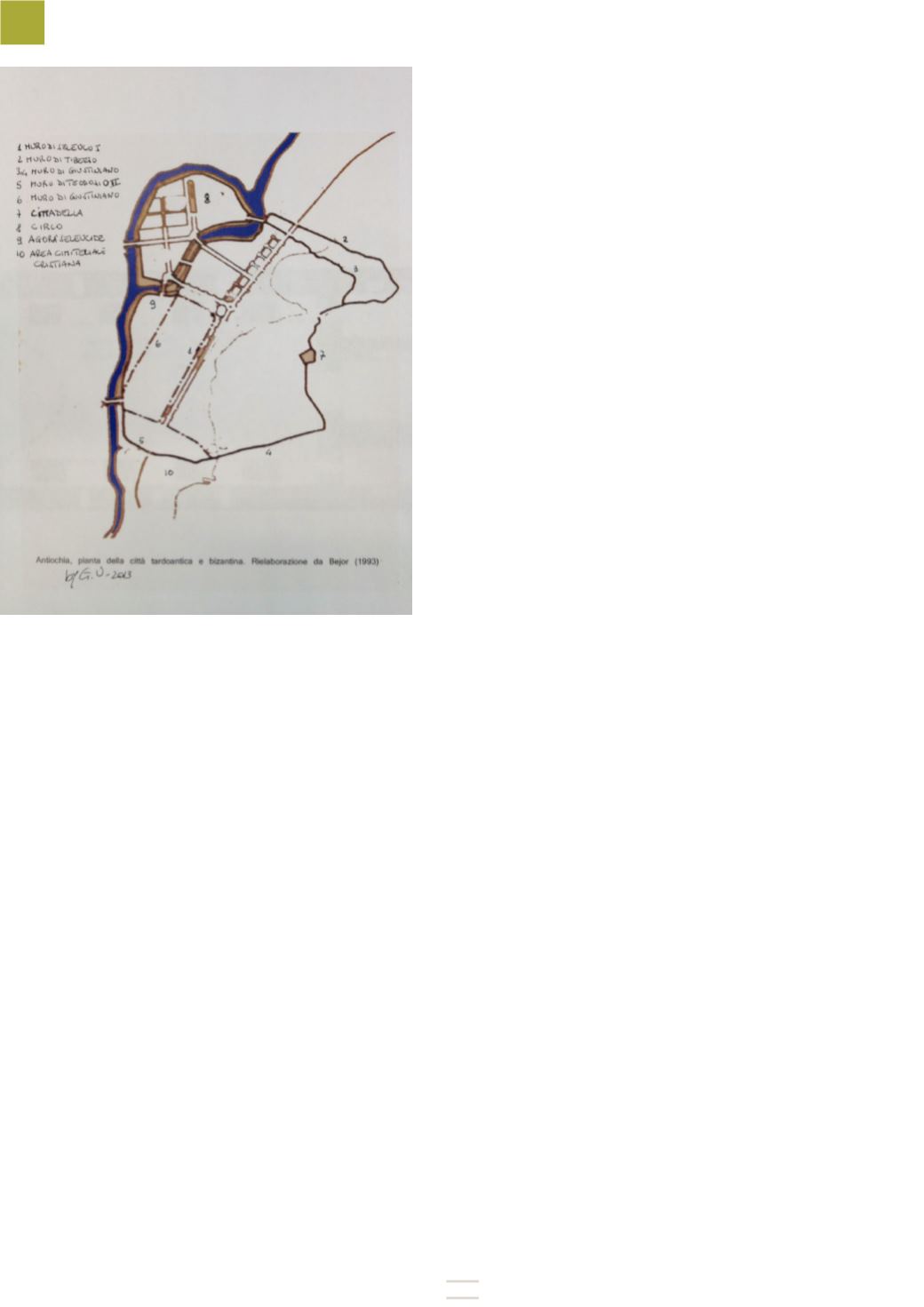
66
delle strutture e dei
luoghi preesistenti e
si assiste a un abban-
dono progressivo di
tutte le costruzioni le-
gate all’intrattenimen-
to quali teatri o stadi.
L’agorà non verrà più
utilizzata come luogo
di svolgimento del
mercato, ma tale at-
tività troverà nuova
collocazione presso
le stoa (le strutture
coperte o strade co-
lonnate). Le prime va-
riazioni dell’impianto
urbano sono dovute
alla preponderante
e crescente compo-
nente religiosa che fa
registrare le maggiori
novità: trovano collo-
cazione nel tessuto
cittadino le strutture
legate al culto, al pel-
legrinaggio e alle atti-
vità commerciali collaterali. Il passaggio è identificabile con la sovrappo-
sizione e sostituzione definitiva dei templi pagani con le chiese cristiane.
In parallelo, emerge un incremento degli edifici religiosi e di assistenza
(ospedali, case per i poveri e case per gli anziani o i ricoveri) sia urbani
sia extra urbani; inoltre acquistano prestigio i centri abitati che diventa-
no sedi vescovili e in cui si riscontra uno sviluppo maggiore del tessuto
urbano. Non denotano particolari caratteristiche i centri di nuova costi-
tuzione, fondati per specifiche esigenze militari o amministrative. In que-
sta fase, le decisioni sulla politica urbana messe in atto dagli imperatori
sembrano seguire esigenze funzionali. Gli interventi edili di Anastasio e
Giustiniano, due imperatori particolarmente attivi, possono essere ri-
condotti a tre tipologie relativamente delineate:
•
interventi su strutture difensive, contrazione dei perimetri delle città,
scelta – in accordo tra architetti e gerarchia ecclesiastica – delle posi-
zioni strategiche per i nuovi impianti;
•
edificazione di nuovi luoghi di culto e mantenimento degli stessi;
•
progettazione e realizzazione di strutture tipicamente classiche, quali
edifici di rappresentanza, la cura per l’assetto viario e la divisione tra
le zone produttive e residenziale.
Ad esempio gli sforzi condotti su Antiochia, città della Siria che rivestiva
importanza strategica e militare, appaiono rilevanti ed esemplificano in
modo chiaro i tre punti sopraindicati. La città, sede di una zecca e della
cattedra patriarcale, fu oggetto di un vero e proprio programma di rico-
struzione a seguito del raid sasanide avvenuto nel 540 d.C., seguito a un
forte terremoto nel 526 a.C.; il precedente perimetro esterno, realizzato
da Teodosio II intorno al 430-431 d.C., fu allargato fino a comprende-
re un’altura, considerata punto debole, che fu parzialmente spianata; fu
effettuata anche una contrazione
dell’area intramuraria a discapito
di una zona ricca di strutture di
intrattenimento. Per accentuare il
carattere della metropoli cristiana
furono edificate due chiese (una
“grande” e l’altra “grandissima”)
intitolate al Theotokos e all’arcan-
gelo Michele. Nel 526 d.C., la città
abbandonò il suo nome ellenistico
e fu intitolata Theoupolis, la città
di Dio. Anche nuovi centri furono
edificati: sul confine bizantino sa-
sanide nel 505-507 d.C. Anastasio
I fece costruire Dara (in Armenia) e,
sempre nell’ottica militare, l’attività
edificatoria investì la rifondazione
di Sergiopoli (Rusafah) e Zenobia in
Siria e altri centri ex novo in altre
regioni dell’Impero.
Gli effetti della crisi di impoveri-
mento generale, che investì l’Im-
pero verso la fine del VI secolo e
che perdurò per tutto il VII secolo
d.C., vengono confermati anche
dal nuovo modello di organizzazio-
ne urbana; le indagini archeologi-
che hanno attestato un frequente
cambio di destinazione d’uso delle
strutture e una precarietà edilizia
diffusa. I segni evidenti di tale ten-
denza sono:
•
la tamponatura di porticati per
ricavarne nuovi spazi o i resti
di abitazioni ricavate all’interno
di monumenti pubblici pree-
sistenti, situazione riscontrata
nella maggior parte delle zone;
•
la tecnica costruttiva risulta più
grossolana e povera, verosimil-
mente segnale di mancanza di
manodopera altamente spe-
cializzata sul territorio.
Potrebbe essere anche interpre-
tato come una drastica riduzione
dell’attività edile direttamente ri-
conducibile a Costantinopoli. In un
contesto territoriale così ampio,
è comunque impensabile non te-
nere in considerazione le varianti
locali che hanno influenzato forte-
mente la realizzazione architetto-
nica di molte strutture, sia per gli
Pianta di Antiochia


















