
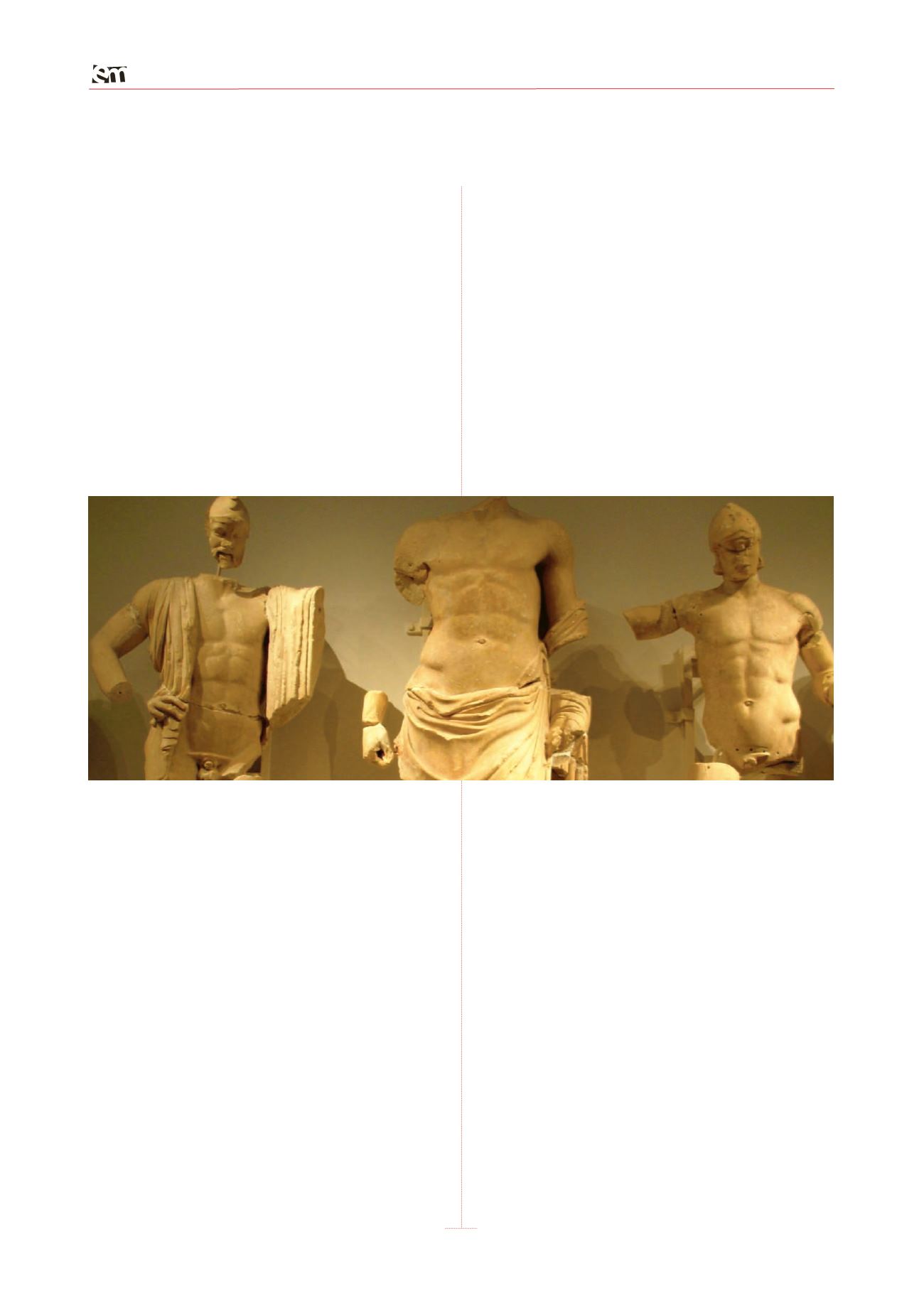
lità “intellettuali”, assolutamente inscindibili dal
corpo, assieme al quale formavano l’intero essere, co-
stituendo quello che fu il celebre ideale del “k
αλ
Õ
ς
κα
ˆ ¢
γα
qÒ
ς
”, letteralmente “il buono e il bello”, al-
meno fino al IV secolo a.C.
Ora come allora, dunque, i Giochi Olimpici costitui-
scono un evento di grande forza aggregatrice e di
ampio impatto partecipativo, rappresentando un fe-
nomeno universale che coinvolse e coinvolge tantis-
simi uomini nel nome di unmessaggio che, rinnovato
nel 1896 dal barone Pierre de Coubertin, giunge al
nostro tempo da una civiltà, quella ellenica, che ha
costituito uno dei tratti fondamentali nella storia mil-
lenaria dell’umanità.
Ed ecco che restituendo vigore e sostanza a quel
messaggio trasmesso attraverso preziose testimo-
nianze di uomini e letterati che ne avvertirono il peso
e ne restarono coinvolti e affascinati, è possibile giun-
gere alla riscoperta di un ideale, partendo dall’analisi
del mito, delle imprese leggendarie, dello spirito spor-
tivo più puro.
Ogni atleta, sottoponendosi ad un lungo periodo di
duri allenamenti
9
e gareggiando in totale nudità
10
, in-
tendeva dare ampia dimostrazione delle proprie ca-
pacità, al fine di essere osannato dalla pÒlij di
appartenenza; i concorrenti, che ricevevano come
premio per la vittoria una semplice corona di olivo sel-
vatico
11
, aspiravano, infatti, ad un qualcosa di più
grande, ovvero la fama ed il rispetto eterno di tutti i
Greci. FIG. 4
Premesso ciò, le Olimpiadi occuparono una posizione
di spicco rispetto ad ogni altra manifestazione spor-
tiva, costituendo l’espressione più alta dello spirito
agonistico e determinando l’adunanza di tutti i Greci,
ovvero un’assemblea di uomini liberi provenienti da
tutto il mondo; quindi risulterà chiaro come gli agoni
olimpici diventarono veri e propri festival panellenici
12
.
Questo spirito, nato inGrecia e perfettamente espresso
nei Giochi Olimpici, era costituito dalla consapevolezza
dell’uomo della sua forza fisica, morale e dell’ugua-
glianza democratica.
Si potrebbe pensare che tale visione fosse una chimera;
considerazione che potrebbe essere prontamente
smentitada tutti coloro i quali hannoprovatoeprovano
lo spiritodi fratellanza che viene a crearsi tra gli atleti di
tutto il mondo e che domina ancora le moderne Olim-
piadi. Nel periododedicatoallegare, infatti, i confini che
dividono i popoli, sono dimenticati; il linguaggio, la re-
ligione e la razza non alzano barriere tra gli uomini; le
posizioni sociali, di ricchezzamateriale e nazionale non
hanno senso; gli uomini, spogliati di tutto il resto, com-
petono in pace e con onore. Tutti coloro i quali hanno
avuto la fortuna di vivere questa esperienza, conti-
nuanoa credere e a sperare che l’idealeolimpicopossa
essereutilead ispirare ilmondo intero, non soltantoper
i pochi giorni riservati alla competizione.
Andrebbe quindi compreso cosa e quanto resti dello
28
c u l t u r a
9 Circa l’allenamento e le patologie sportive: DOMENICI, 1972, pp. 59 - 61.
10 Per approfondire la conoscenza dell’abbigliamento sportivo e della nudità atletica degli an-
tichi Greci: FITTÀ - PADOAN, 1988, pp. 76 - 78; GARDINER, 1956, pp. 28 - 30.
11 Sulle corone: FINLEY - PLEKET, 1976, p. 24; FITTÀ - PADOAN, 1988, p. 35.
12 La panegiria si caratterizzò per essere in primo luogo un’adunanza avente carattere reli-
gioso; questa tipologia di “riunioni” era tenuta sotto il diretto controllo del dio signore del
santuario. In onore di questa divinità il periodo di festa si apriva con una solenne processione
e con sacrifici che consolidavano i legami interni alla comunità dei partecipanti; il tutto ter-
minava con altrettanti rituali e sacrifici. In tale contesto rientrarono gli agoni olimpici che ri-
univano i Greci a scadenze regolari. ZAIDMAN - PANTEL, 1989, p. 100; su Olimpia ed i concorsi:
FINLEY - PL
EKET, 1976.


















