
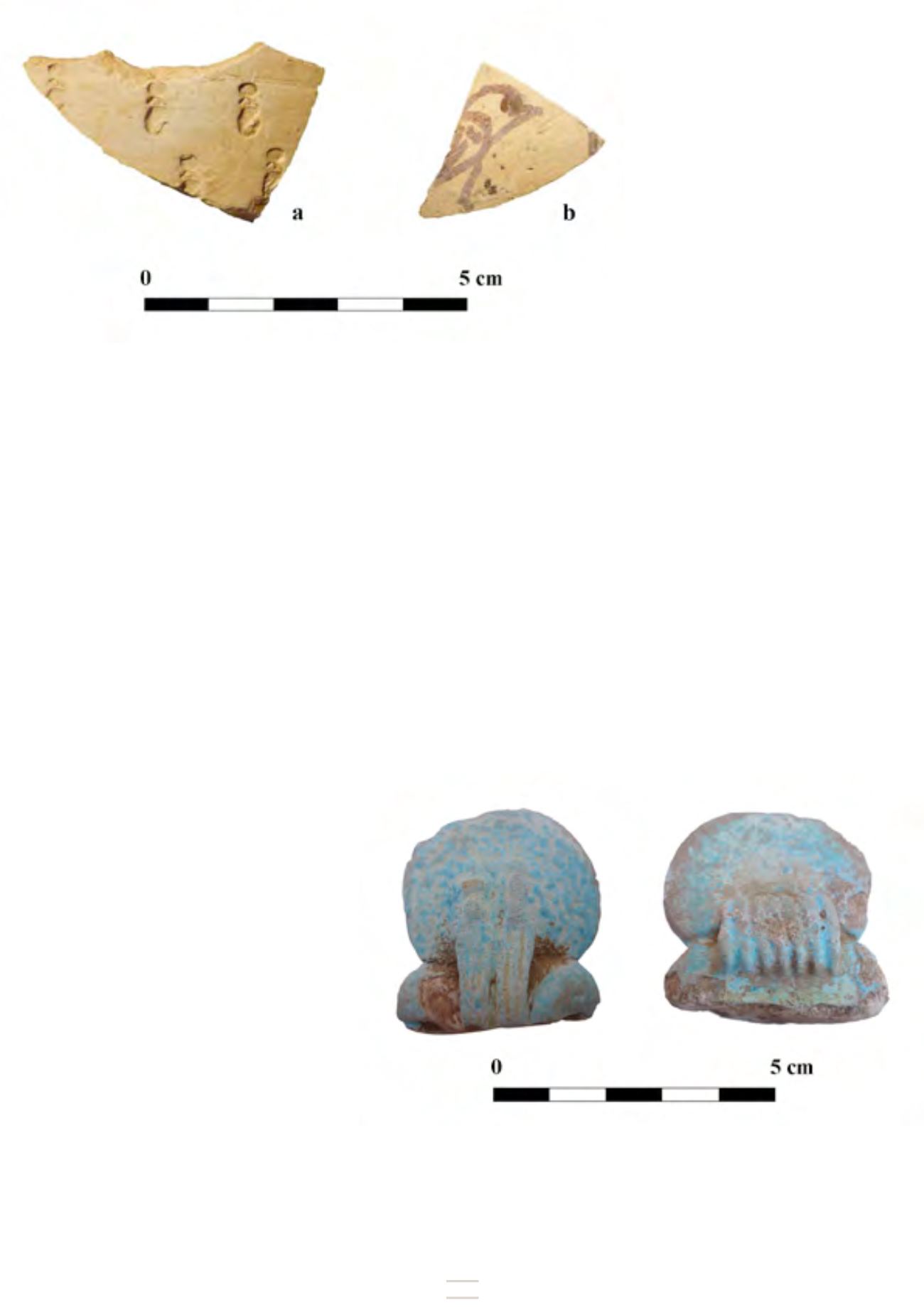
58
laborazione con Mario Gaeta
17
,
Fabio Bellatreccia e Giancarlo
Della Ventura
18
. Ciò ha permesso
una caratterizzazione esaustiva
dei materiali di studio, offren-
do un’ulteriore chiave di lettura
della realtà archeologica loca-
le arricchendo la possibilità di
comparazione con insediamenti
coevi (fig. 4). Sebbene l’area ri-
chieda certamente un approfon-
dimento d’indagine, da realizzar-
si già dalla prossima stagione sul
campo, la combinazione di dati
architettonici, archeometrici e di
cultura materiale ed artistica permette un inquadramento cronologico dell’occupazione di K 1000, por-
tando a non escluderne la contemporaneità con il palazzo sul
kom
I. Fermo restando la chiara ascrizione
all’ambito meroitico classico sulla base delle modalità costruttive, l’attribuzione ad un periodo fra I e II se-
colo d.C. è indicata dalla datazione al radiocarbonio di carbone di legna forse risultato di un incendio
19
, e
precisata dalla collezione ceramica campionata. Essa affianca la consueta produzione legata ad esigenze
quotidiane, di impasto più o meno grossolano, a raffinati manufatti generalmente associati a contesti eli-
tari, inclusi frammenti della cosiddetta “egg-shell”, particolarmente diagnostica. Il termine indica una spe-
cifica tipologia di ceramica caolinica di spessore inferiore ai 5 mm, limitata a forme destinate alla presen-
tazione ed al consumo di alimenti e bevande; presenta impasto estremamente fine, ingobbio chiaro ed
eterogenee decorazioni dipinte od impresse. Sebbene sia attestata in modo generalizzato entro il regno
meroitico, la sua diffusione appare ristretta a contesti sacrali nonché a residenze e sepolture riferibili ad
un alto lignaggio socio-economico, secondo una datazione che la vulgata attuale vuole fra la metà del I e
la metà del IV secolo d.C.
20
I frammenti noti per Abu Erteila, rinvenuti dai saggi di scavo su entrambi i
kom
nonché da ricognizioni di superficie alle propaggini occidentali della concessione, mostrano il frequente
ricorso a motivi decorativi realizzati per impressione, di carattere geometrico o legati all’influsso egiziano
(fig. 5a). Fra le rare ornamentazioni dipinte spicca su un frammento la resa di un volatile realizzato con
pigmento bruno derivante da ematite (fig. 5b).
Rafforzando e precisando quanto già
esposto, l’emergenza della “egg-shell”
permette di restringere l’arco crono-
logico ascrivibile all’occupazione di
K 800 e K 1000, da riconoscersi con
verosimiglianza in un intervallo tem-
porale compreso fra la metà del I e la
metà del II secolo d.C.
Egualmente riferibile ad un contesto
di prestigio, presso l’ambiente K 1014
è venuto alla luce un frammento di
amuleto in faience, quale corona in
forma di disco solare sul quale poggia-
no due urei affiancati, recanti rispet-
tivamente la corona bianca dell’Alto
Egitto e quella rossa del Basso Egitto;
la preservazione alla sua base di due
elementi ricurvi, rimanenze di corna,
evidenzia come esso sormontasse
originariamente una testa d’ariete (fig.
6). Una simile iconografia, che voleva
17 Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Roma “Sapienza”.
18 Dipartimento di Scienze, Sezione di Scienze Geologiche, Università degli Studi “Roma Tre”.
19 L’analisi al radiocarbonio ha restituito una datazione in età calibrata compresa fra il 20 ed il 140 d.C.
20 Cfr. in part. Adams 1986: 435-40.
Fig. 5 / Abu Erteila, propaggini occidentali, frammenti di “egg-shell” / Ceramica caolinica. I-II secolo d.C.
ph Baldi e Fantusati
Fig. 6 / Abu Erteila, Complesso K 1000, Ambiente K 1014 / amuleto raffigurante una corona originaria-
mente sormontante una testa d’ariete / Faience. I secolo d.C. (?) / ph Fantusati


















