
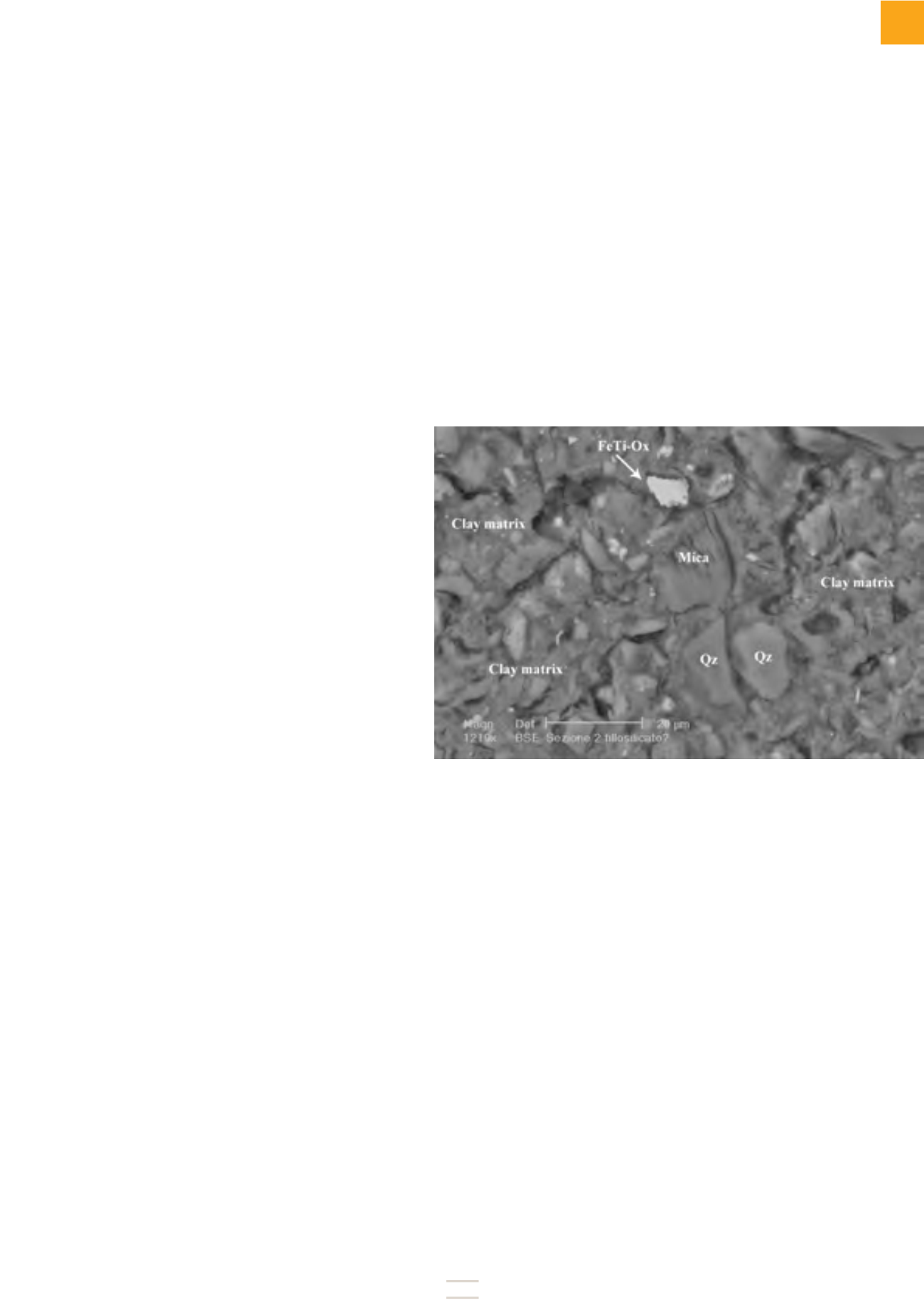
57
tità di carbone, constavano ciascuno di vasi impilati
12
, in modo che la cenere ardente,
collocata nel recipiente inferiore, permettesse la cottura dei cibi contenuti in quello su-
periore
13
. Il mantenimento della posizione verticale e la buona preservazione delle pareti
nonostante l’evidenza di numerose fratture, giustificano l’ipotesi che i vasi godessero di
strutture protettive, collocandosi evidentemente su piano rialzato considerato il dislivel-
lo rispetto alla quota pavimentale osservata. Rifacimenti successivi lasciarono inalterate
le strutture murarie originarie ma imposero al contempo una mutazione della riparti-
zione planimetrica, che divenne più fitta e disordinata mediante l’erezione di nuovi muri
divisori. Essi appaiono ergersi secondo tecniche e spessori difformi, talora con l’utilizzo
di materiali cotti di reimpiego, evidenziando l’assenza dell’uniformità costruttiva che ave-
va caratterizzato la precedente edificazione. Ciò palesa la messa in opera di interventi
frettolosi frutto della contingenza piuttosto che della programmazione, parlando a fa-
vore di una perdita di prestigio e ricchezza del complesso. Non è possibile affermare se
la definizione di un maggior numero di ambienti fu volta ad una parcellizzazione delle
unità abitative all’interno di quello che era in origine un unico complesso residenziale. Il
carattere improvvisato dei rimaneggiamenti strutturali e la longevità delle classi cerami-
che ad essi associate, limitate ad una produzio-
ne prettamente domestica, non consentono di
fornirne collocazione cronologica.
La suggestione di un complesso cultuale
L’indagine di scavo ha avuto contestualmente
luogo presso l’altura orientale, cosiddetto
kom
II, rivelando allo stesso modo un’occupazione
dell’area in cui è stato possibile riconoscere
molteplici fasi antropiche di differente impatto.
Il più antico momento costruttivo sinora indivi-
duato portò all’erezione di un edificio a chiaro
sviluppo longitudinale, detto K 1000, con anda-
mento N-S e dimensioni note, ma certamente
parziali, di 23 m N-S x 11 m E-O. Le strutture
d’alzato si ergevano da fondazioni in cotto de-
finite da arrangiamenti eterogenei, costituite
talora da frammenti incoerenti ed in altri casi
da mattoni interi disposti sul dorso o sistemati
in due corsi secondo il verso della testa. In continuità con l’architettura meroitica nota, il
ricorso a soluzioni molteplici per le fondazioni del medesimo edificio non rappresentava
necessariamente indice di datazioni differenti, bensì poteva rispondere alla disponibilità
di materiale e a scelte dei costruttori per la singola parete
14
(fig. 3). Benché gli elevati
abbiano mostrato un disomogeneo grado di preservazione, l’evidenza disponibile li lega
alle medesime tecniche murarie osservate per il palazzo, definite dall’analoga combina-
zione dei due materiali argillosi, che allo stesso modo forniva protezione alla faccia ester-
na delle mura di telaio. Per entrambi gli edifici appare inoltre comune, tanto per i muri
perimetrali quanto per quelli divisori, l’impiego di intonaco calcareo di spessore variabile
fino ai 2 cm, di cui si conservano lacerti. Esso risultava talvolta arricchito da decorazioni
dipinte in policromia; misure condotte con laser Raman da Armida Sodo ed Annalaura
Casanova Municchia
15
hanno rivelato l’uso di differenti pigmenti fra i quali il cosiddetto
blu egizio, silicato di rame e calcio, che trova unica altra attestazione meroitica certificata
da indagini archeometriche nel tempio di Amon a Dangeil
16
. Reperti ceramici di differente
tipologia, nonché campioni di argilla del Wadi el-Hawad, oltre a frammenti di arenaria e
mattoni cotti, sono stati egualmente sottoposti ad indagini archeometriche grazie alla col-
12 Si tratta di olle con la sola eccezione di un isolato vaso caliciforme.
13 Fra gli insediamenti meroitici del Butana, il medesimo procedimento è stato notato ad Hamadab (Wolf et alii 2009: 239, abb. 38) ed Abu Geili (Adams 1984: 273).
14 Per il caso di Meroe v. ad es. Shinnie & Bradley 1980: 25 ss. Per Muweis v. Baud 2010: 218-19, fig. 284.
15 Dipartimento di Scienze, Università degli Studi “Roma Tre”.
16 Sweek et alii 2012: 11.
Fig. 4 / Abu Erteila, Kom I, osservazione di un frammento ceramico allo Scanning Electron
Microscope (SEM) / a cura di Fabio Bellatreccia e Marco Baldi


















