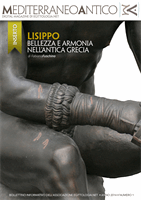28
“vendicatore”
94
. Quando fu innalzato lo Zeus era la
statua più alta del mondo greco: fonti indipendenti
concordano nel tramandare la misura di quaranta
cubiti
95
. L’analisi della scultura è tale da far intende-
re che la gamba destra era avanzata e flessa e la
sinistra tesa e arretrata; quanto al mantello, questo
lasciava scoperta la spalla destra; inoltre, la fluente
pettinatura doveva apparire come lo sviluppo di un
motivo già osservato nell’Alessandro e nel Kairòs
96
.
Una delle ragioni che avevano trattenuto Fabio dal
rimuovere lo Zeus era stata l’osservanza del divie-
to che accompagnava da secoli il costume romano:
uomini e dèi in armi non potevano varcare il pome-
rio. Il console invece non ebbe riguardo a traspor-
tare a Roma l’altro colosso eseguito da Lisippo per i
Tarantini dopo il 314, l’Eracle meditante
97
(24). Ultima
opera dell’artista sicionio, l’Eracle avrebbe raggiunto
una fama ancor più vasta e durevole: prova indiret-
ta della fortuna del colosso in età ellenistica, può
essere considerata, infatti, una pittura pompeiana
in
III stile della Casa di Epidio Sabino in cui si vede
Eracle seduto in atto di ascoltare Orfeo
98
. Da Roma,
dove era stato dedicato sul Campidoglio dallo stes-
so quinto Fabio Massimo
99,
il bronzo fu trasferito nel
325 d.C. a Costantinopoli, dove venne descritto ac-
curatamente dagli autori bizantini, per poi andare
distrutto soltanto nel 1204 dai Crociati che lasciaro-
no la base al suo posto
100
.
94 Una folla di cippi indicava a Taranto le case di coloro che erano stati colpiti dalla folgore per un sacrilegio:
questo Zeus vendicatore era detto Kataibàtes, in quanto discendeva con la saetta nella profondità della terra
e si collegava agli dei inferi. Per il colosso di Taranto, sono le città della lega italiota ad aver salvato persuasive
attestazionideldio:aMetaponto,nell’areadelteatro,tra letavolettevotive interracottadiunbancodivendita,
si è rinvenuta la parte superiore di uno Zeus che brandisce con la destra la folgore, mentre con la sinistra
impugna loscettro;alladestradeldiosiscorge l’aquilaposatasudiunsostegno,oraperduto.(23)AdEraclea
il tipo è noto da una matrice, custodita al museo di Policoro. Anche questa è spezzata, ma conserva una parte
del supporto dell’aquila, che appare scanalato a guisa di colonna provvista di abaco, sormontato a sua volta
da due volute simili a pulvini.
95 Secondo il piede romano, un cubito (pari a un piede e mezzo) è m 0,444, per cui l’altezza dello Zeus
sarebbe stata m17,76.
96 Nel caso specifico, con la parziale discesa sulla fronte, ben si collegava alla componente ctonia del culto.
La divinità del Kairòs, era la personificazione del momento propizio ed irripetibile, l’
“Occasione”
; il
Kairòs
era
riprodottoancheadOlimpia,dove ilcultodelladivinitàavevasedeall’ingressodelloStadio.Per larestituzione
dell’archètipo è utile il rilievo al Museo dell’Acropoli di Atene. MORENO, 1987, pp. 125-131.
97 Per approfondire la conoscenza dell
’Eraclemeditante
,
si consiglia: MORENO, 1987, pp. 237-257.
98 Strab., VI, 278; Petronio (Sat., 88,5) riferisce che Lisippo sarebbe morto trascurando di cibarsi, proprio
mentre era impegnato nella finitura dell
’
Eracle meditante
,
sua ultima opera.
99 Attraverso tale sistemazione si rinnovava l’originaria collocazione sull’Acropoli di Taranto, dove Annibale
non era potuto entrare quando occupava la
pÒlij
e dove il nume aveva continuato a ricevere onori dal
presidio romano e dagli aristocratici tarantini favorevoli ai Quiriti.
100 Dalle indicazioni degli scrittori medievali, si calcolache fosse nellaproporzione di cinque volte il naturale:
trattandosi di una figura seduta, toccava i cinque metri. La gamba e il braccio sinistro erano distesi, l’altra
gambapiegata, ilgomitopoggiatoalginocchioe ilmentonellamano; ilsedileerarappresentatodaunacesta,
copertadalla leontea.Altempo incui l’Eraclesitrovavanellasuacollocazioneoriginaria,risaleanche latesta in
marmo pario al Museo di Taranto, che conserva l’attacco della mano sotto la barba e il tormentato corrugarsi
del volto, non lontano dal realismo del
Pugile delle Terme
.
Da Alessandria provengono due ornamenti di aghi
crinali in bronzo, che riducono a proporzioni minime il soggetto. Altri monumenti si riferiscono al tempo in
cui l’Eracle era a Roma: risalgono alla prima età imperiale i bronzetti della Bibliothèque Nationale di Malibù
(inv. 559) e della Collezione Santangelo, proveniente dall’agro di Pompei. Al periodo severiano si ascrive
la statuetta in marmo da Ratiaria al Museo di Vidin (Bulgaria), che compendia un corpo muscoloso, tale
da richiamare la complessione dell’Eracle in riposo Farnese-Pitti. Anteriore al trasporto dell’originale a
Costantinopoli è la derivazione come
Giona
sotto la pergola che appare a Roma nella catacomba della Via
Latina. La testimonianza è utile per suggerire attraverso la pittura paleocristiana, un altro possibile tramite
della fortuna di questa iconografia lisippea nell’Occidente medievale e moderno, per il resto determinata
dalle numerose rielaborazioni bizantine come Adamo, Elia, San Giuseppe e San Giovanni Evangelista.