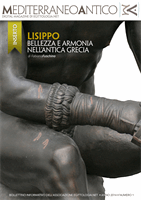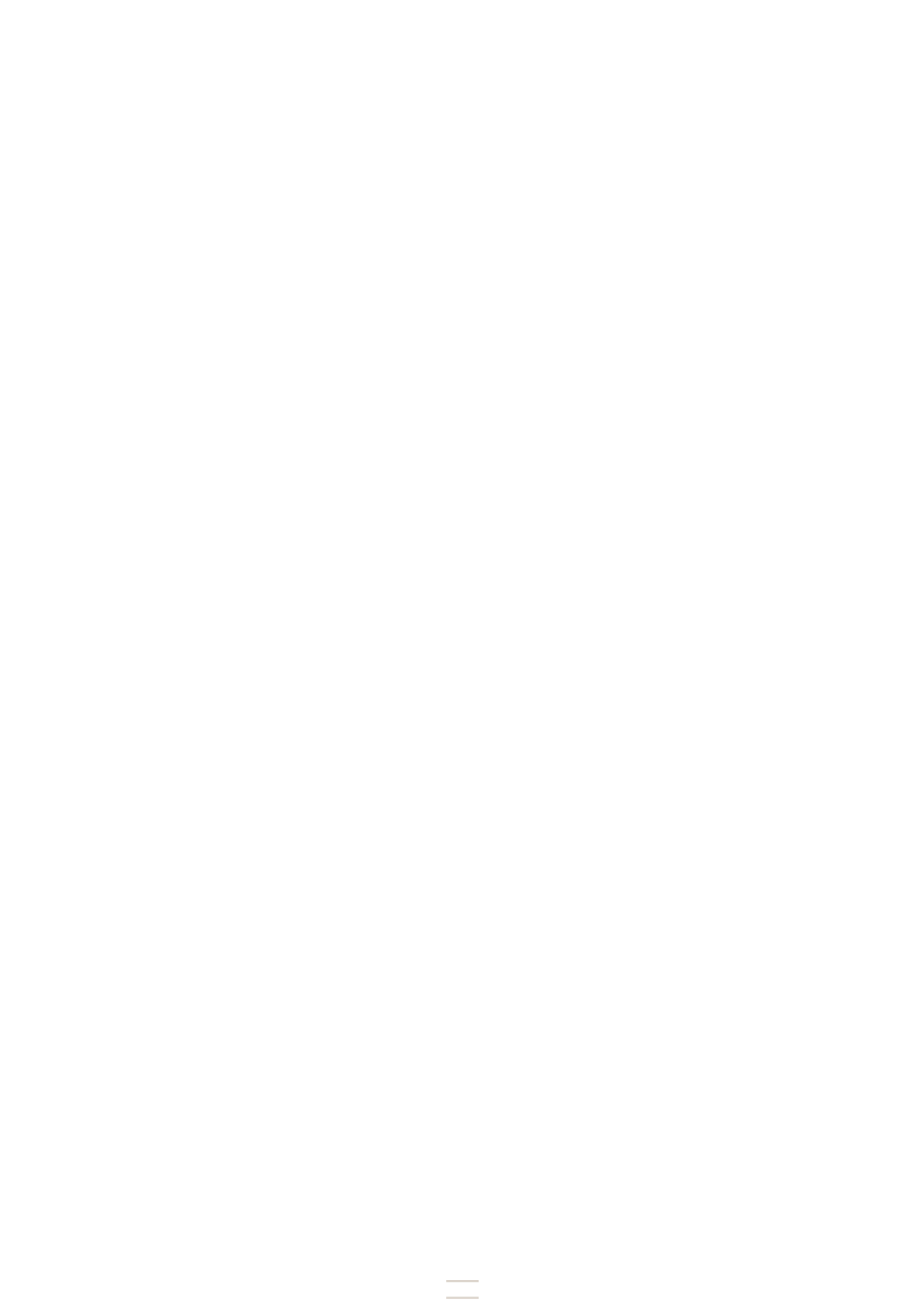
31
corpo stesso. E’ come un nuovo Policleto pervaso
ed edotto da tutto il sistema prospettico o sceno-
grafico dell’opera ellenistica disciplinata da esigen-
ze esclusivamente ottiche. I corpi lisippei sono an-
ch’essi “quadrati”, cioè costruiti su quattro segmenti
e su corrispondenze analogiche di “alti” e di “bassi”,
ma superano, con le loro “aperture”, con gli sfumati
dell’epidermide, con lo sguardo fisso in alto, l’iniziale
povertà degli artisti del V secolo. Infine la testa pic-
cola, come la snellezza del corpo sono esigenze del
gusto ellenistico
104
.
Questa è la somma esegetica del pensiero degli an-
tichi sull’arte di Lisippo, espressa in termini moderni
e ampiamente accolta dagli storici contemporanei i
quali hanno potuto apportarvi quegli accorgimen-
ti che solo una critica maggiormente provveduta
di materiale di raffronto poteva approntare
105
. Va
posta in maggior evidenza, rispetto agli antichi, la
piena conquista della tridimensionalità delle statue
lisippee che non è più da considerare tanto come
una invenzione dovuta a un dato ingegno artistico,
quanto un adattamento funzionale della statua alle
nuove condizioni scenografiche.
In altre parole, mentre prima bastava una visione
unica del corpo umano, giacché trattavasi o di sta-
tue di dèi in funzione sacrale, o di atleti in funzione
agonistica, con l’avvento del IV sec., con le nuove
leggi ottiche che prevedevano la visione da ogni
parte, la terza dimensione si profonda da sé. Inoltre
è da porre in risalto la grande innovazione delle sta-
tue lisippee per quanto riguarda la ponderazione
del corpo: questa presenta una gamba di carico e
una di quiete, ma il peso è più equamente compen-
sato e distribuito su ambedue, di quel che fosse in
Policleto.
L’Apoxyòmenos e l’Agias, dunque, possono conside-
rarsi come i “monumenti chiave” dell’arte lisippea.
In entrambe le opere, alle già ricordate caratteri-
stiche fisiche (muscolatura, snellezza, proporzione,
capigliatura, ponderazione), si aggiungono situazio-
ni psicologiche proprie della prima epoca ellenistica.
Il cerebralismo e il razionalismo si compiacciono di
far avvertire potenzialmente una situazione preclu-
dendone l’attuazione, considerata probabilmente
troppo ovvia, troppo volgare, troppo “policletea”, o
“mironiana”, tanto da portare a considerare Mirone
e Policleto “attimisti in atto” e Lisippo “attimista po-
tenziale”, un “attimista interrotto”.
104 Il nuovo canone introdotto da Lisippo è stato trasmesso anche da Vitruvio (III, 1-3).
105 D’altra parte, però, lo storico moderno si trova in una condizione estremamente svantaggiosa: non
possiede alcun originale di L., ma soltanto probabili copie.