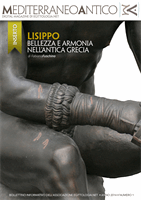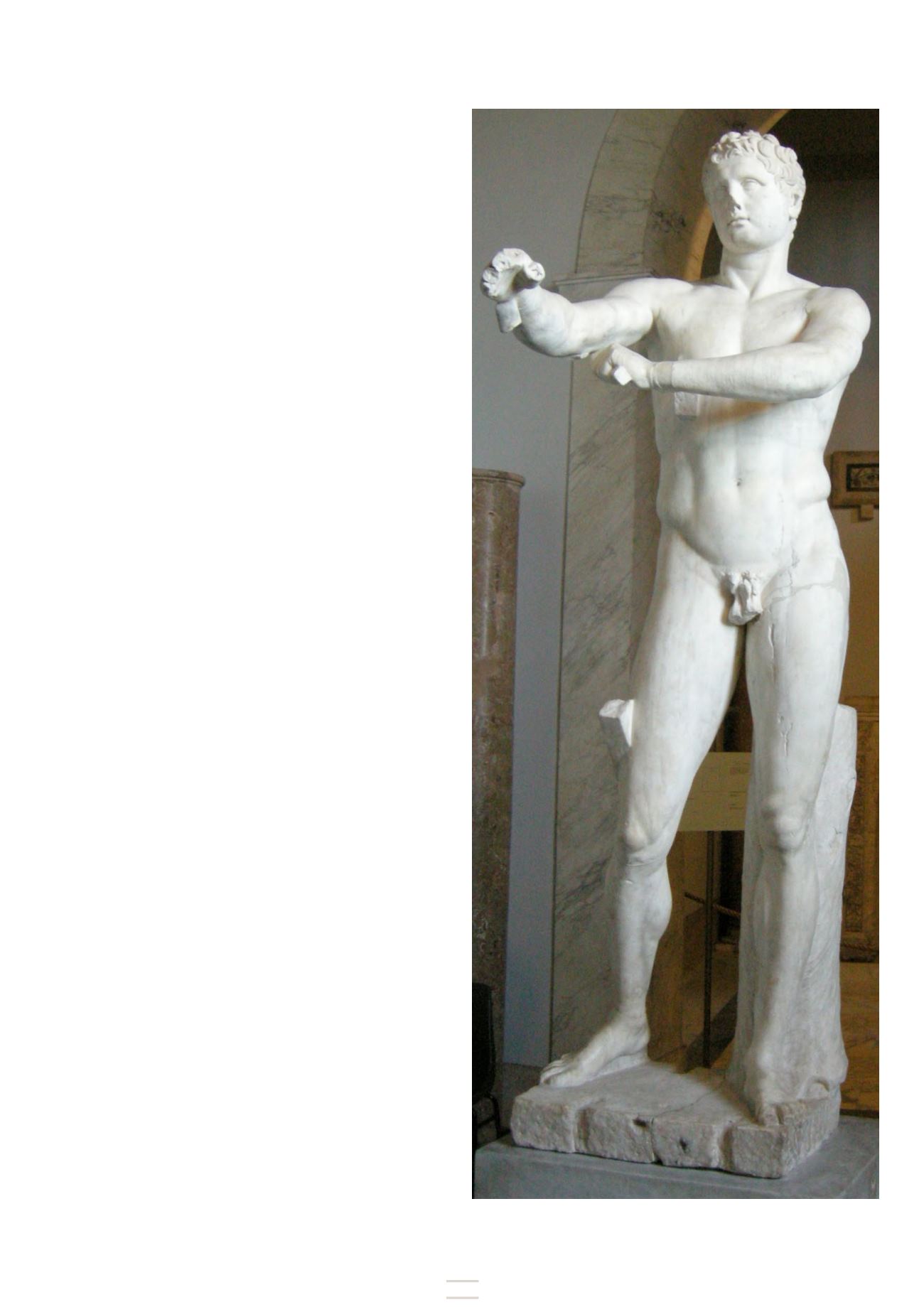
29
LA TEORIA ARTISTICA
Fondamentale per com-
prendere lo stile di Lisippo è stato il giudizio espres-
so da
Plinio il Vecchioche racchiude molto dell’o-
pinione di cui esso godeva nel mondo antico ed è
ancora oggi in massima parte valido, consentendo
di comprendere come Lisippo con la sua arte fosse
riuscito a superare il
canone policleteo, introducen-
do in scultura quegli accorgimenti prospettici che
già venivano usati in architettura
101
. Confermando
l’attenzione posta sul dato esegetico, è da notare
come Quintiliano lodasse la veritas di Lisippo, Plinio
la constantia e l’elegantia delle sue opere
102
mentre
Properzio chiamasse animosa, cioè “vive”, le sue
figure. La traduzione e l’esegesi di questi termini
tecnici antichi in concetti moderni, dimostra che la
sensibilità critica dei Greci aveva ben colto l’essenza
dell’arte lisippea. La constantia, concetto che meglio
sarebbe rappresentato dal termine compositio, si ri-
ferisce evidentemente alla costruzione ben propor-
zionata dei corpi lisippei che per questo risultano
anche eleganti, da qui la valutazione di Plinio.
Quanto alla veritas, questa rappresenta la precipua
qualità specifica dell’epoca ellenistica; ben differente
da quella policletea, più ancora, da quella mironiana.
Le argutiae, o minuziosità di particolari somati-
ci, si trovano anche in artisti arcaici e severi, quali
Pythagoras ma le argutiae di Lisippo sono di tutt’al-
tro genere: sono particolari veristici, non esaspera-
zioni di elementi corporei inesistenti o appena ac-
cennati in natura. Inoltre è tipico del tratto lisippeo
il saper presentare i corpi umani come appaiono
all’occhio, è anche questa una perfezione dell’ar-
te già matura. Lisippo, pur costruendo i suoi corpi
secondo una procedura geometrica e matematica
già perfezionata da Policleto, ne ingentilì la rigidità
rimpiccolendo il modulo (nova intactaque ratione)
e lasciando un largo margine a tutta un’altra serie
di quadrationes, che Policleto aveva ignorato, vale a
dire quelle ottico-psicologiche
103
.
Laddove Policleto aveva curato i corpi, Lisippo af-
fronta un concetto umano più complesso prenden-
do in considerazione sia l’elaborazione dell’aspetto
anatomico quanto la visione ottico-filosofica del
101 Plin., Nat. Hist., XXXIV, 65:
“statuariae arti plurimum traditur contulisse capillum exprimendo, capita minora
faciendoquamantiqui,corporagraciliorasiccioraque,perquaeproceritassignorummaiorvideretur.Nonhabet latinum
nomen symmetria, quam diligentissime custodiit, nova intactaque ratione quadratas veterum staturas permutando;
vulgoquedicebatab illis factosqualesessenthomines,asequalesviderenturesse.Propriaehuiusvidenturesseargutiae
operum custoditae in minimis quoque rebus.” (“È fama che Lisippo abbia contribuito molto al progresso dell’arte
statuaria,dandounaparticolareespressioneallacapigliatura, impicciolendo latestarispettoagliantichi,eriproducendo
ilcorpopiùsnelloepiùasciutto;onde lastatuasembrapiùalta.Nonc’èparola latinaperrendere ilgrecosymmetria,che
egli osservò con grandissima diligenza sostituendo un sistema di proporzioni nuovo e mai usato alle statue “quadrate”
degli antichi. E soleva dire comunemente che essi riproducevano gli uomini com’erano, ed egli invece come all’occhio
appaiono essere. Una sua caratteristica è di aver osservato e figurato i particolari e le minuzie anche nelle cose più
piccole”).
102 Plin., Nat. hist., XXXIV, 65
103 Plut., Soph., 236 A.
21 / Apoxyomenos