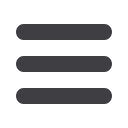
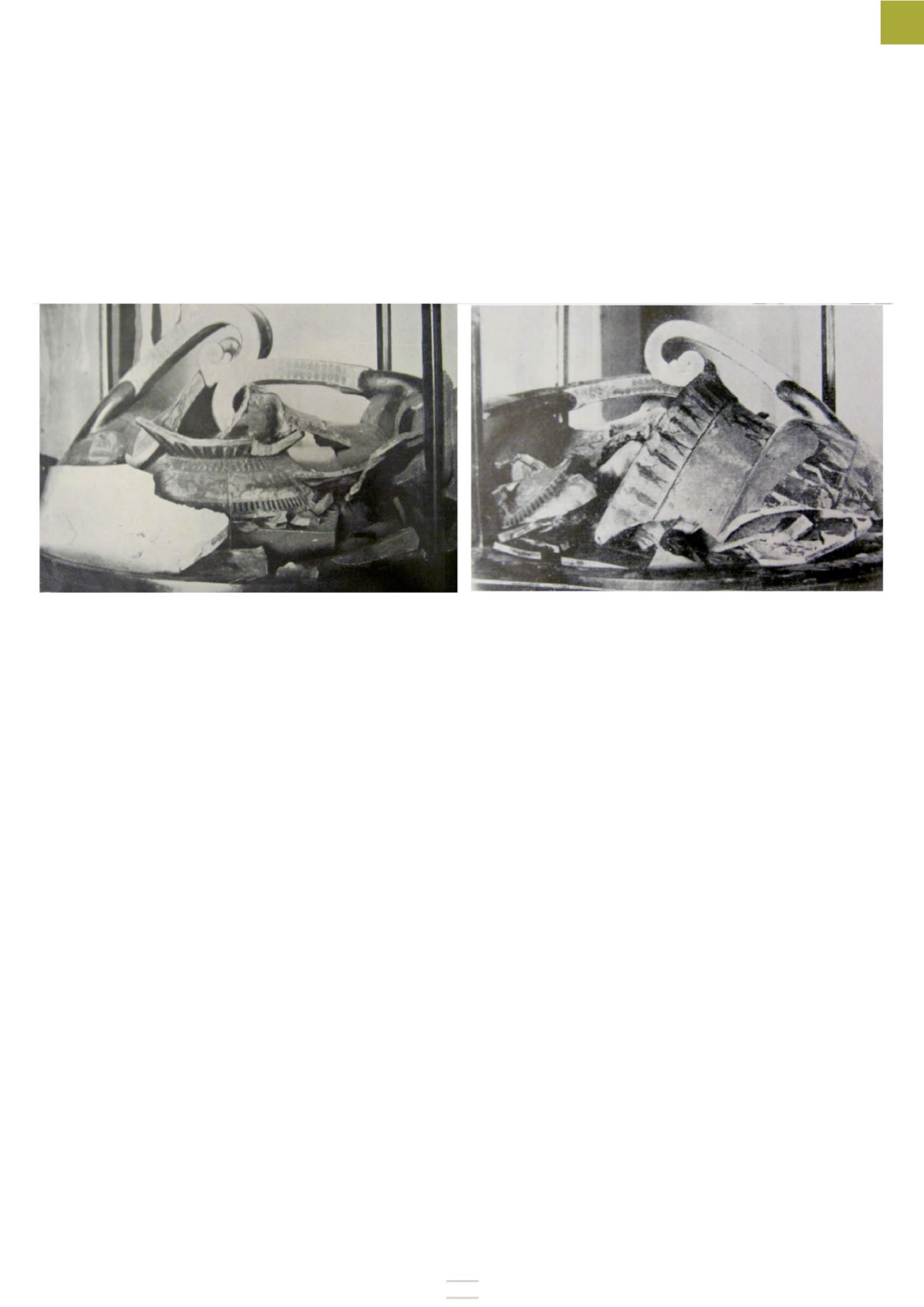
81
Rispetto all’Etruria, in Grecia si aveva un panorama del tutto diverso: infatti, le uniche donne ammesse a pren-
dere parte a tali occasioni erano soltanto etére, ossia accompagnatrici, meretrici, donne di dubbia moralità.
A tale proposito, Teopompo (378 – 320 a.C.), considerato non senza ragione
“omnium maledicentissimus”
tra
gli scrittori greci, accentua e sottolinea questa netta differenza tra le due culture, esasperando la descrizione
della donna etrusca che nelle sue cronache viene ritratta a tinte forti come assidua bevitrice di vino al pari
dell’uomo ed incline ad atteggiamenti molto compromettenti. Al di là di queste evidenti maldicenze, indubbia-
mente scatenate da una sorta di forte ritrosia nel concepire e nell’accettare una figura femminile nettamente
emancipata rispetto alla donna greca, non mancano riferimenti dai toni decisamente più “pacati” in Catullo
(84 – 54 a.C.) che si limita a descrivere l’uomo umbro
“parcus”
e l’uomo etrusco
“obesus”
(Catull., XXXIX, 11:
aut
parcus Umber aut obesus Etruscus
)
1
,
quindi incline ai piaceri della tavola e del bere, con evidente riferimento ai
banchetti e ai simposi. È logico che queste fonti debbano essere soppesate ma se accostate alle testimonian-
ze materiali contribuiscono comunque ad accertare il fatto che da parte dell’aristocrazia etrusca fossero state
recepite ed adottate le pratiche del banchetto e del simposio, occasioni in cui le donne erano ammesse a
prendere parte, in qualità di compagne fedeli e non certo in veste di meretrici. La testimonianza per eccellenza
di quanto appena detto è l’affresco conservatosi sul frontone della camera principale della Tomba della Caccia
e della Pesca di Tarquinia, in cui viene ritratta una coppia coniugale a banchetto sulla stessa
kline
;
i gesti carichi
di affetto e l’abbraccio tenero che unisce l’uomo e la donna lasciano ben pochi dubbi circa l’interpretazione dei
due personaggi come coppia coniugale. Dunque, emerge un quadro molto chiaro e significativo della società
etrusca, come realtà aperta a recepire la cultura greca, riadattandola secondo le proprie forme (foto 2).
Chiusa questa breve ma significativa introduzione, propedeutica a delineare lo sfondo culturale entro cui ci si
muove, adesso concentriamo l’attenzione sulla storia del cratere. Il vaso François fu recuperato in frammenti
tra il 1844 e il 1845 nei territori facenti parte della tenuta di Dolciano in provincia di Siena, all’interno degli
ambienti di una tomba a camera in rovina; deve il nome al suo stesso scopritore, Alessandro François (1796
– 1857), commissario di guerra per conto del Granduca di Toscana, studioso fiorentino, grande erudito ed “ar-
cheologo fortunato” che dedicò la sua vita alla ricerca e allo studio dei manufatti antichi. Tra i grandi meriti che
si devono al giovane si ricorda lo scavo di una tomba localizzata presso la necropoli di Ponte Rotto a Vulci, in
provincia di Viterbo e che, in virtù del grande interesse archeologico ed in onore di una sì spiccata personalità,
prese il suo nome: la tomba François. Era l’autunno del 1857 quando al mondo fu riconsegnata una delle più
preziose testimonianze di pittura parietale etrusca, tutt’oggi considerata fonte preziosissima per la ricostru-
zione storica dell’Etruria alle soglie della conquista romana. Datata a poco dopo la metà del IV sec. a.C., in base
a confronti pertinenti alla struttura architettonica e agli elementi del corredo funebre, conserva preziosissimi
affreschi che decorano le pareti del vestibolo con scene di lotta tra romani ed etruschi e scene di sacrificio di
prigionieri troiani, tra cui figurano
Macstarna,
ossia il corrispettivo etrusco di Servio Tullio, re di Roma, Aiace,
Cassandra, Nestore, Fenice, Eteocle e Polinice, Marce Camitlnas che uccide Cneve Tarkunies, romano ed i
proprietari della tomba Vel Saties e Tanakvil Verati
.
2
Ma quel pizzico di fortuna che accompagnò sempre la sua
1 G. Camporeale 2004, pp. 177 ss.
2 Bianchi Bandinelli – Torelli 1976, tavola 125.
foto 3 / Vaso François in 368 frammenti. 9 settembre 1900. (Foto: archeotoscana.wordpress.com)


















